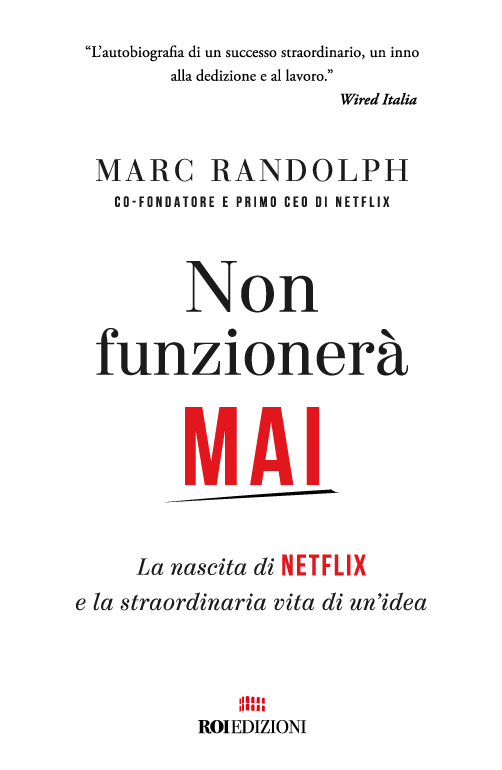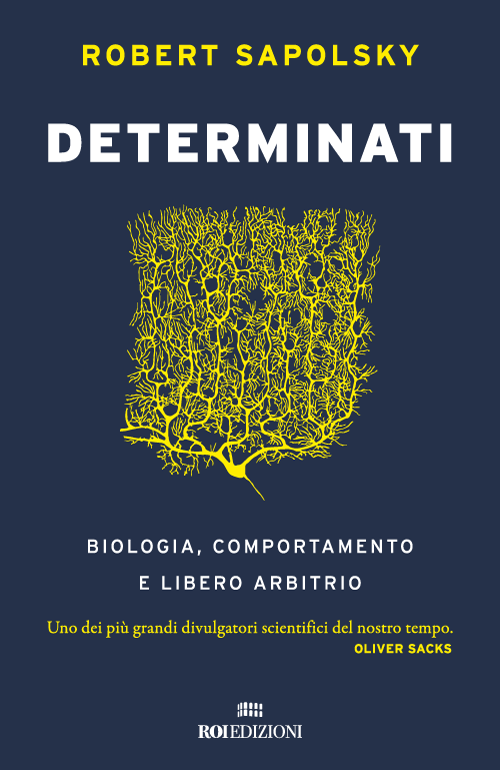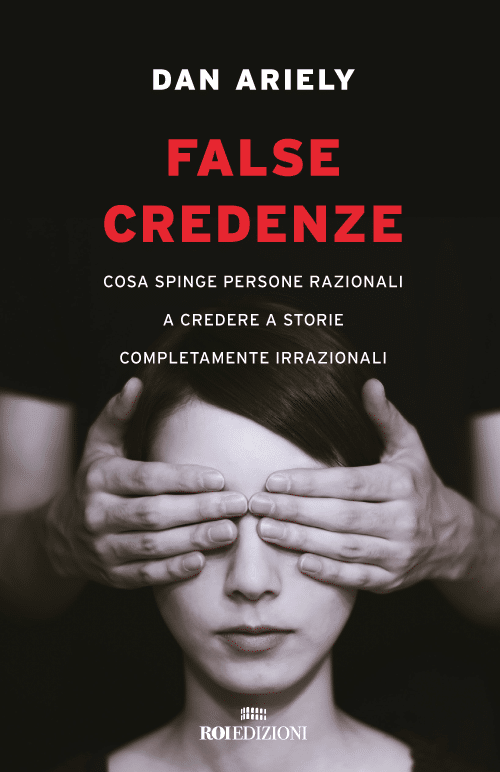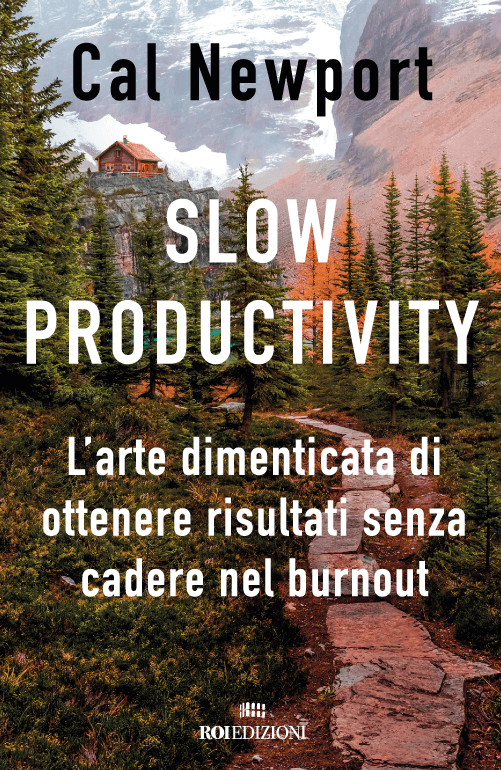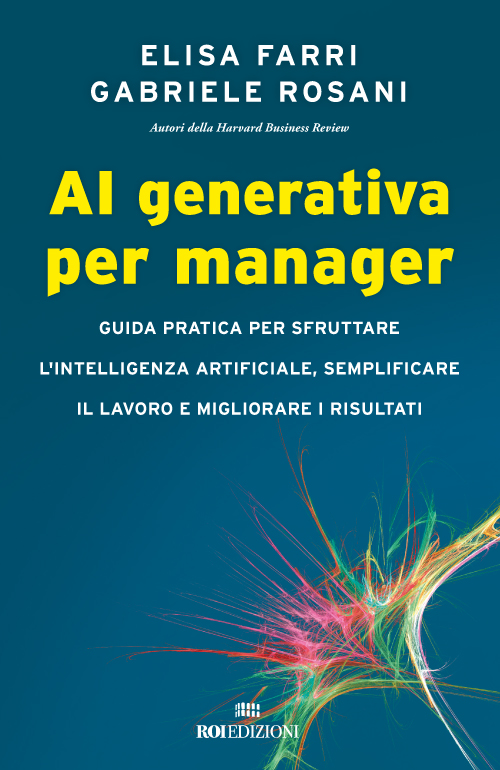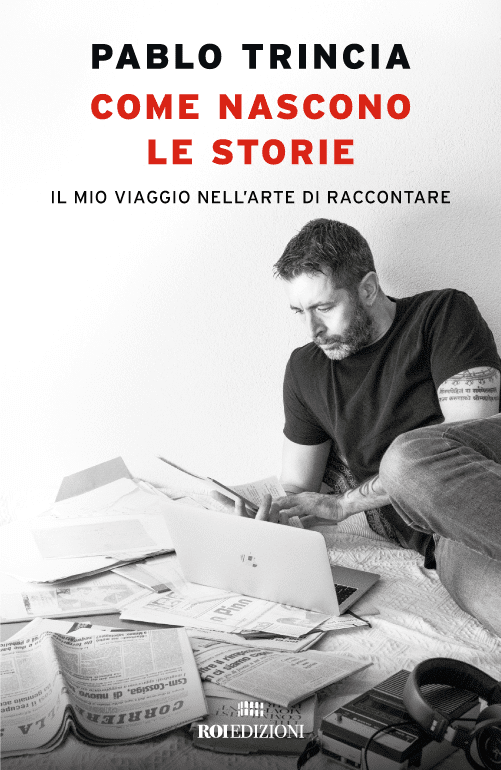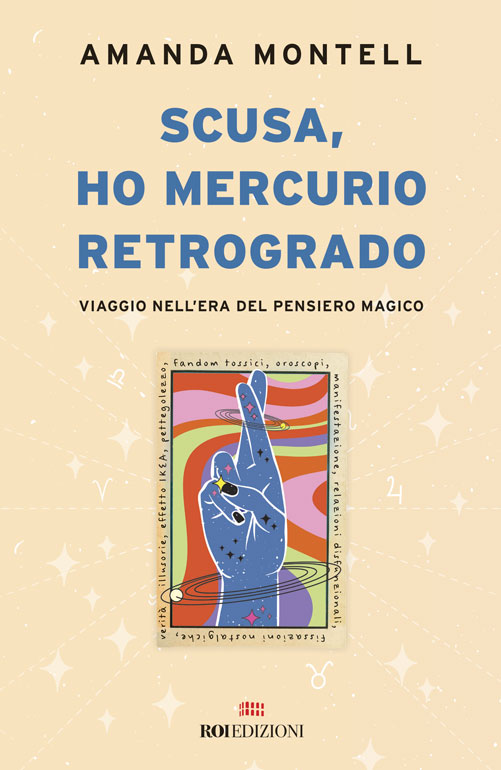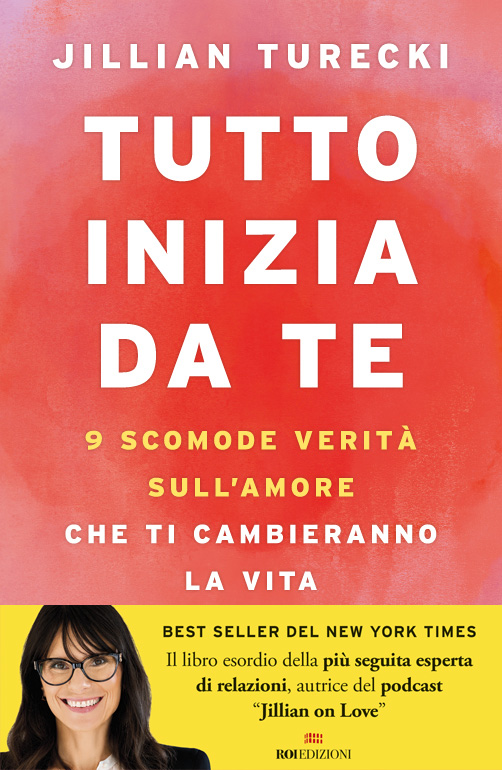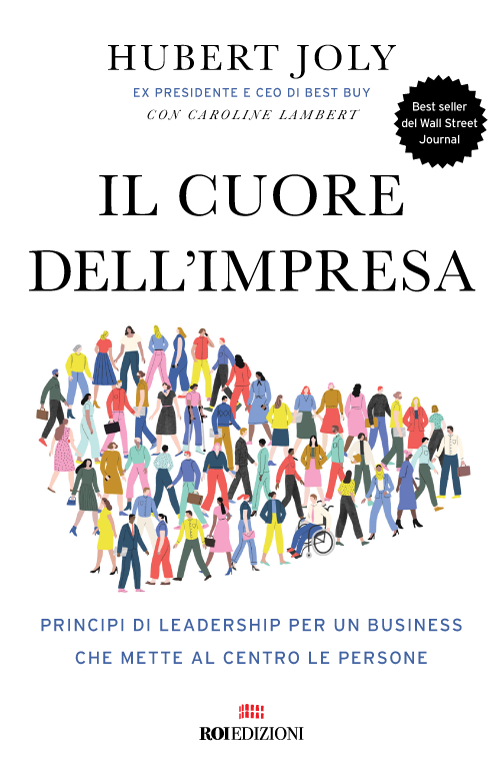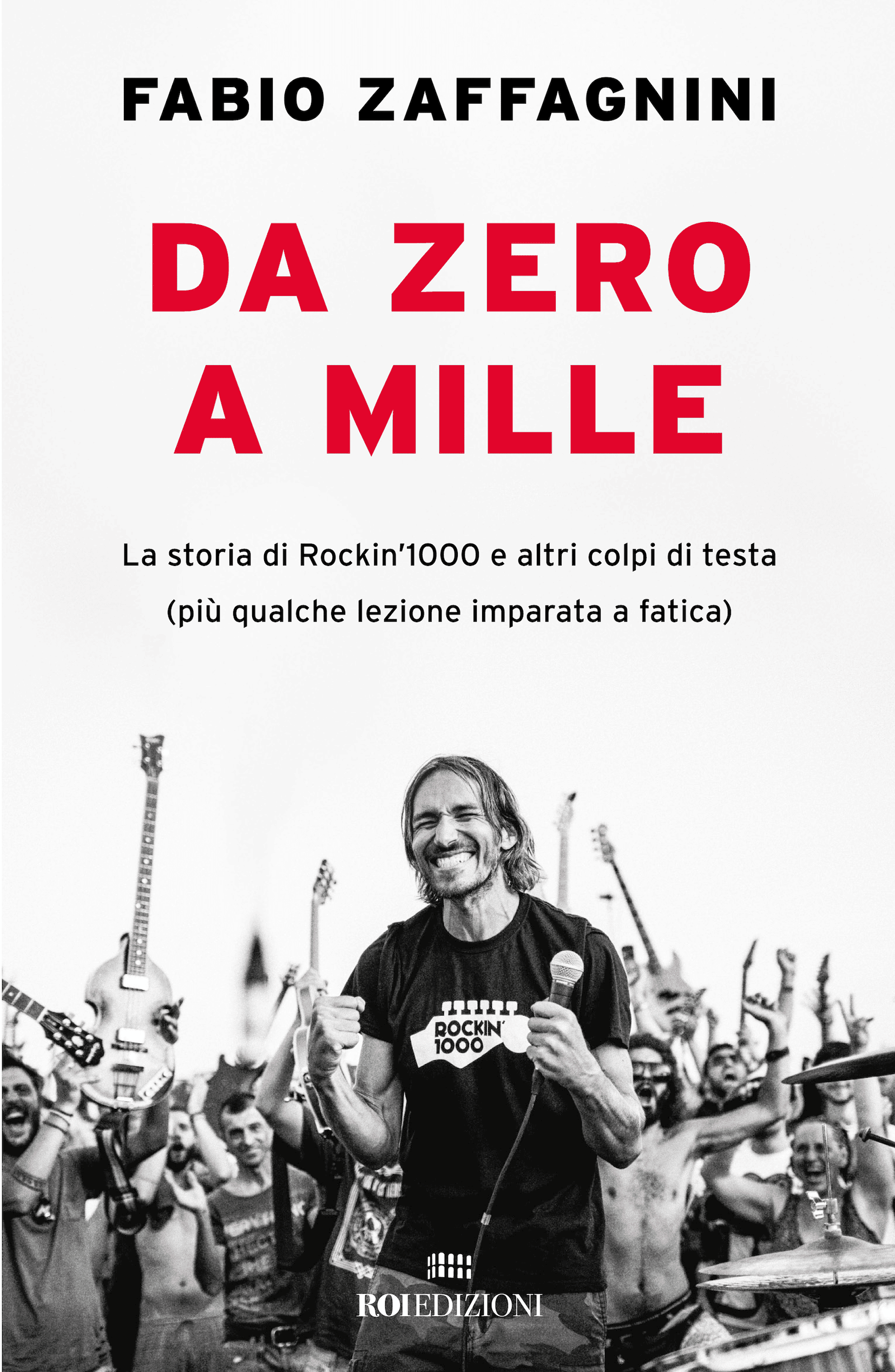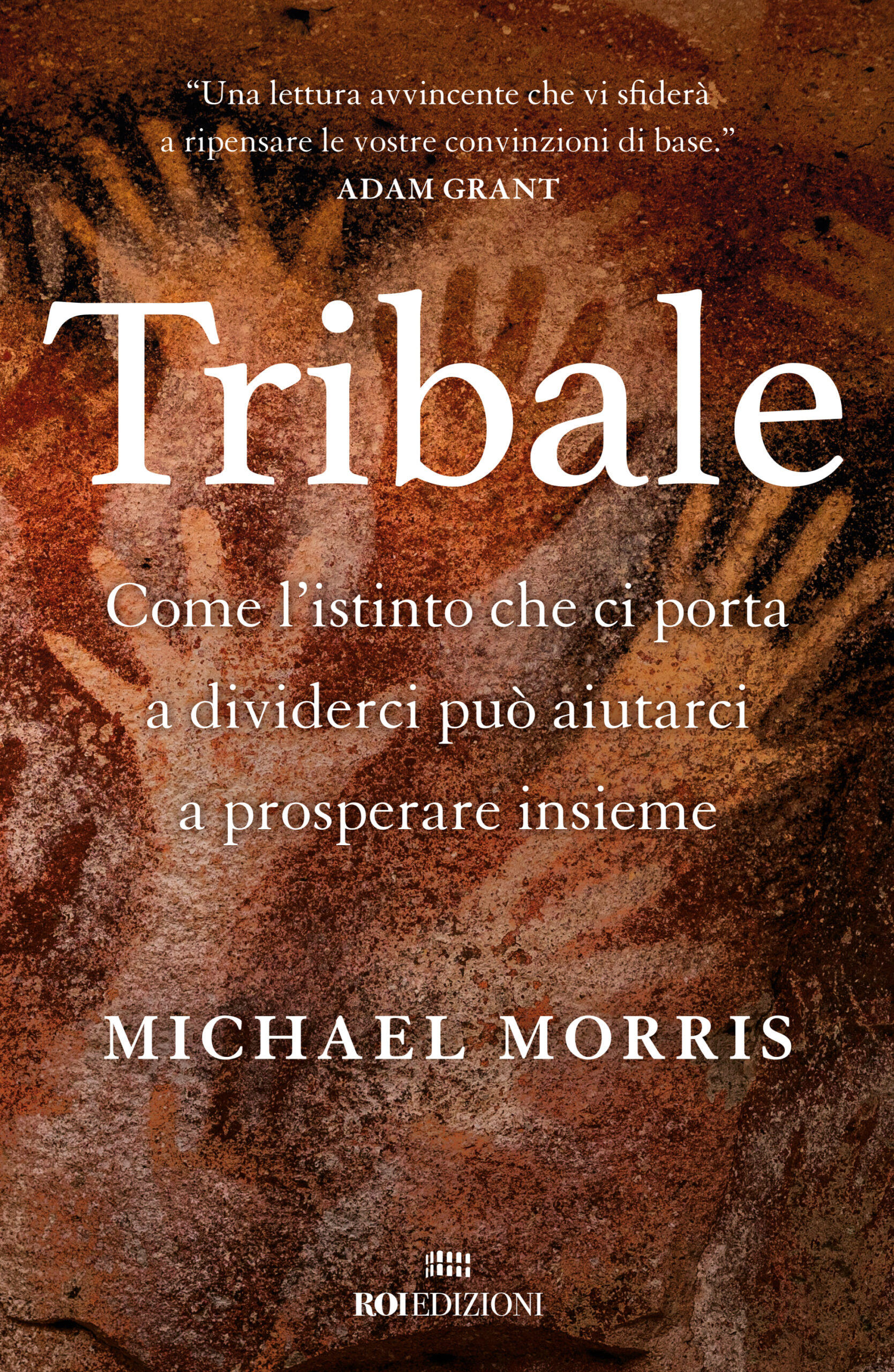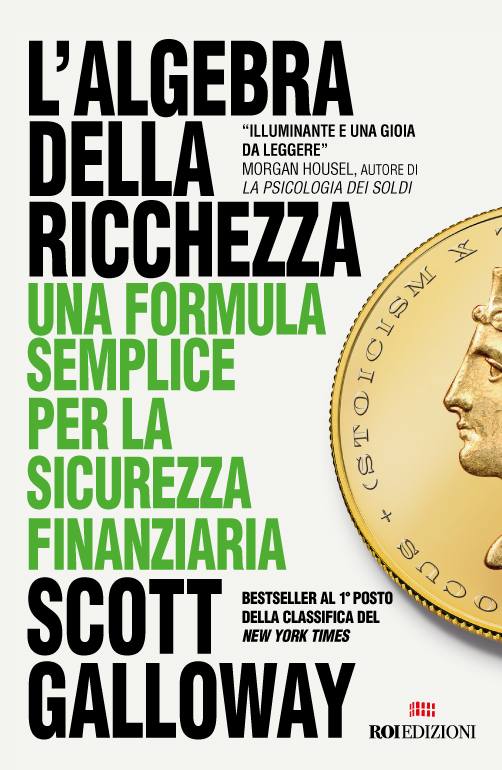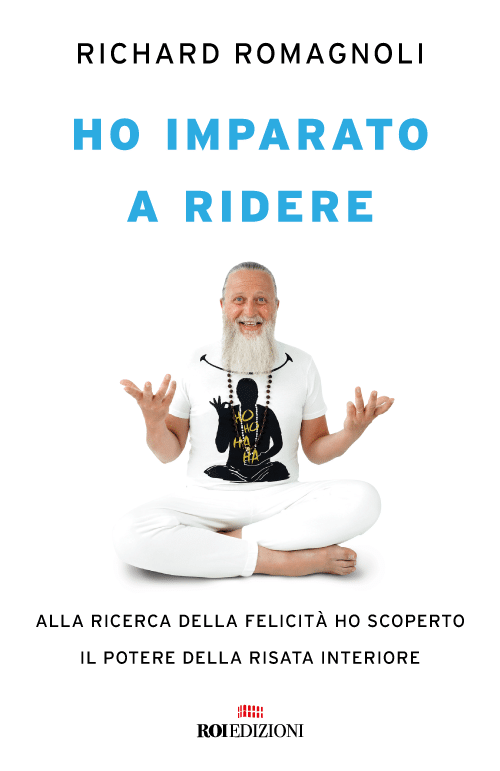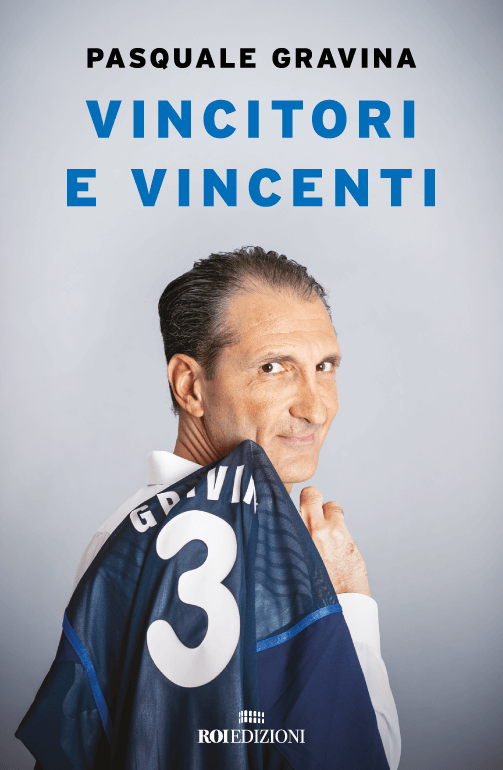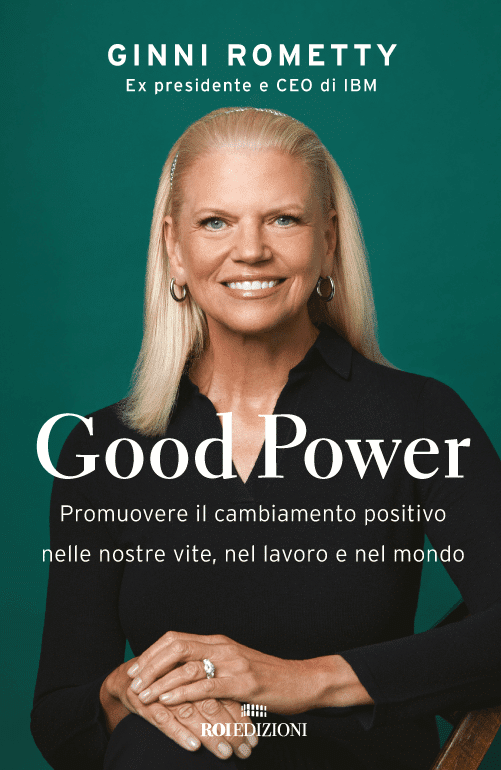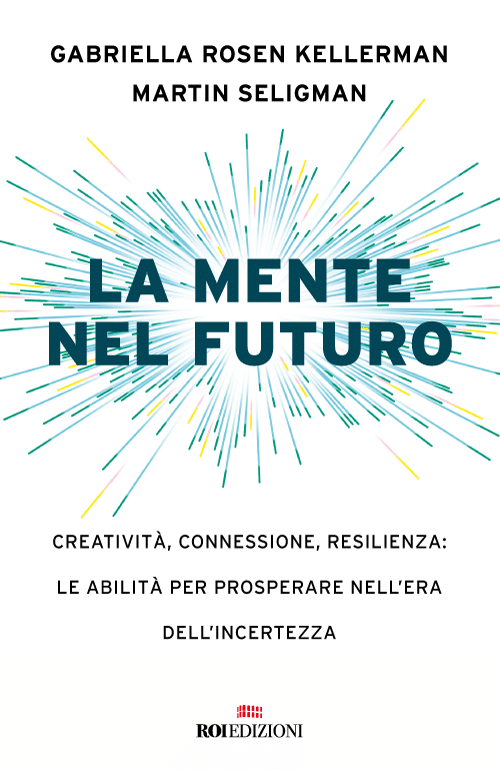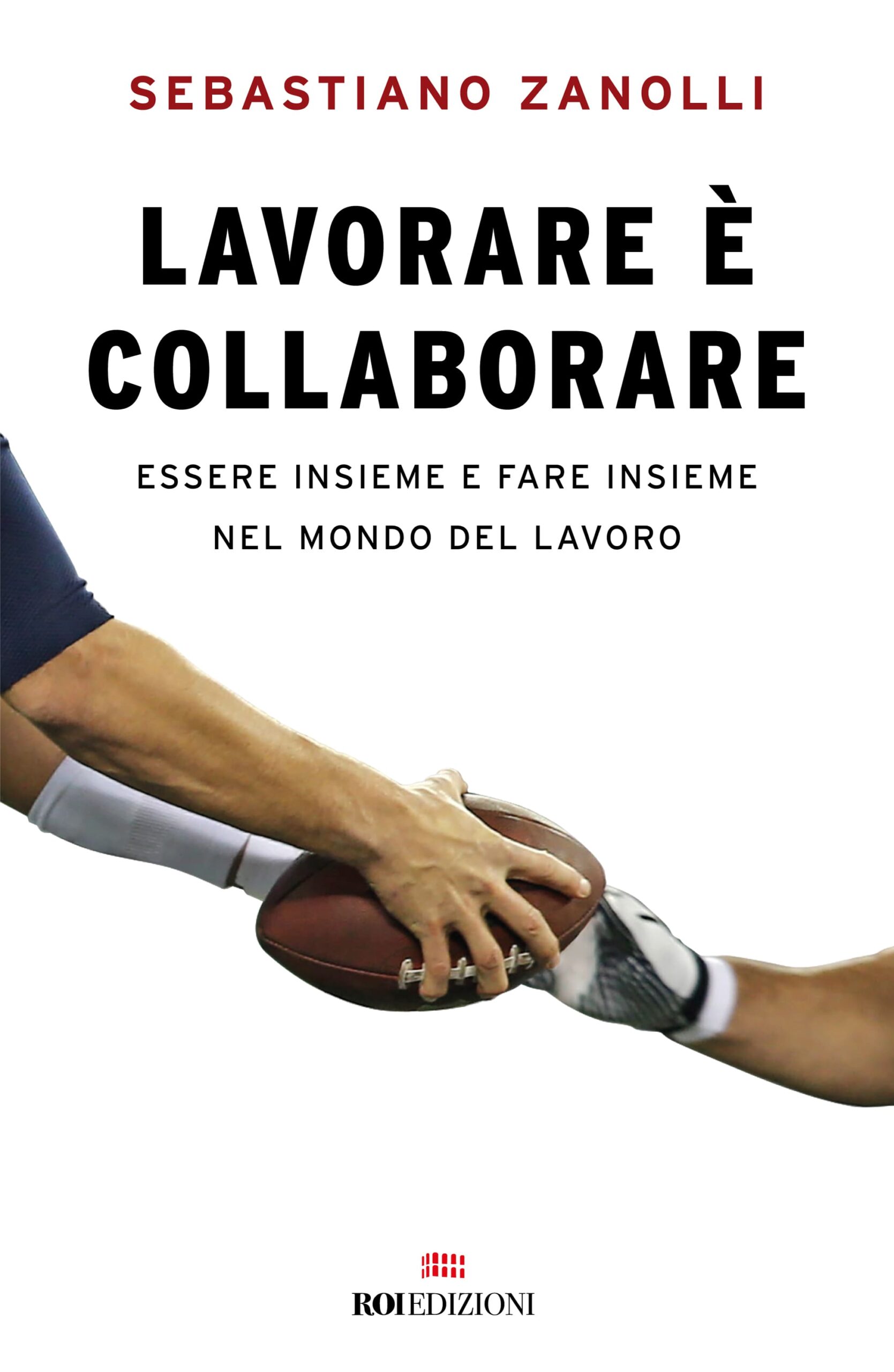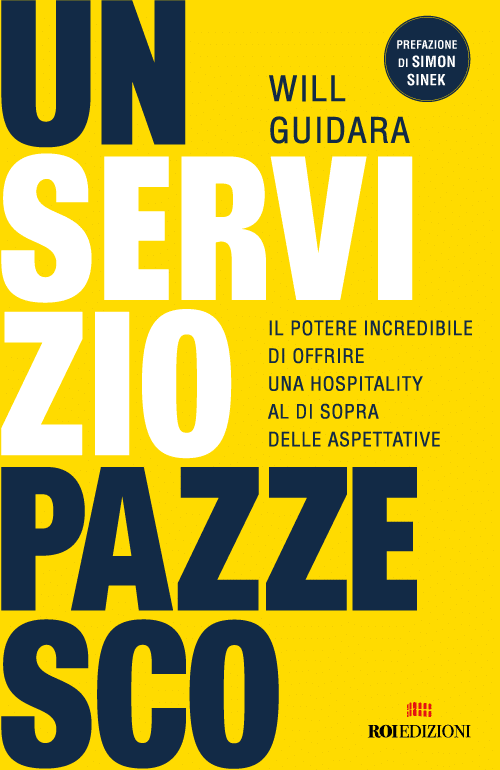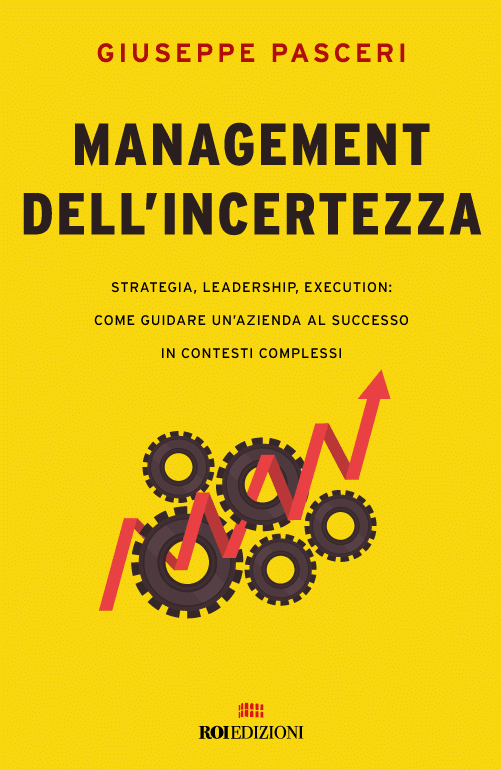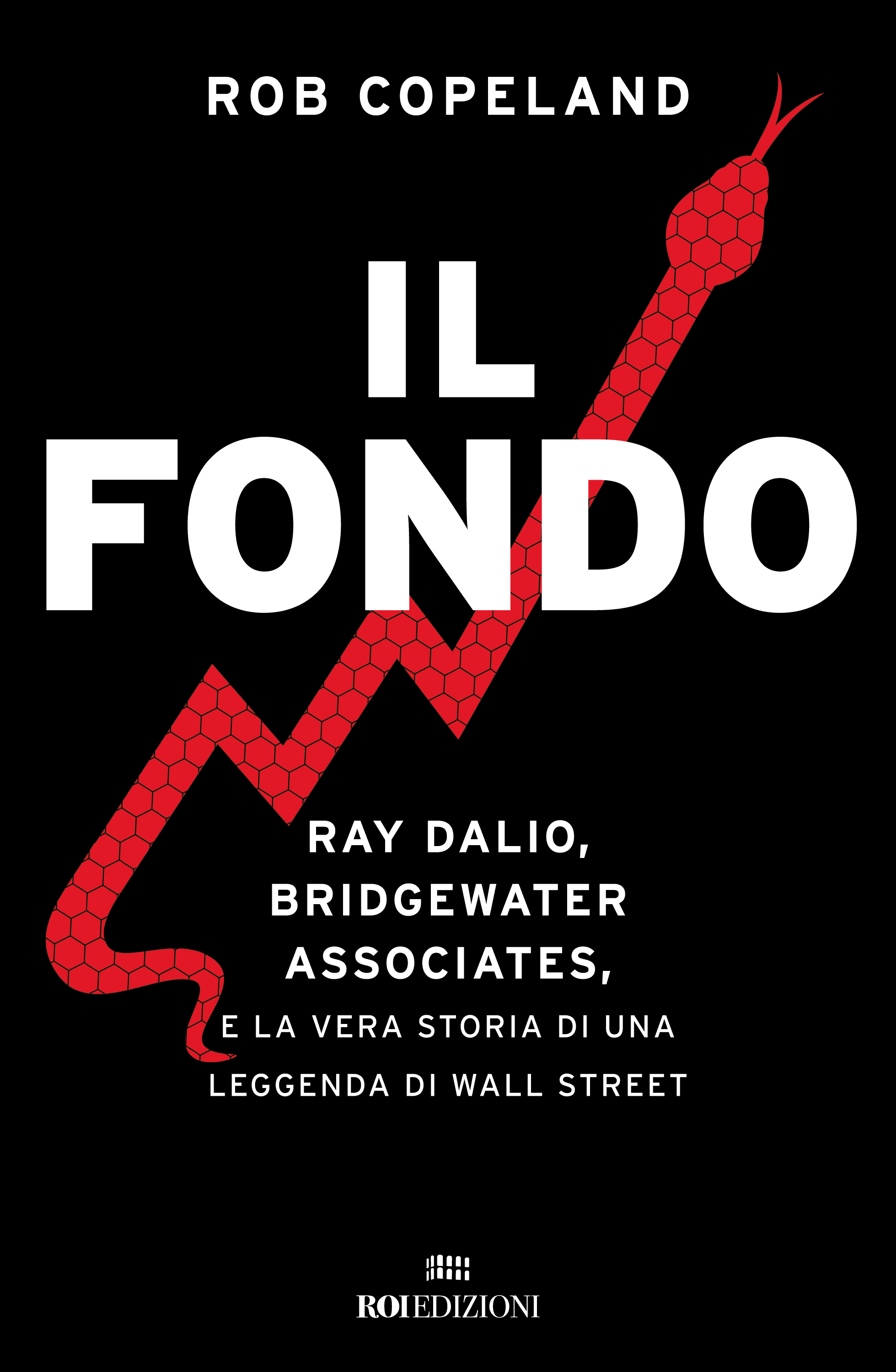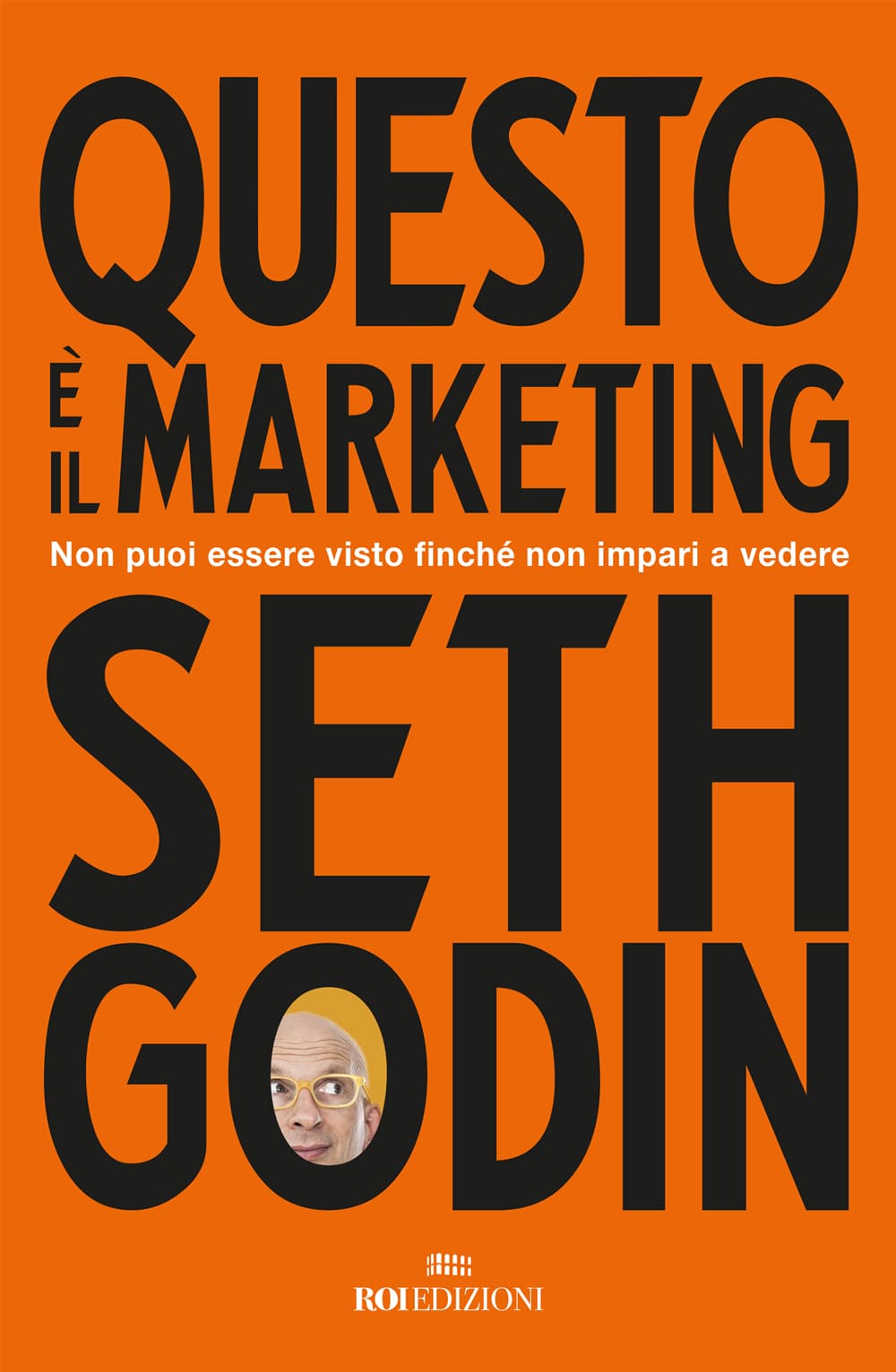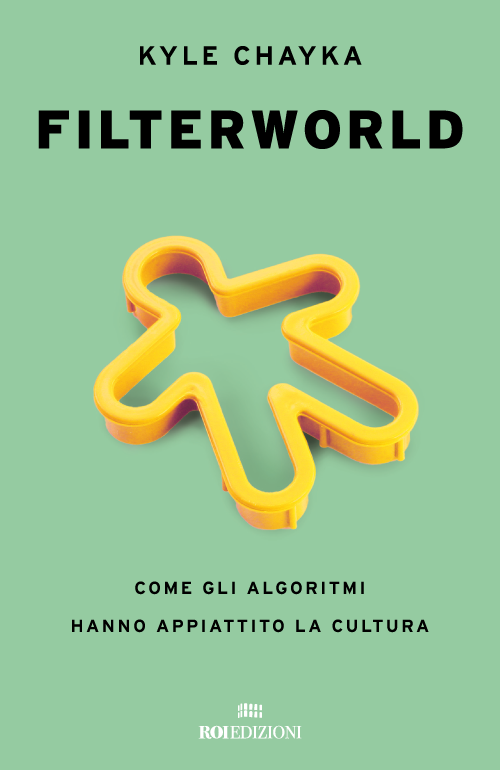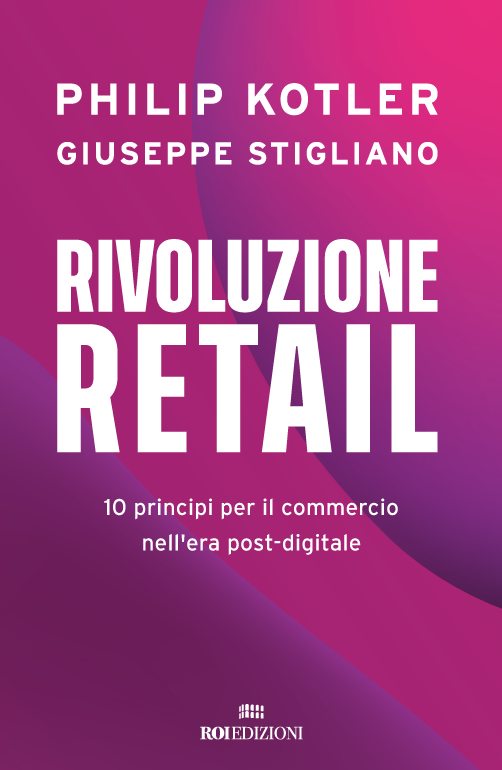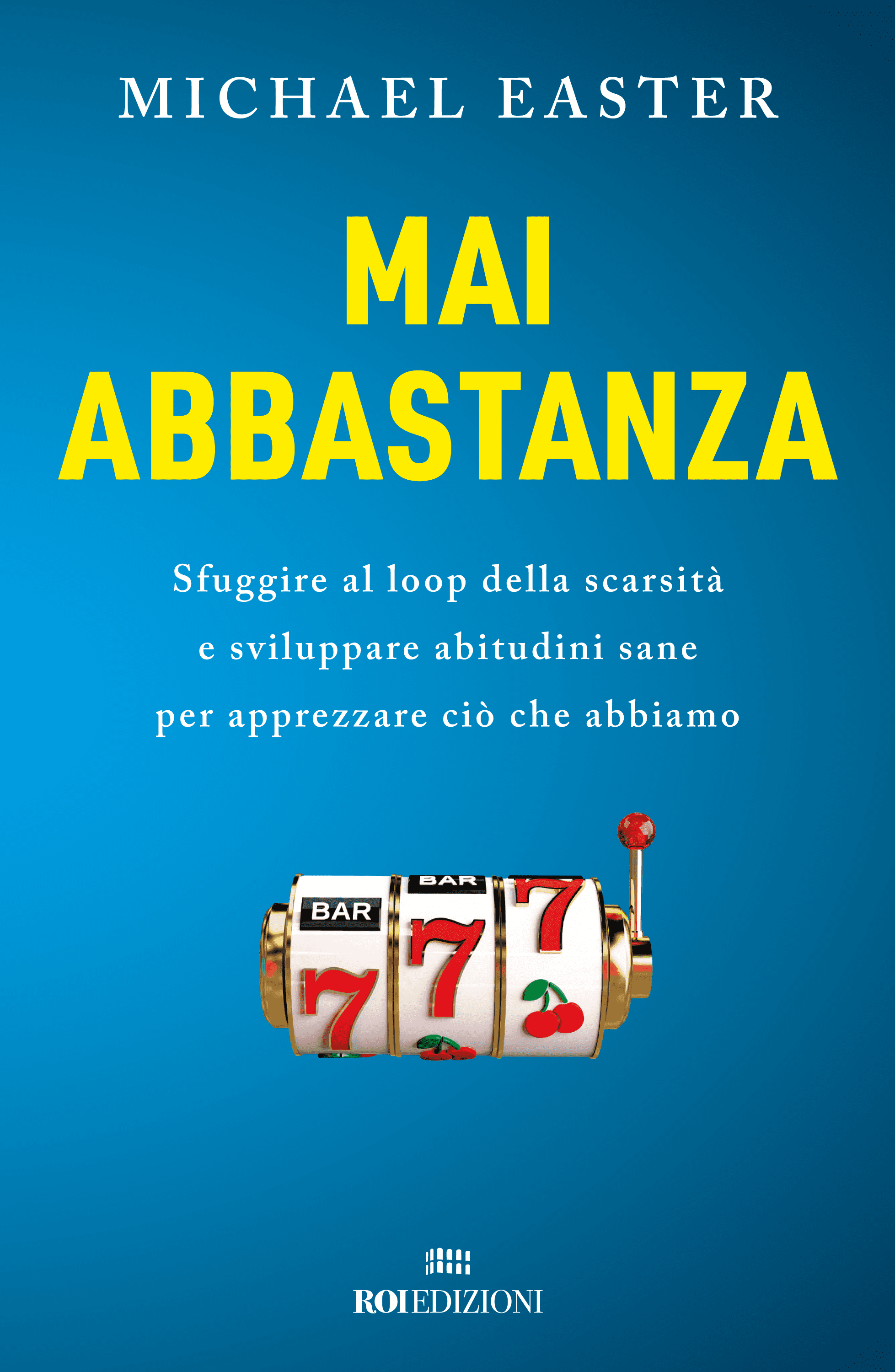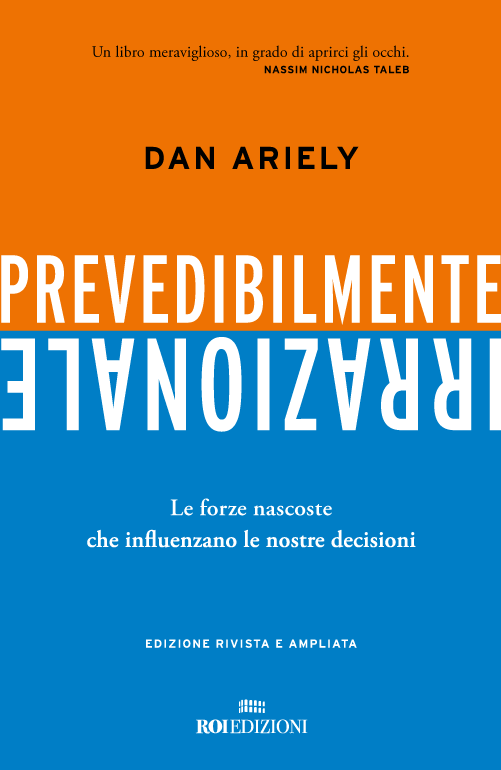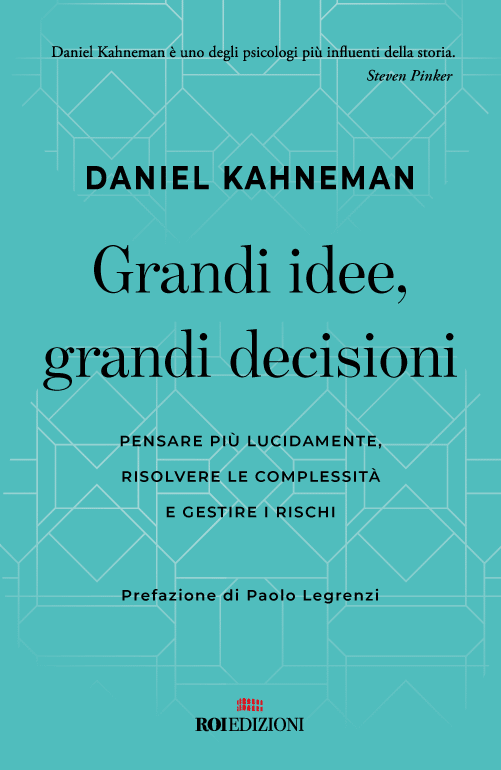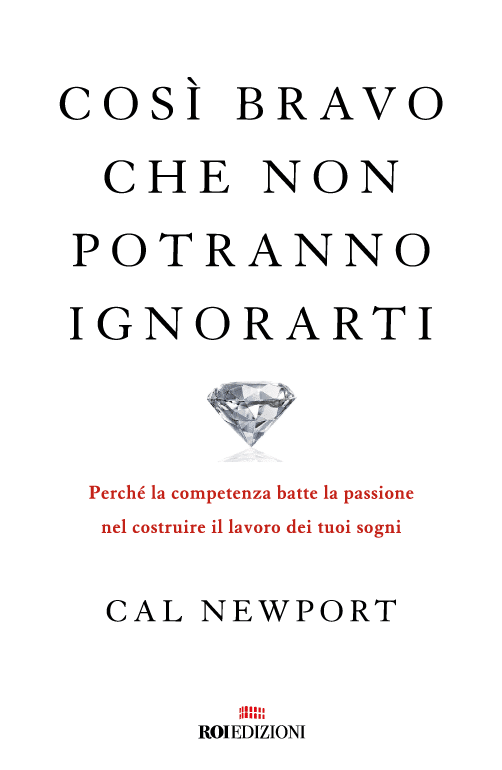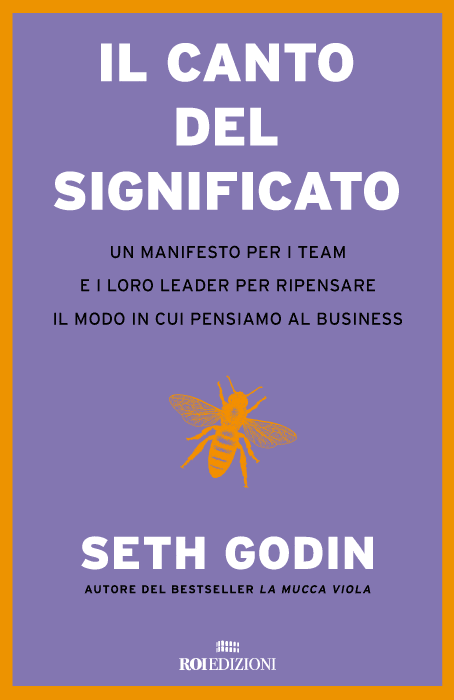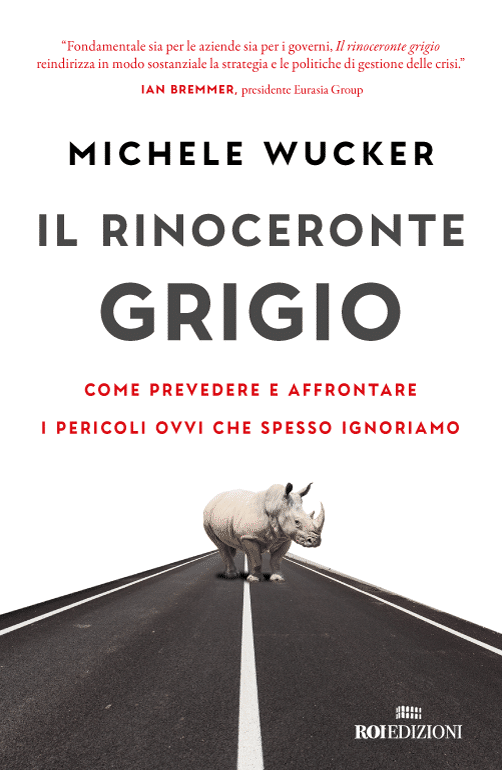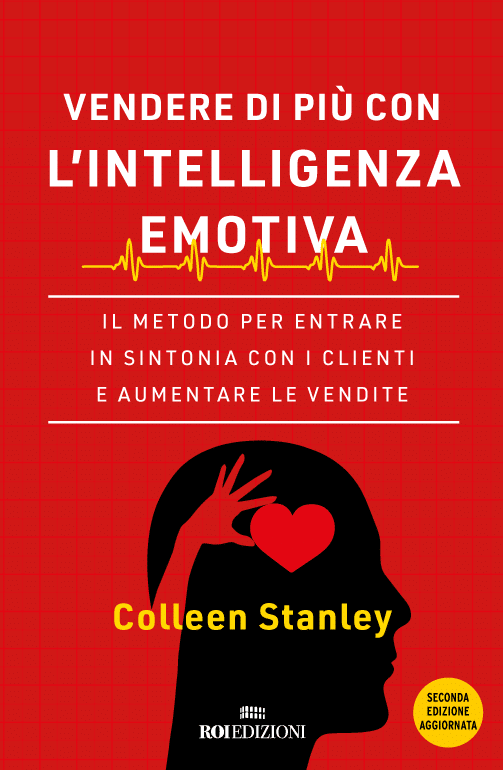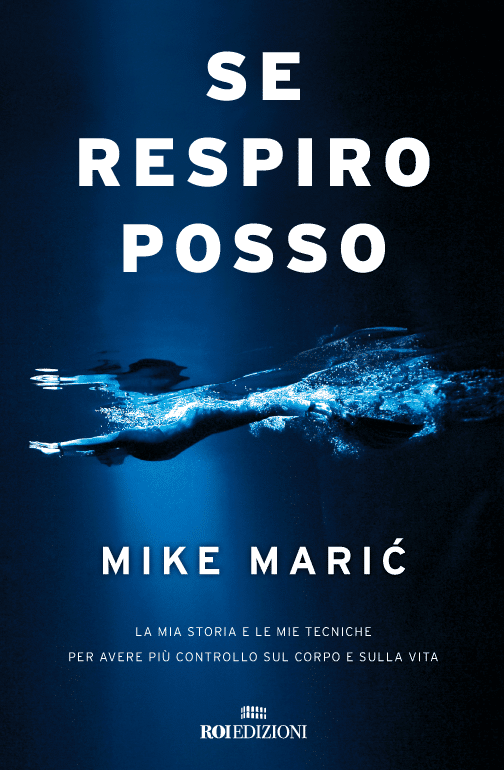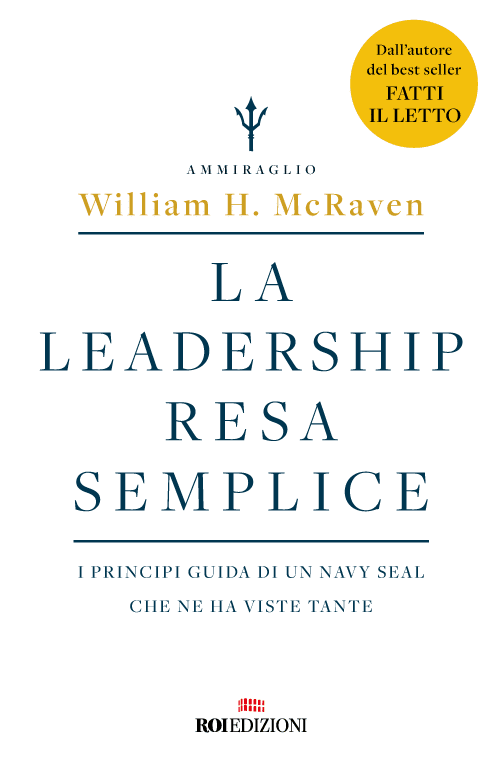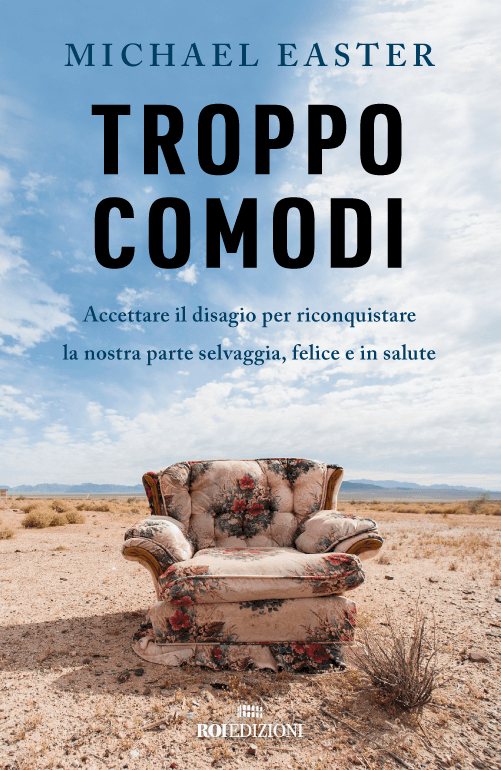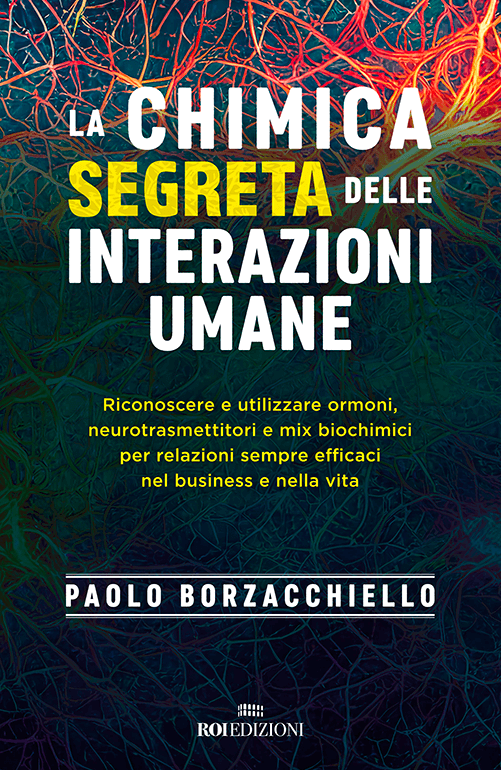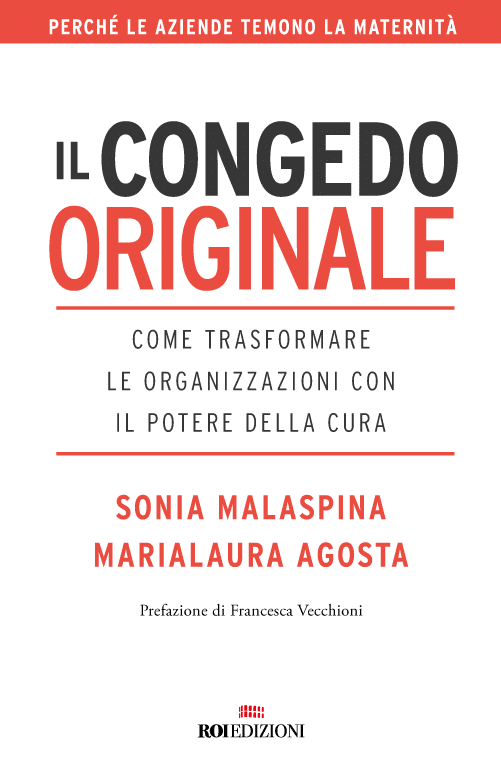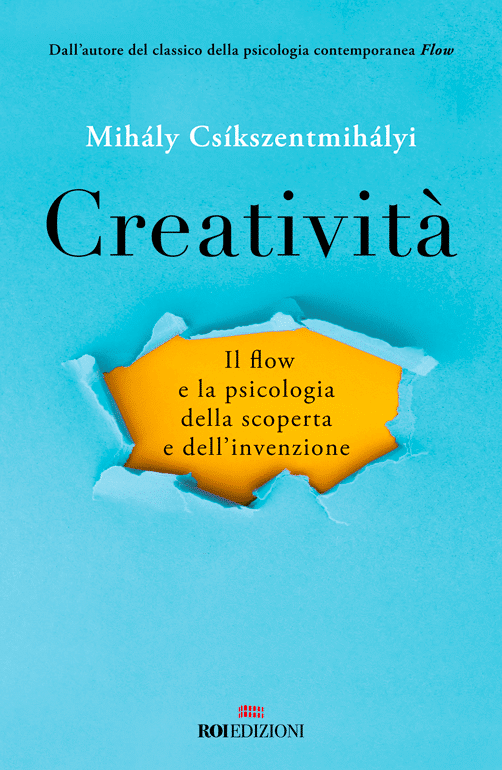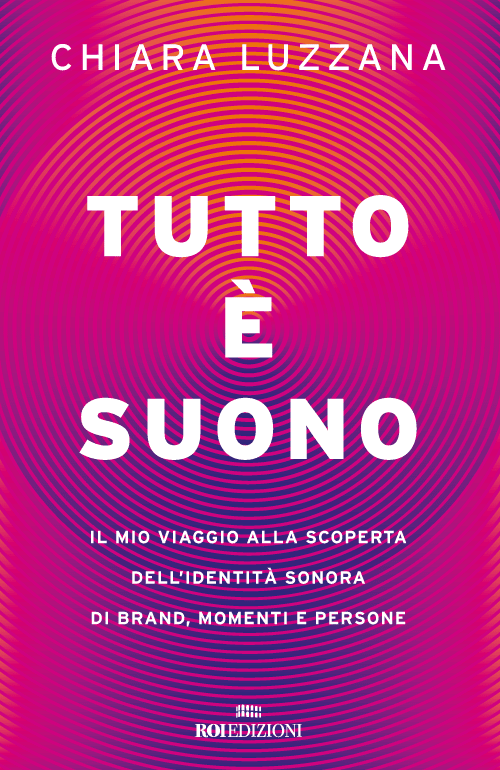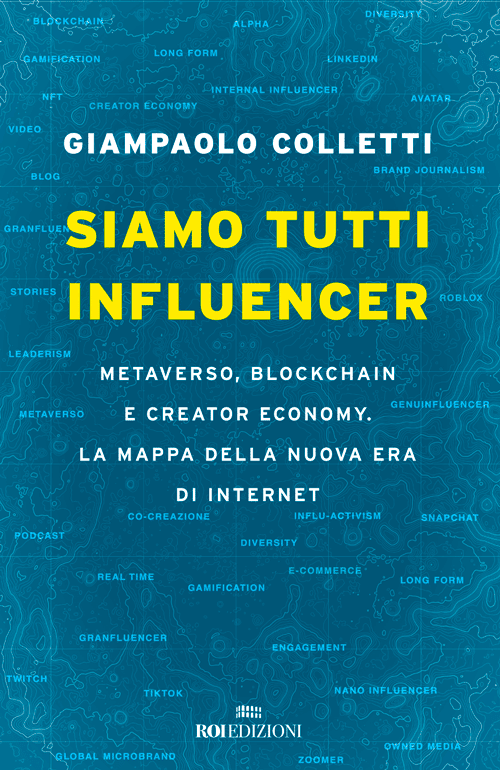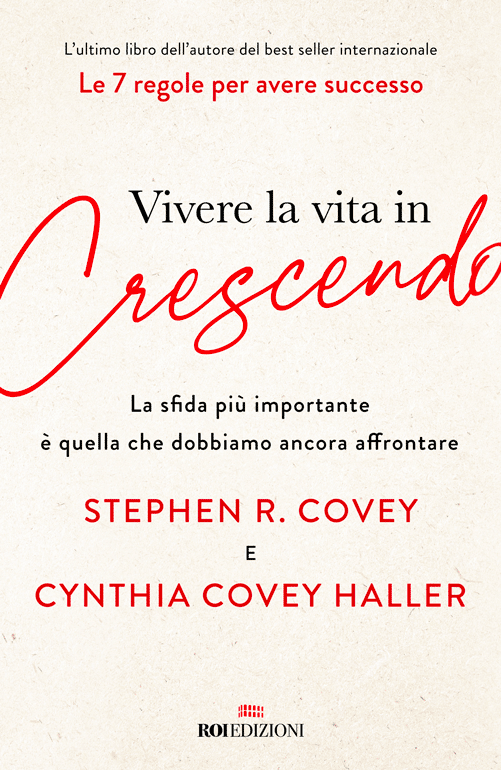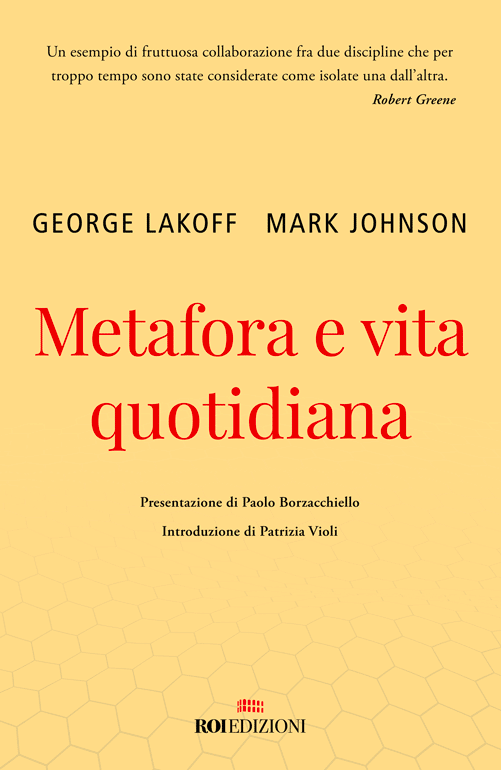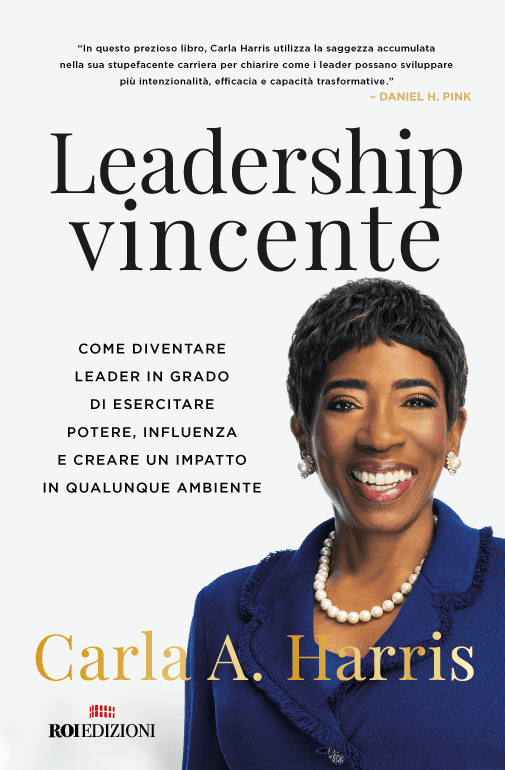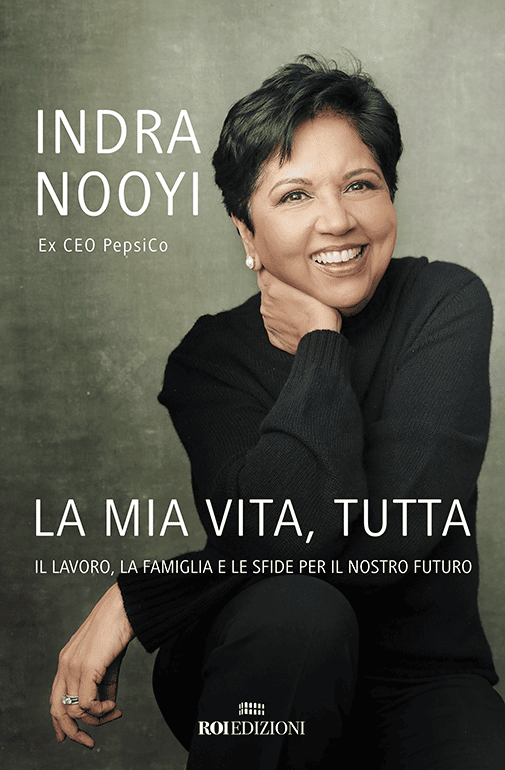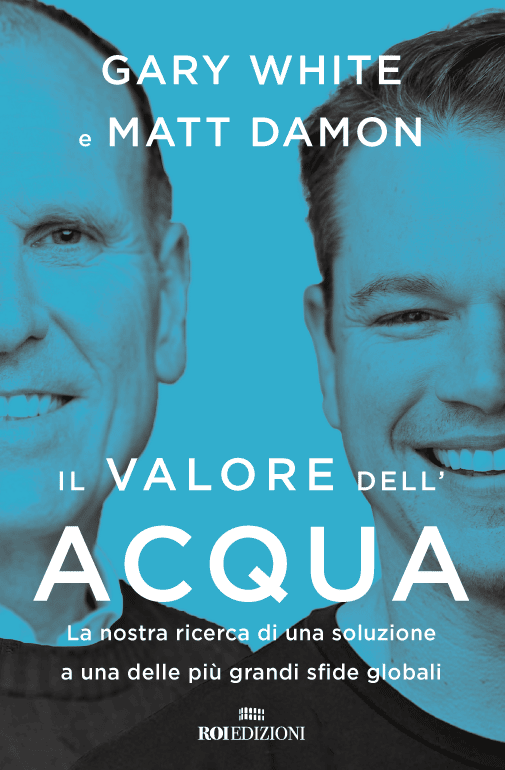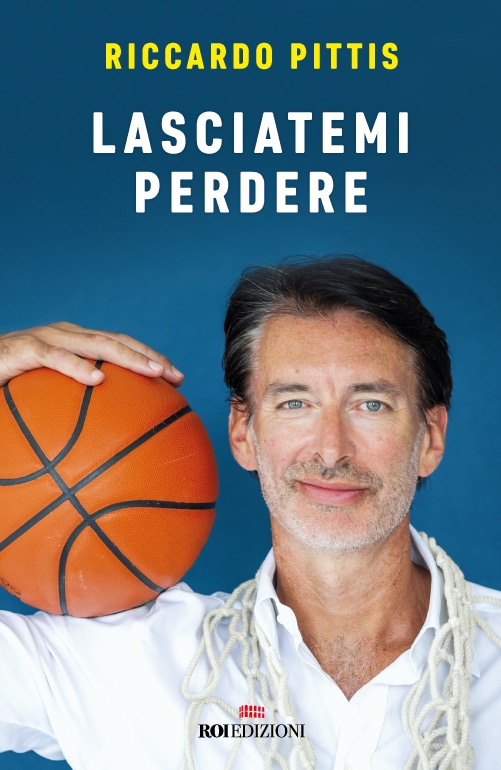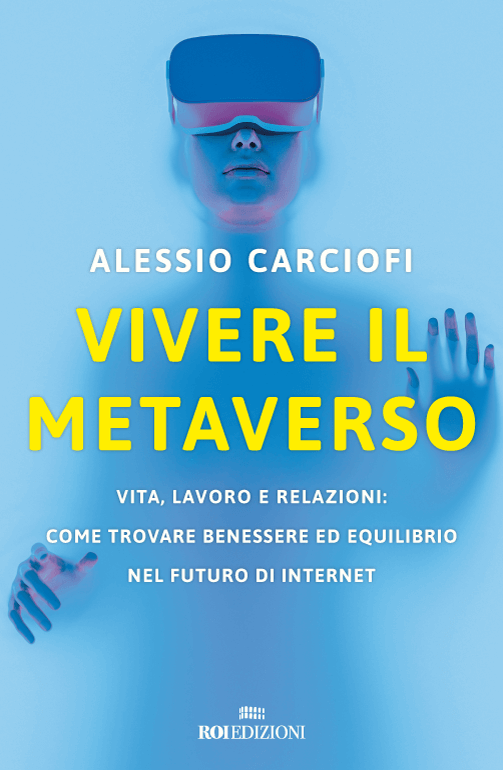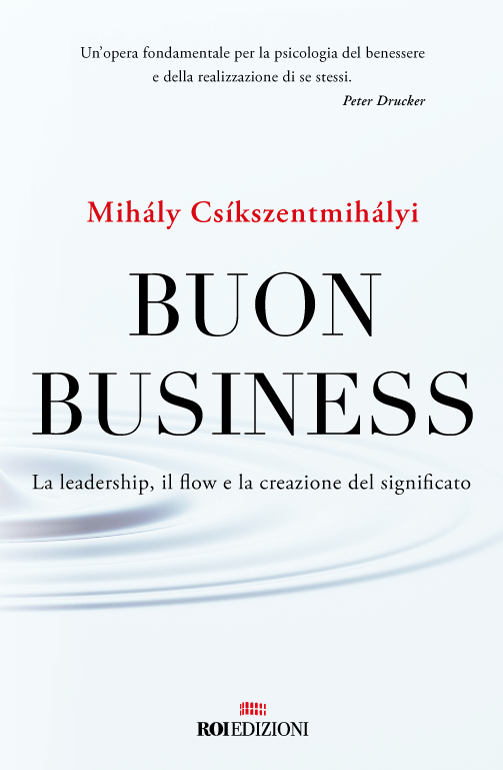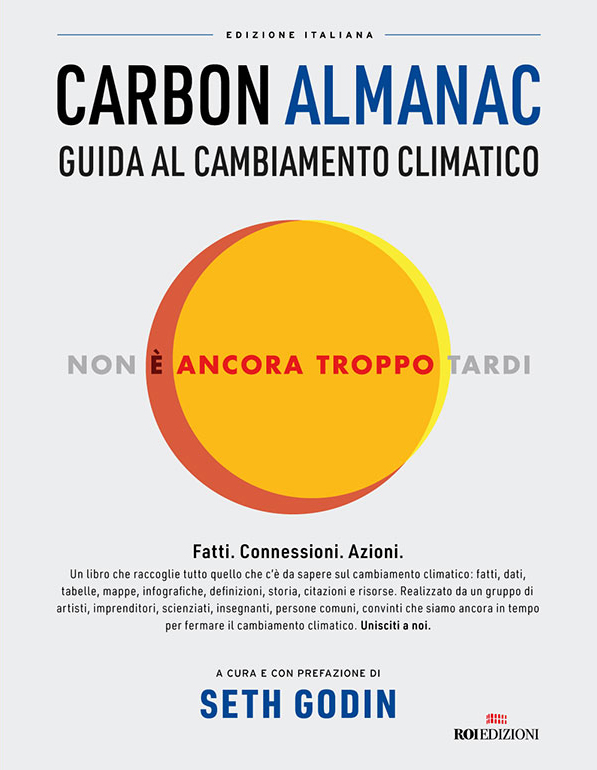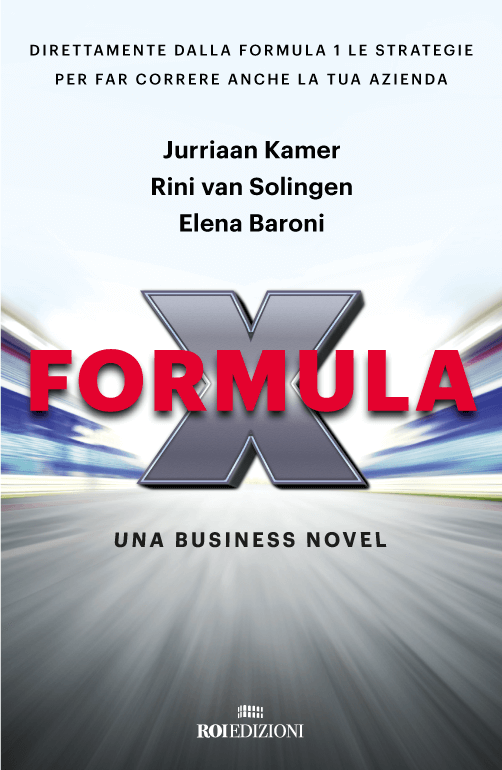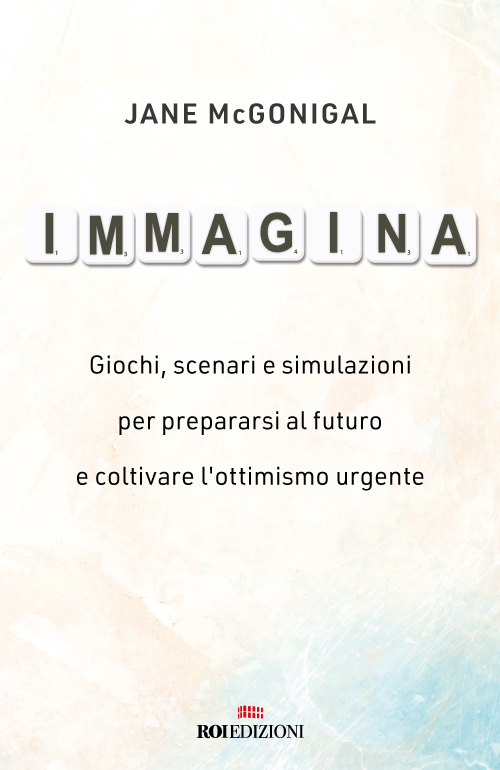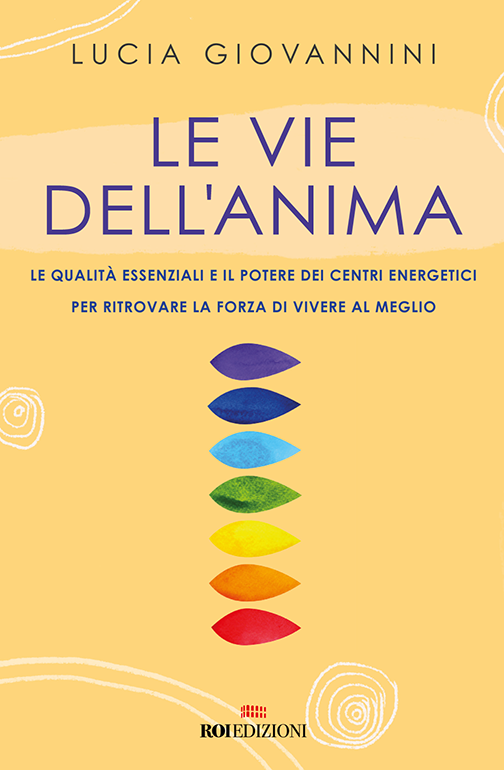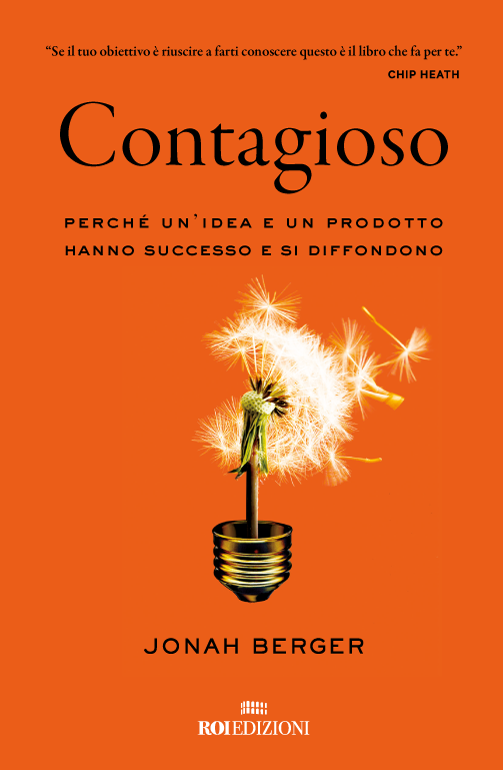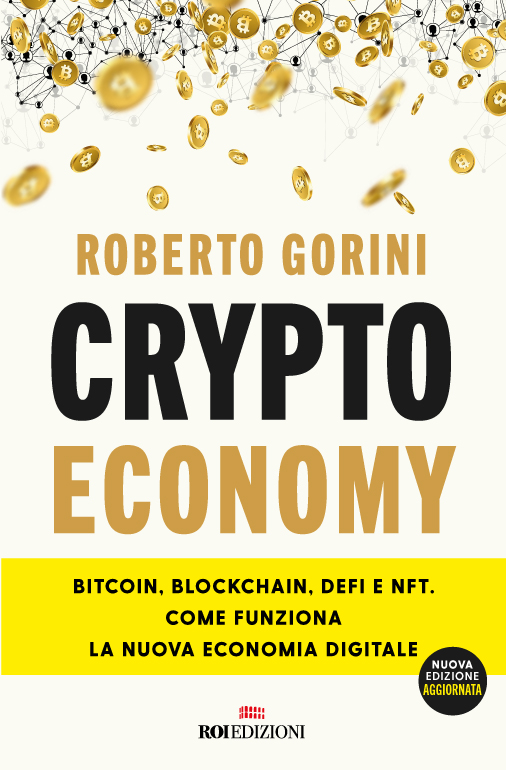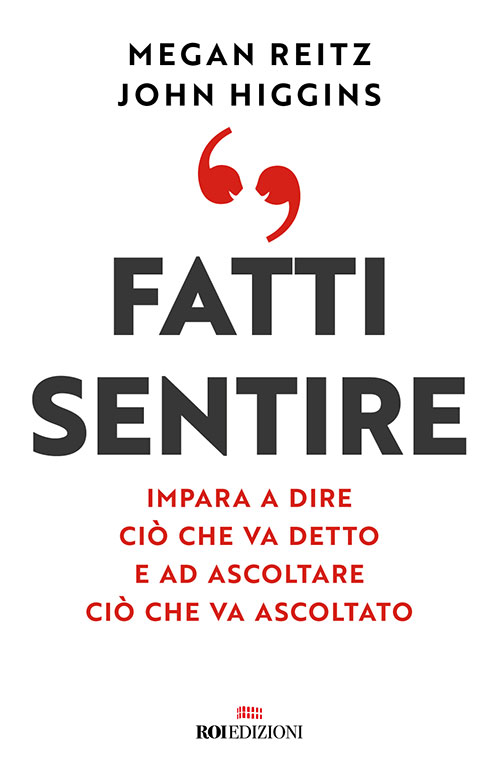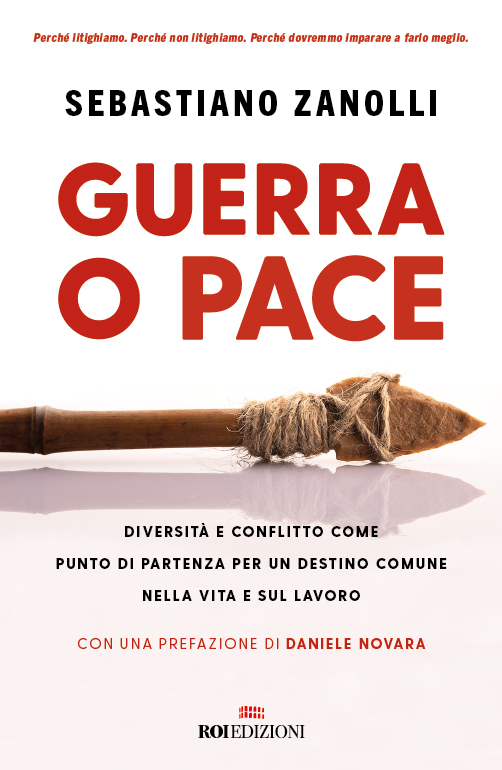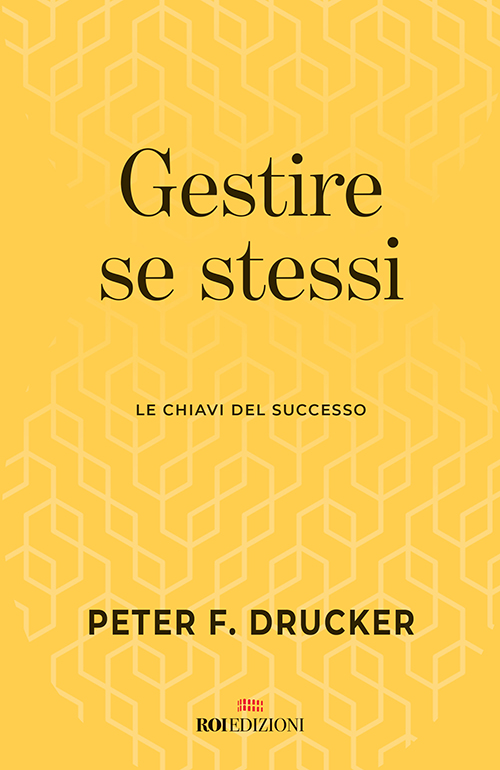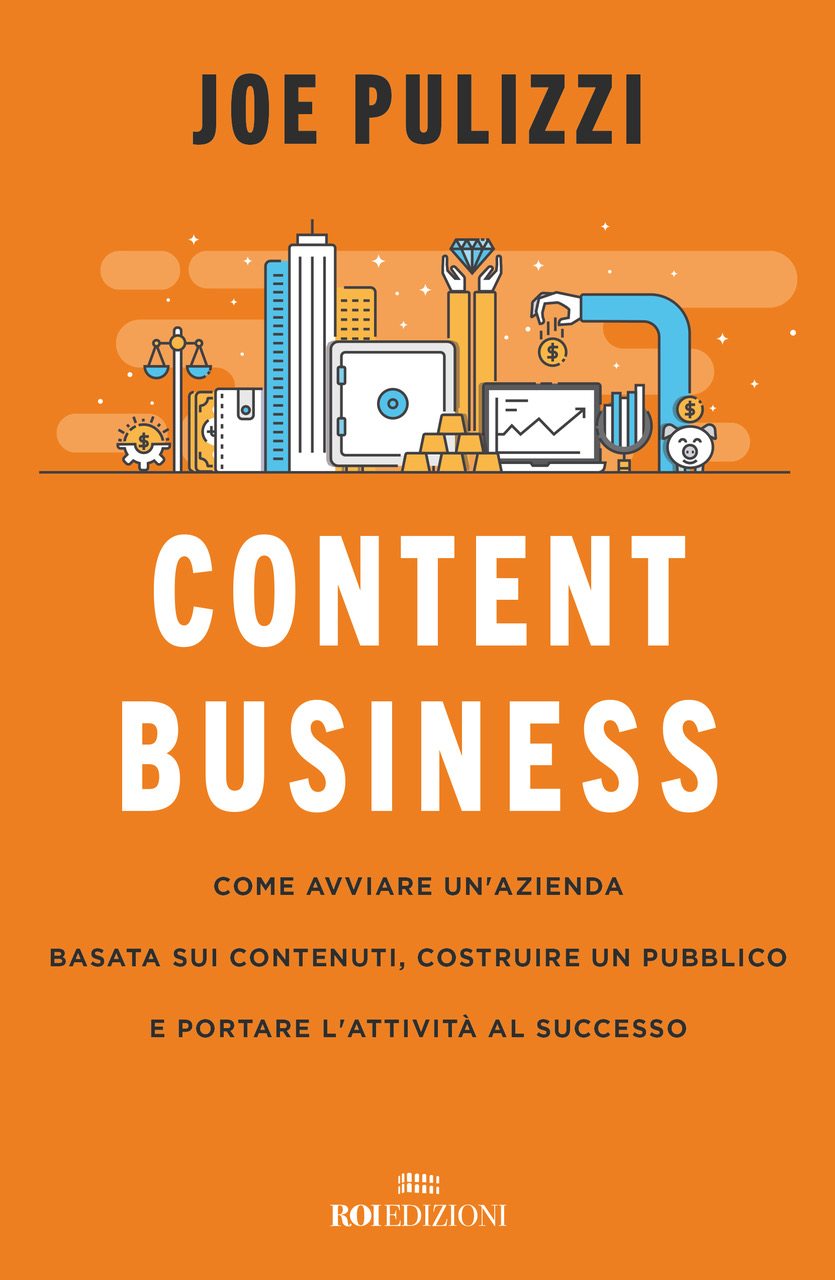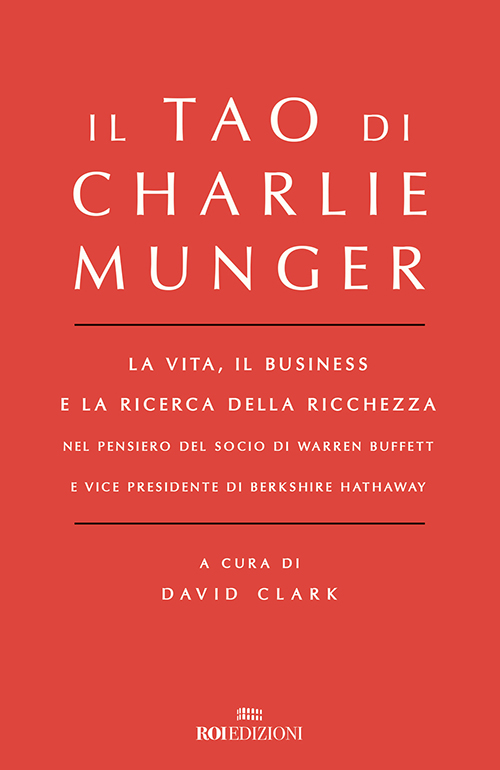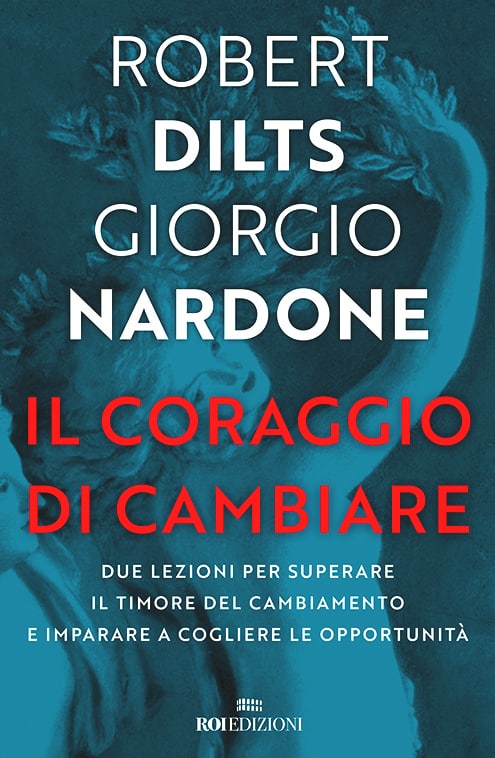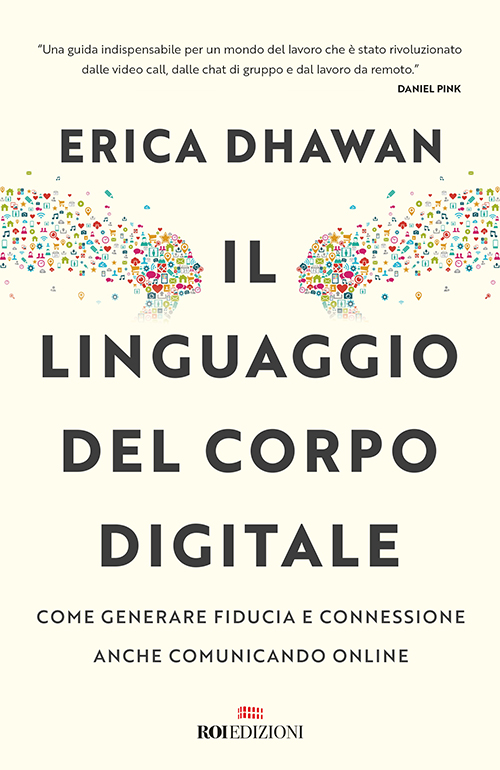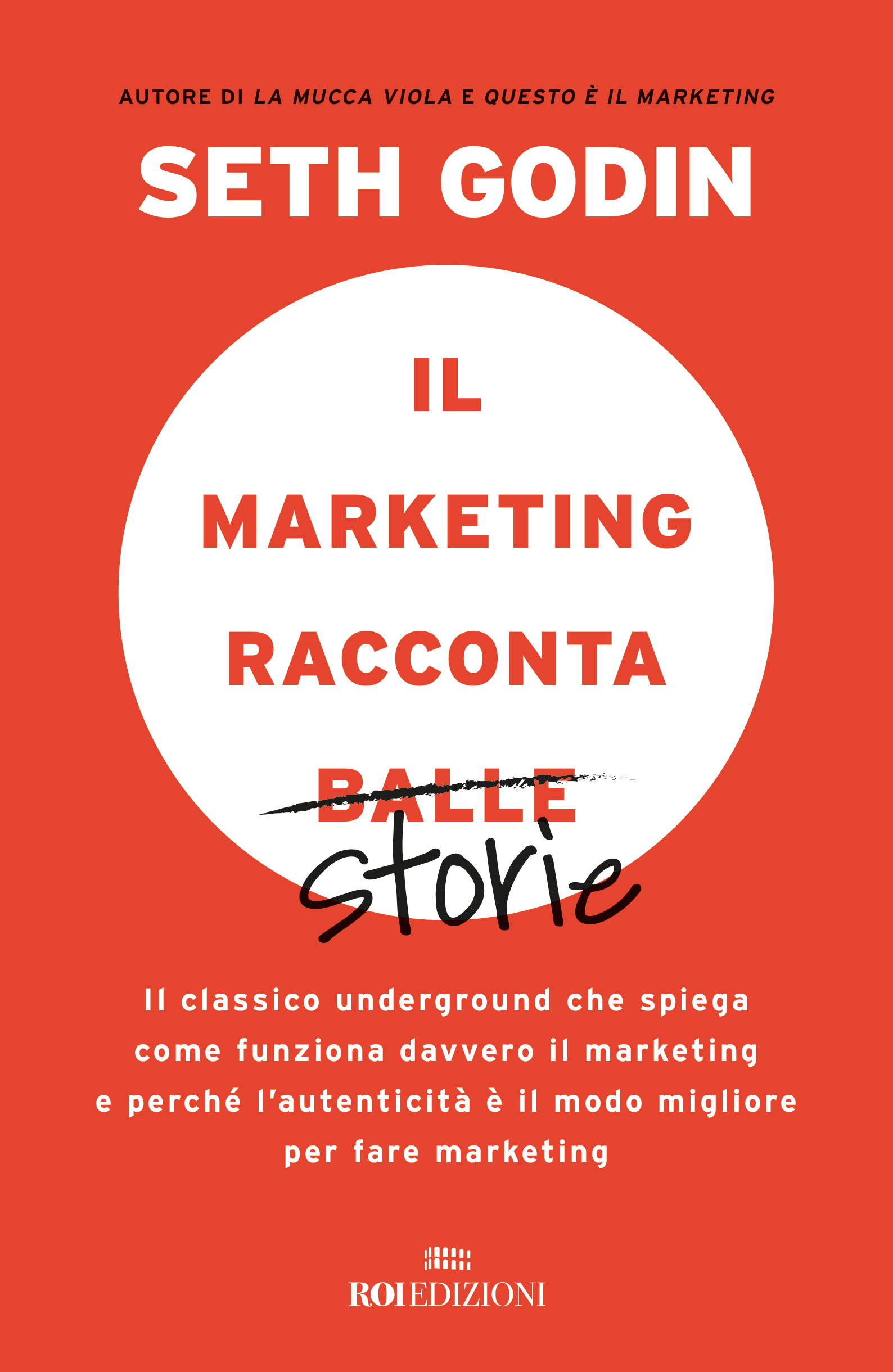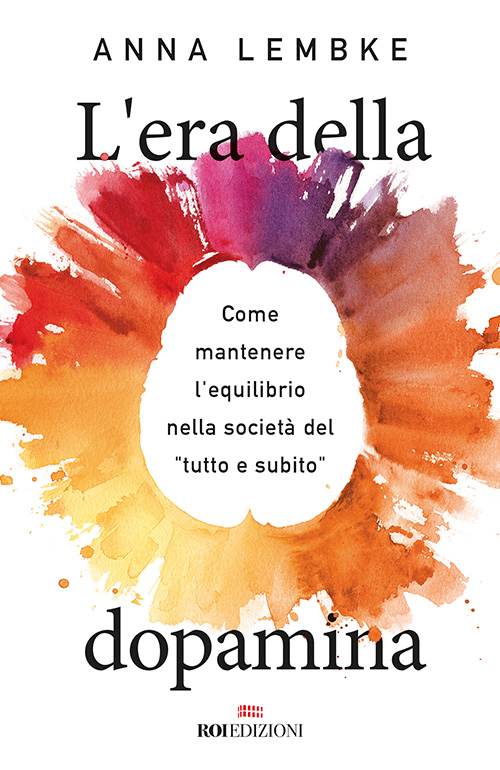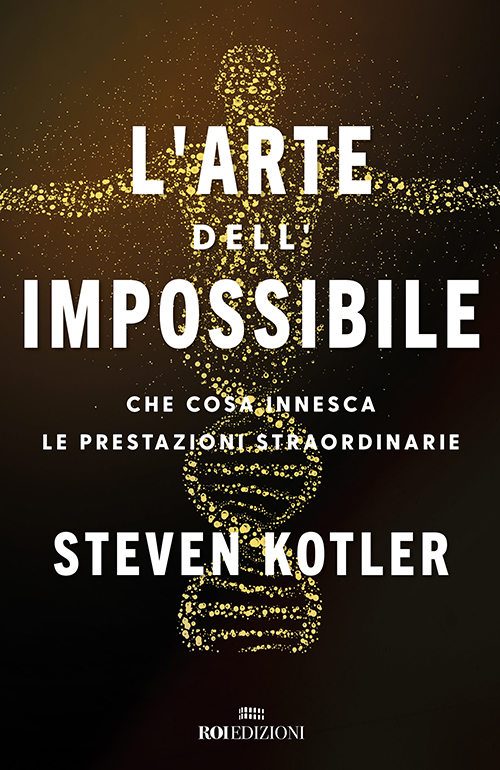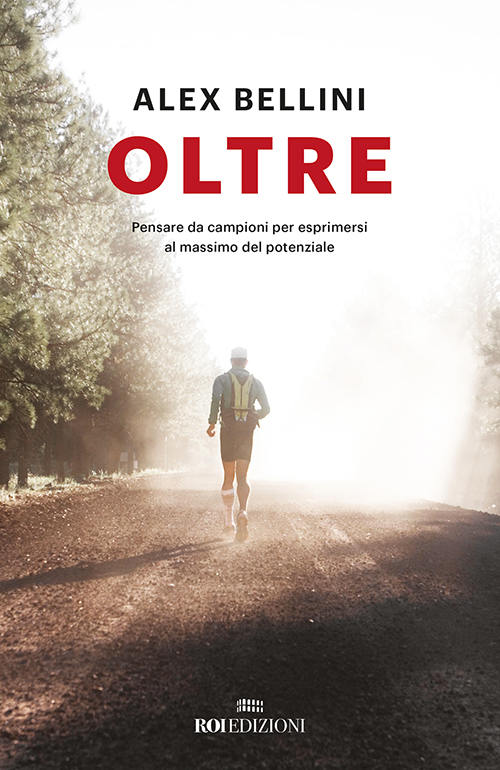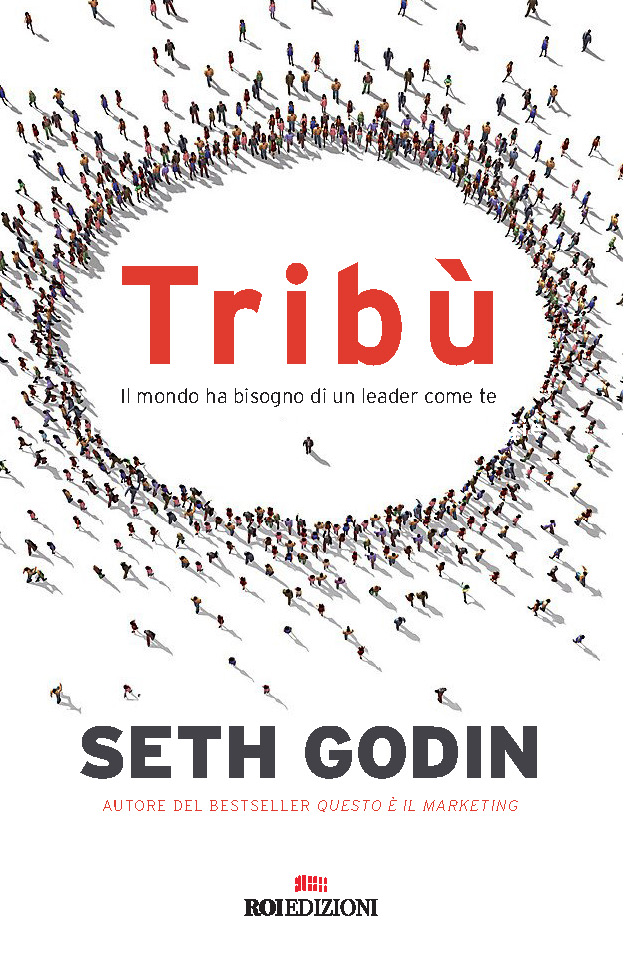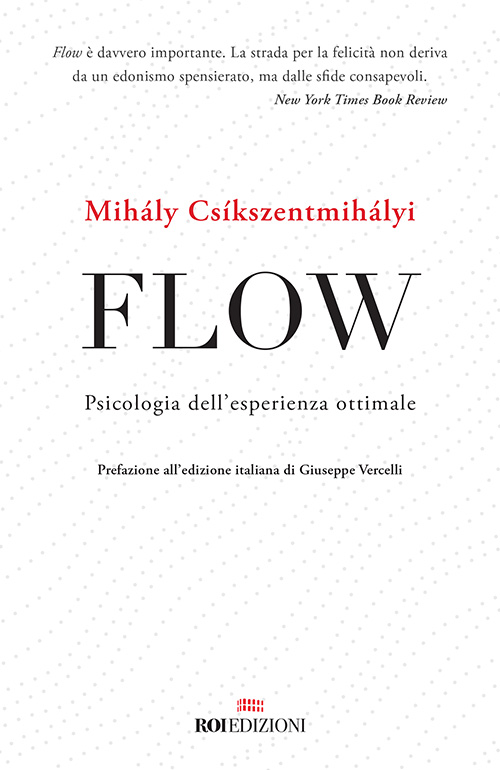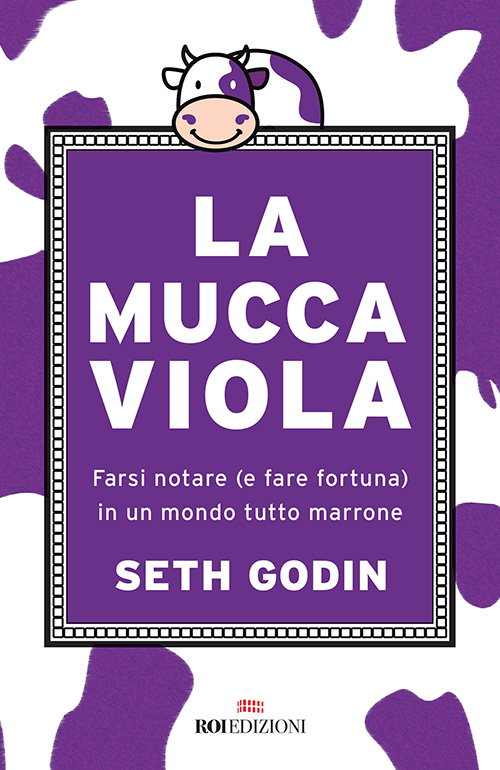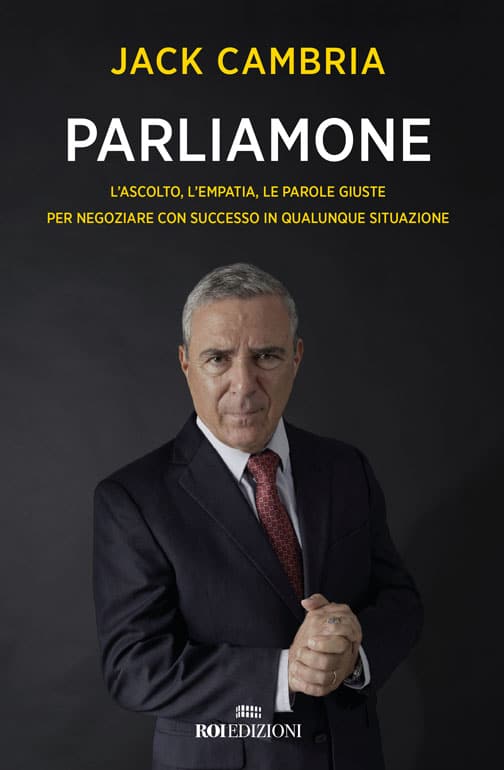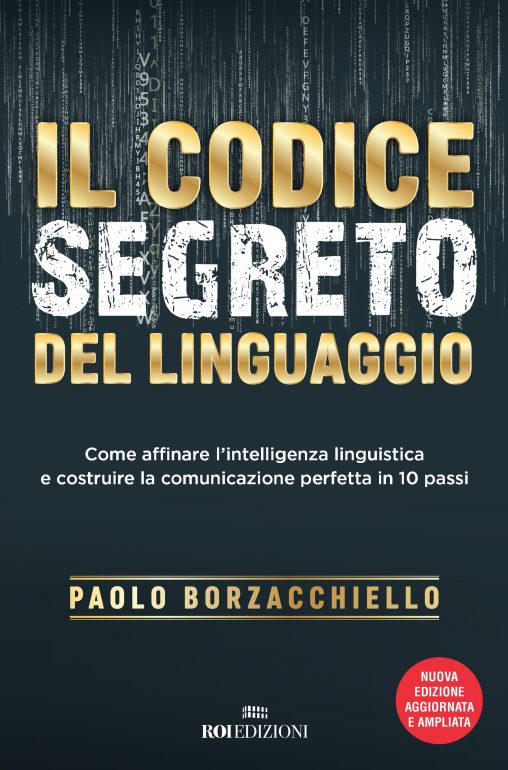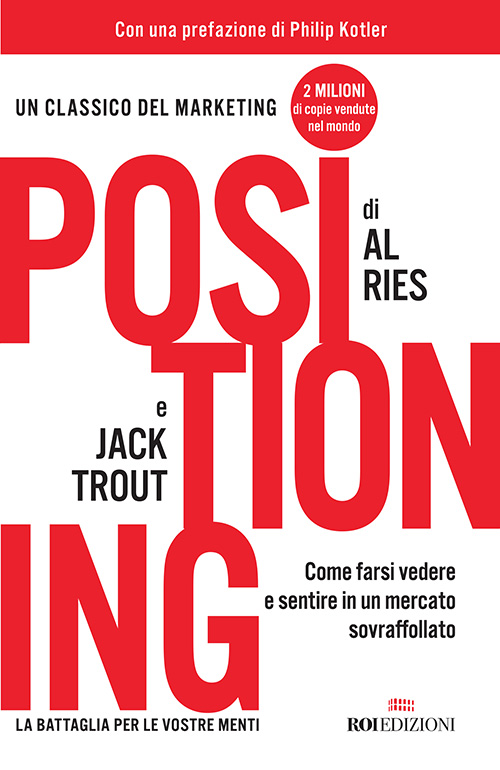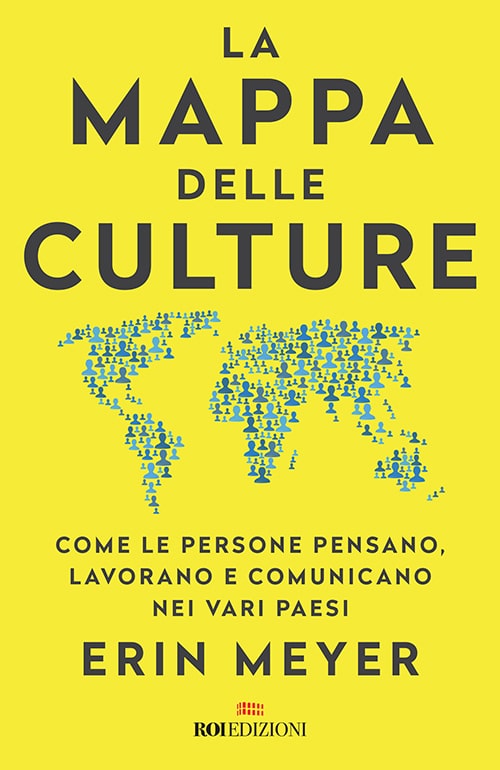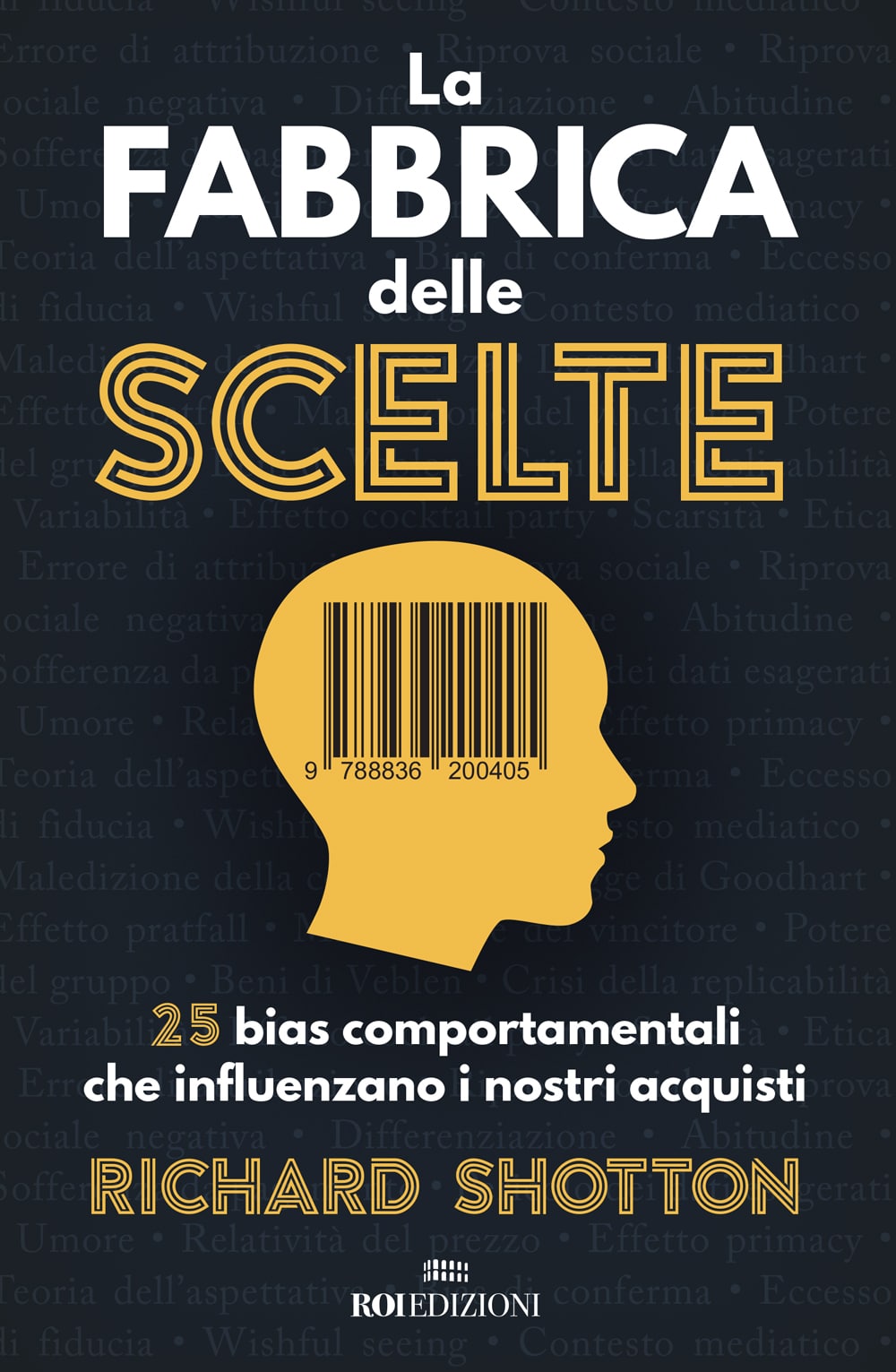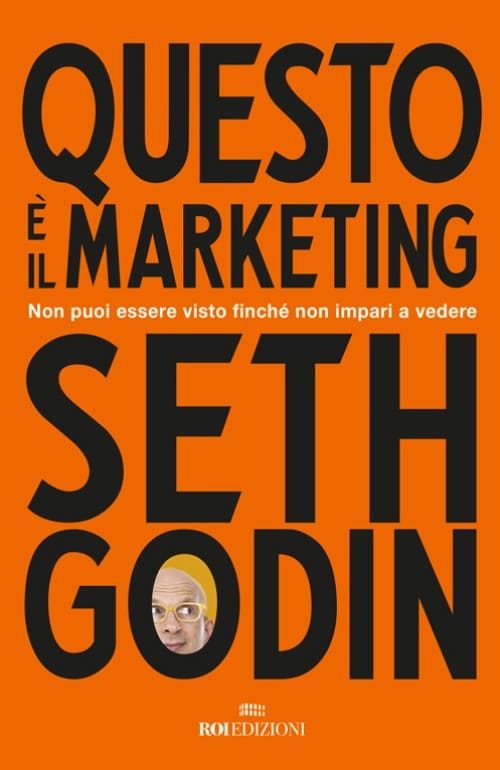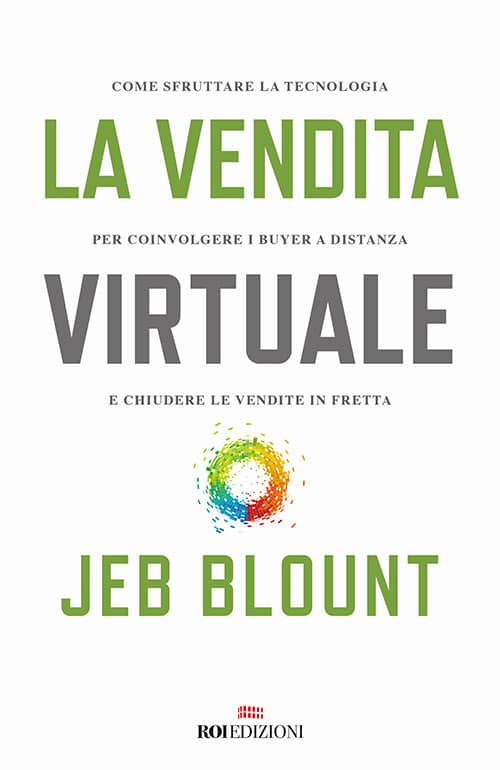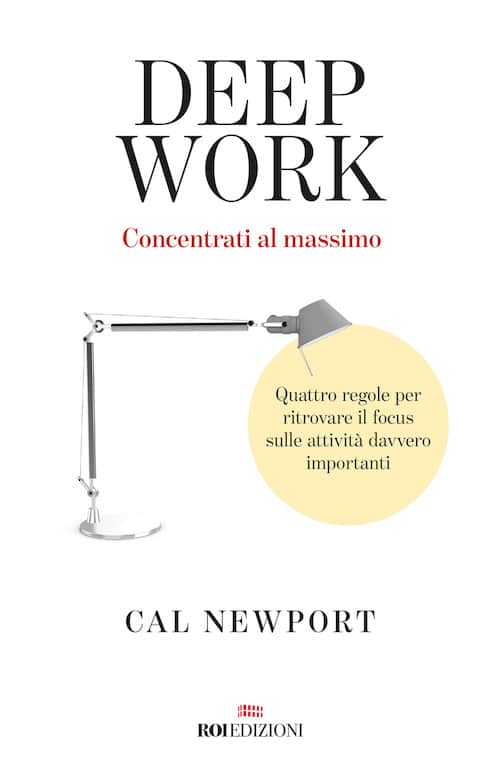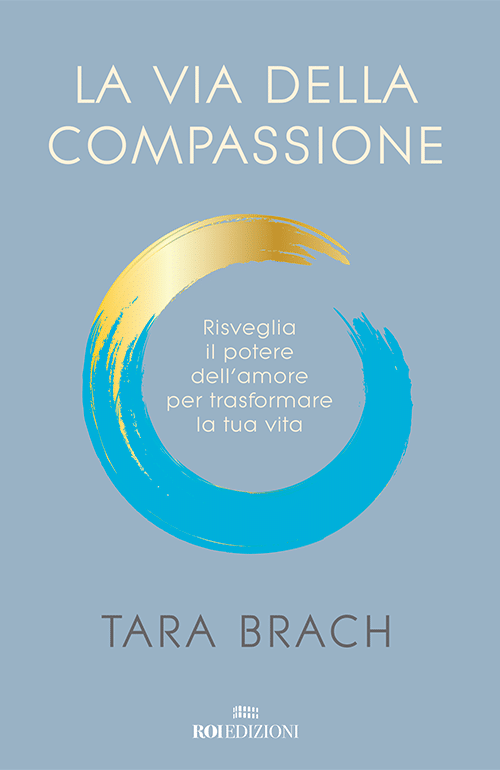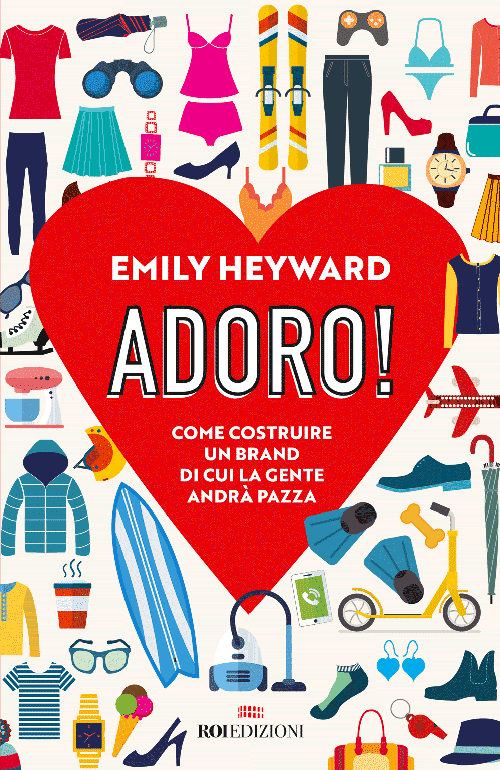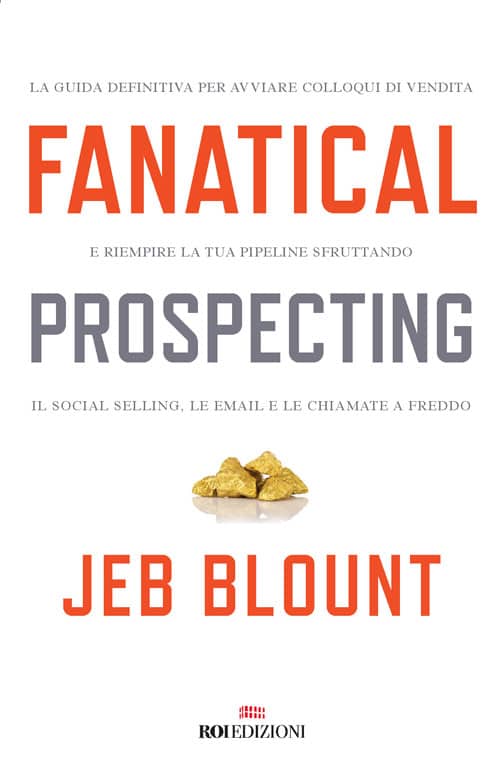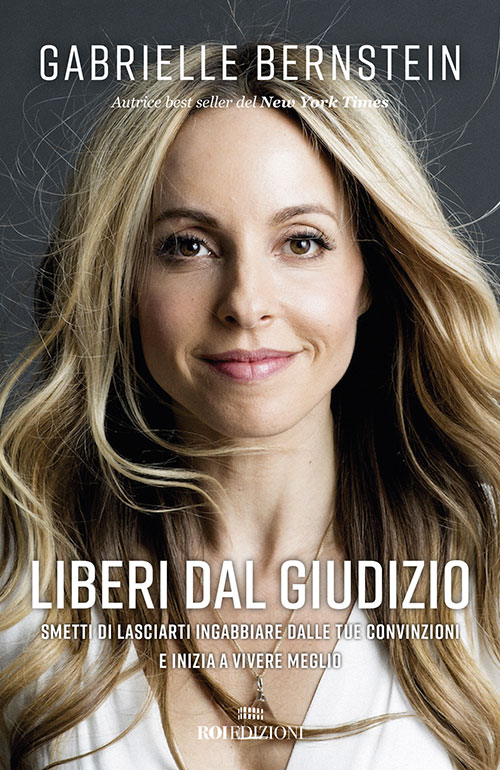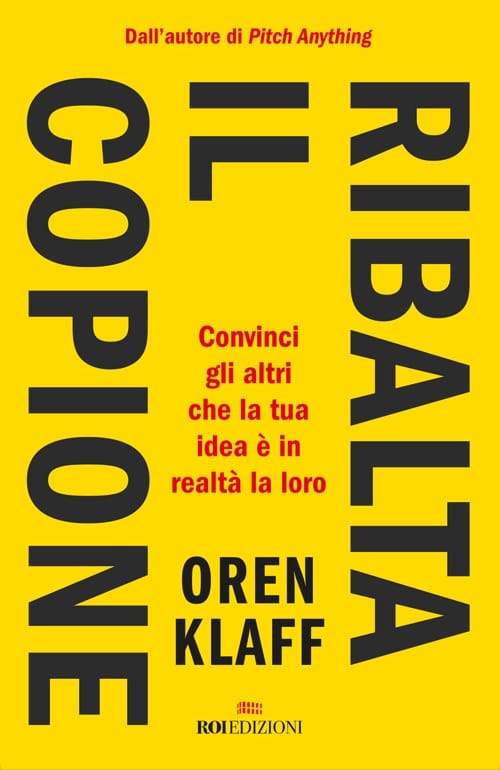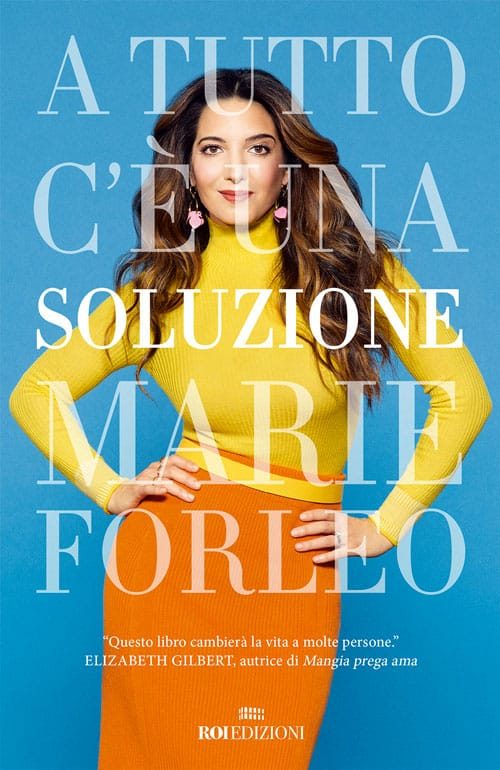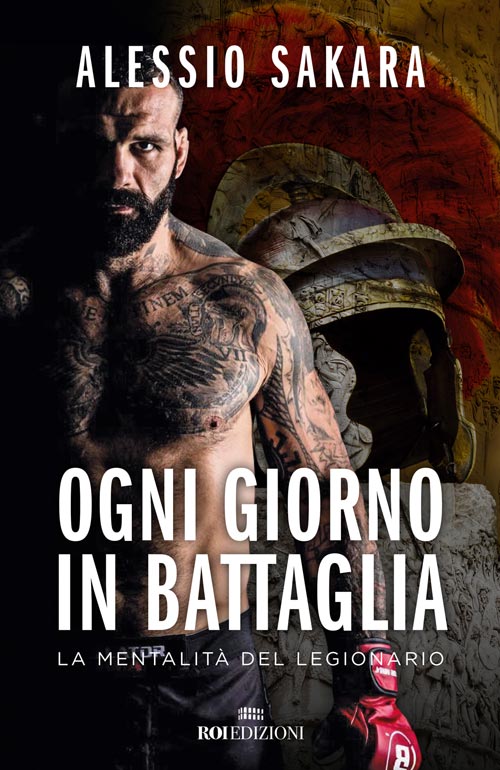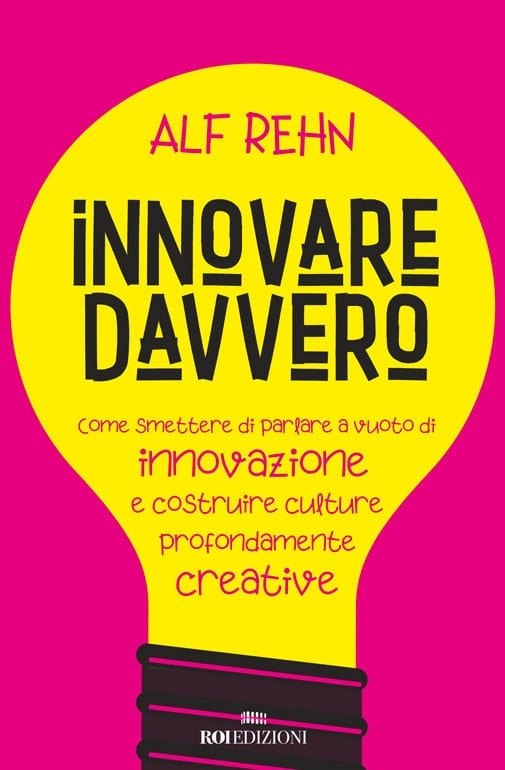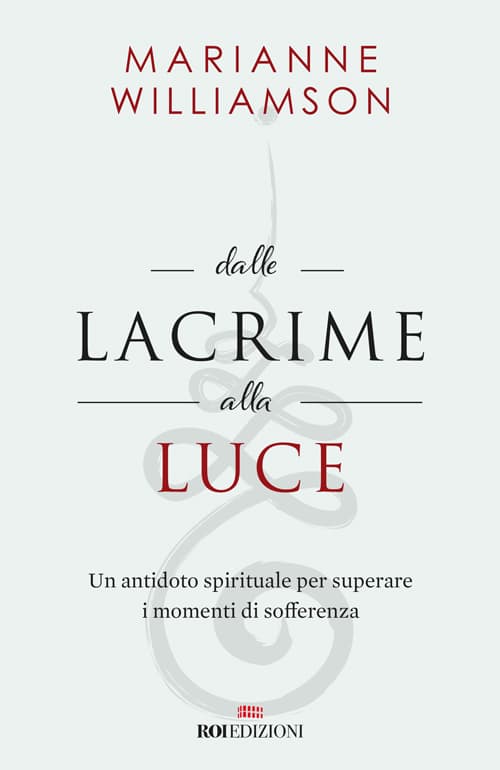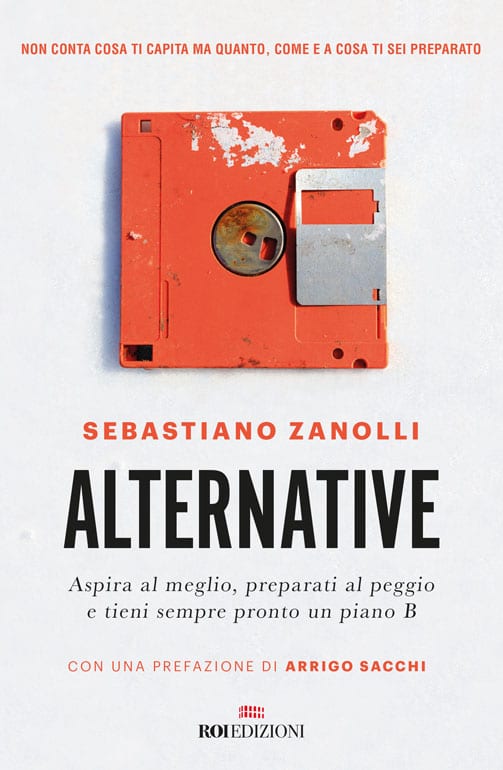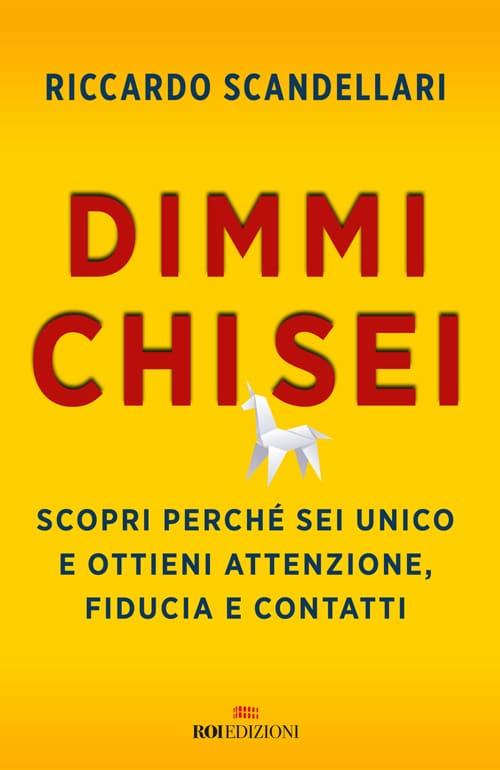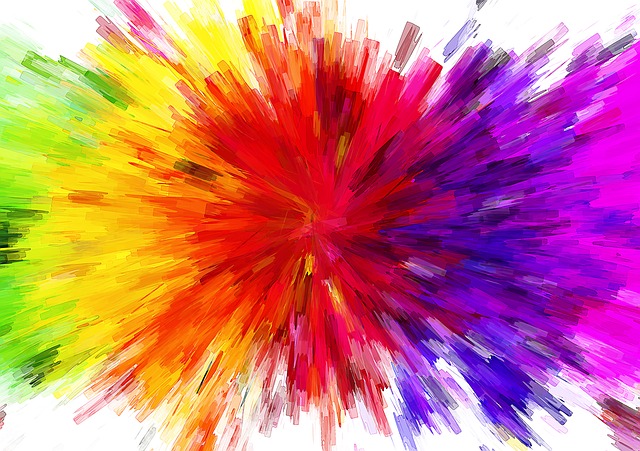Questo è, certamente, un modo radicalmente nuovo di considerare il pensiero. Potrebbe essere un punto di vista non facile, o non naturale, da assumere. Eppure, una massa crescente di evidenze prodotte nel contesto di diverse discipline scientifiche indica che si tratta di un punto di vista molto più accurato in merito a come funzioni effettivamente la cognizione degli esseri umani. Inoltre, è una gratificante concettualizzazione generativa, perché offre tante opportunità, sul piano pratico, per migliorare il modo in cui pensiamo.
Tale concettualizzazione, potremmo dire, è giunta appena in tempo. La riformulazione del modello che rappresenta il modo in cui funziona la nostra mente, oggigiorno, è diventata una necessità urgente, poiché ci troviamo sempre più schiacciati tra due forze opposte: per un verso, abbiamo sempre più bisogno di pensare fuori dal cervello, per l’altro, siamo sempre più ostinatamente compromessi e condizionati dall’approccio brainbound. In primo luogo, per quanto riguarda la necessità crescente di pensare fuori dal cervello, come molti di noi possono facilmente riconoscere – in ragione del ritmo accelerato delle nostre giornate e nella crescente complessità dei nostri impegni scolastici o professionali –, le esigenze che riguardano il nostro pensiero diventano sempre più complesse e continuano ad aumentare. In altri termini, c’è una quantità maggiore di informazioni di cui dobbiamo occuparci. Le informazioni che dobbiamo elaborare si susseguono più velocemente. E il tipo di informazioni di cui dobbiamo occuparci è sempre più specializzato e astratto.
Quest’ultima differenza è particolarmente significativa. Le conoscenze e le abilità che siamo biologicamente preparati ad apprendere sono state superate dalla necessità di acquisire un insieme di competenze che manifestiamo in modo molto meno naturale e che acquisiamo con molta più difficoltà. David Geary, professore di psicologia all’Università del Missouri, pone un’utile distinzione tra le abilità “biologicamente primarie” e quelle “biologicamente secondarie”. Gli esseri umani, indica, fin dalla nascita sono pronti per imparare alcune cose: come, per esempio, parlare la lingua della comunità locale, orientarsi in un ambiente familiare, affrontare le sfide della vita in piccoli gruppi. Non siamo nati per imparare le complessità del calcolo, né le leggi controintuitive della fisica; non ci siamo evoluti per comprendere il funzionamento dei mercati finanziari o la complessità del cambiamento climatico globale. Eppure abitiamo in un mondo in cui tali abilità, biologicamente secondarie, costituiscono la chiave del progresso, e persino della nostra sopravvivenza. Le esigenze dell’ambiente moderno hanno ora raggiunto e superato i limiti del cervello biologico.