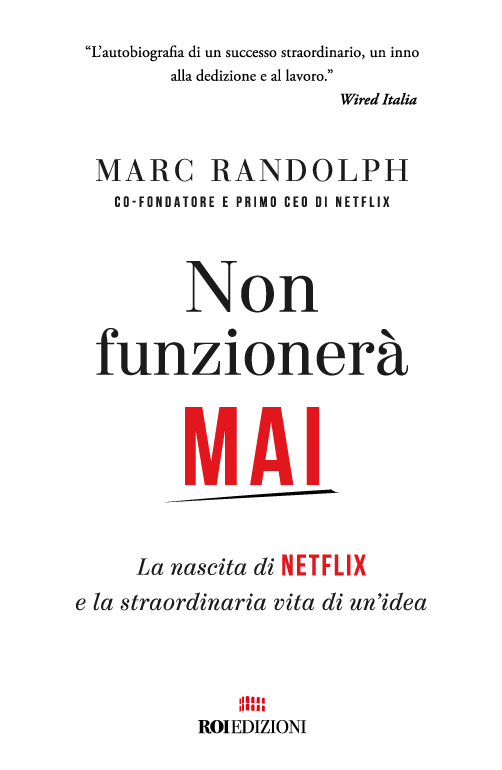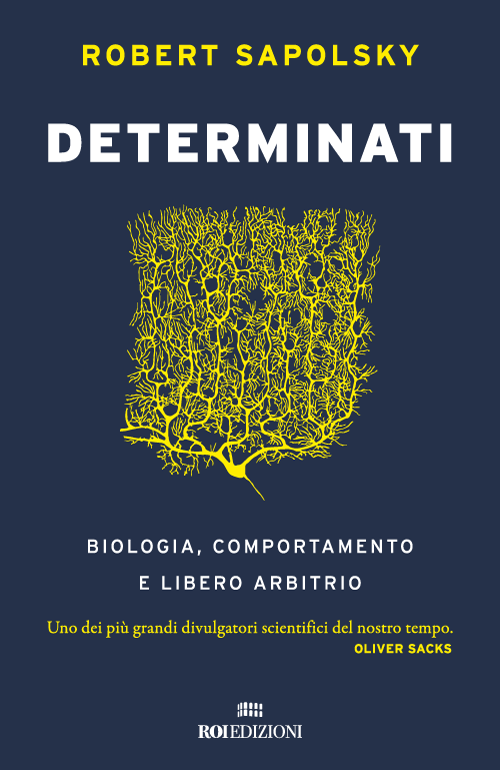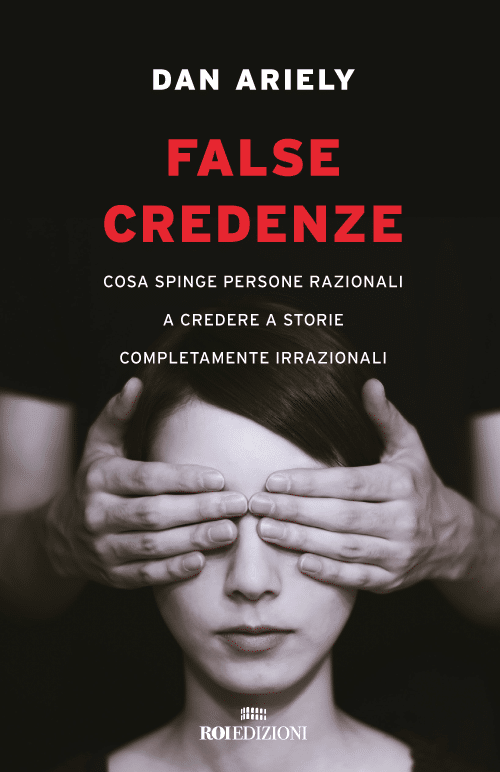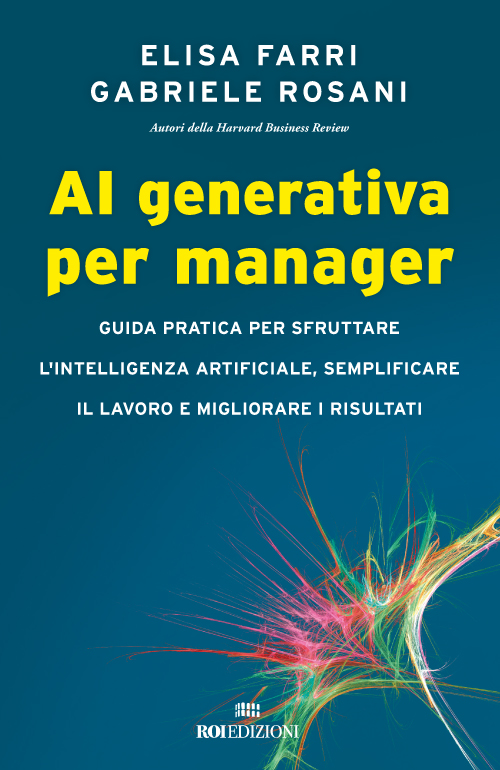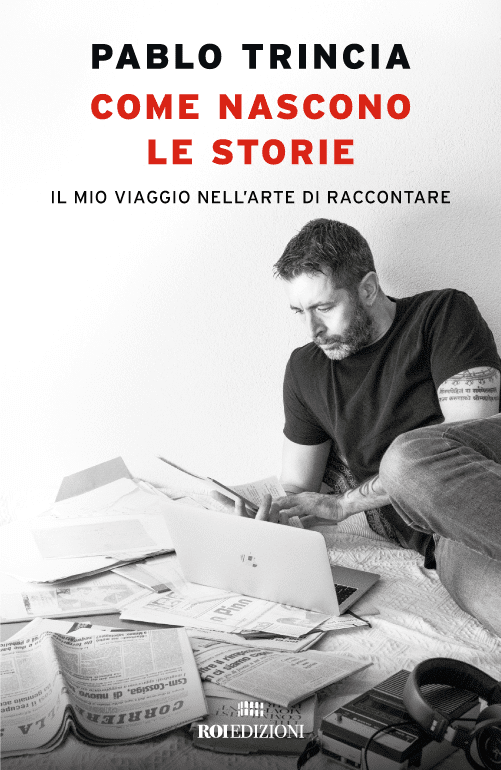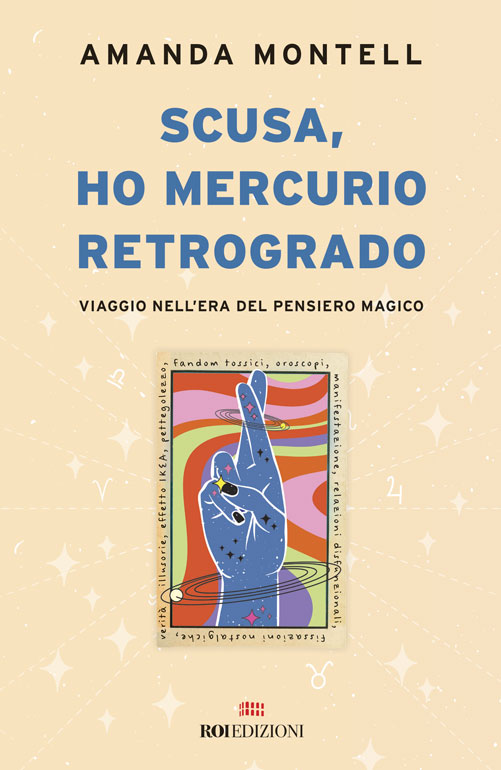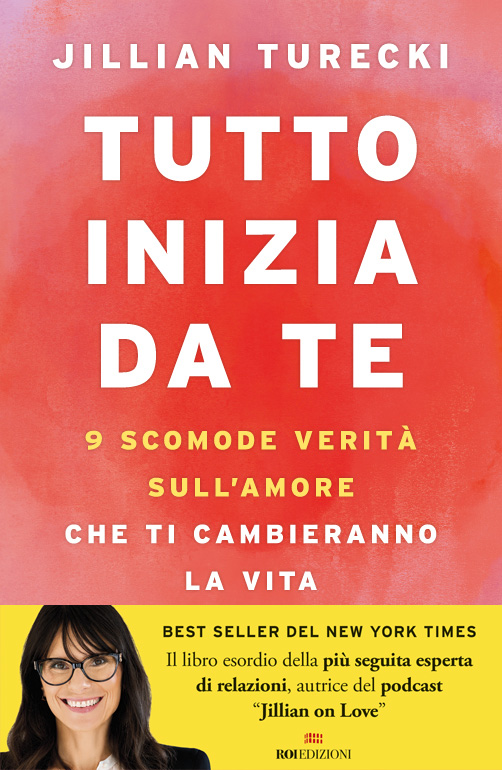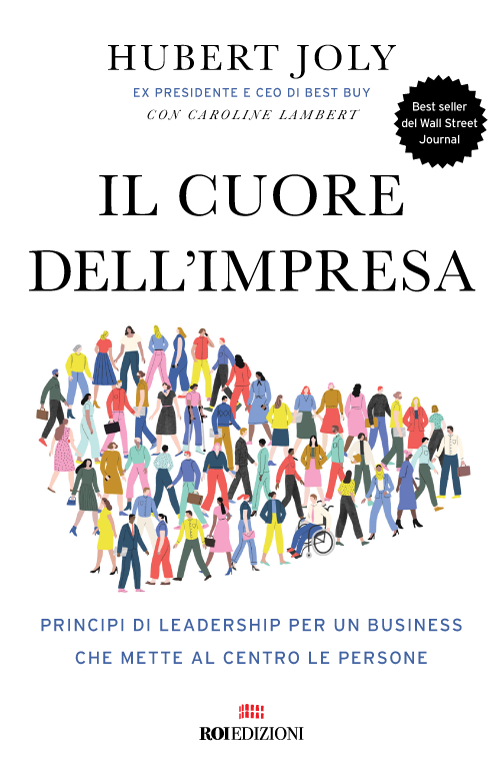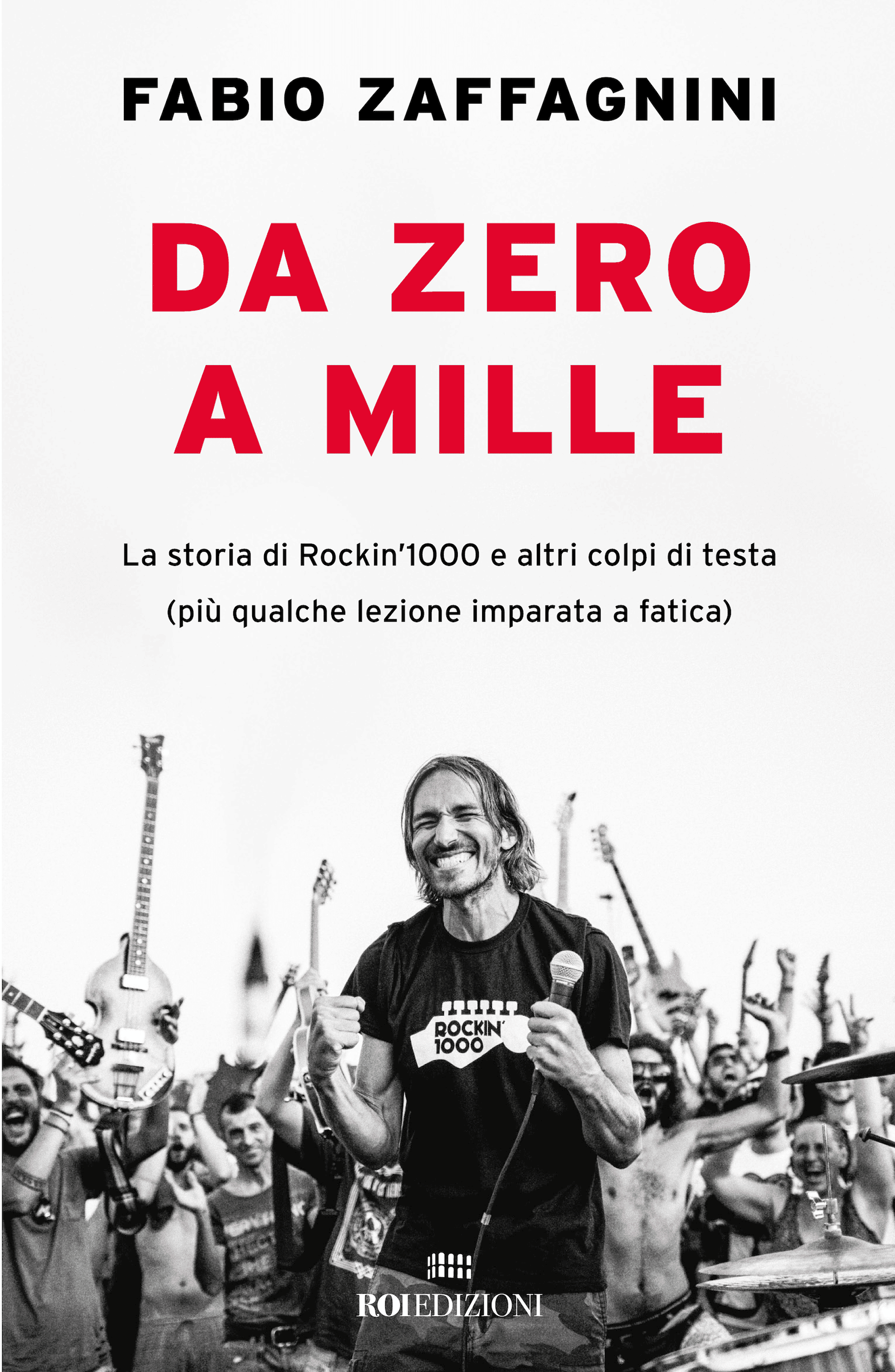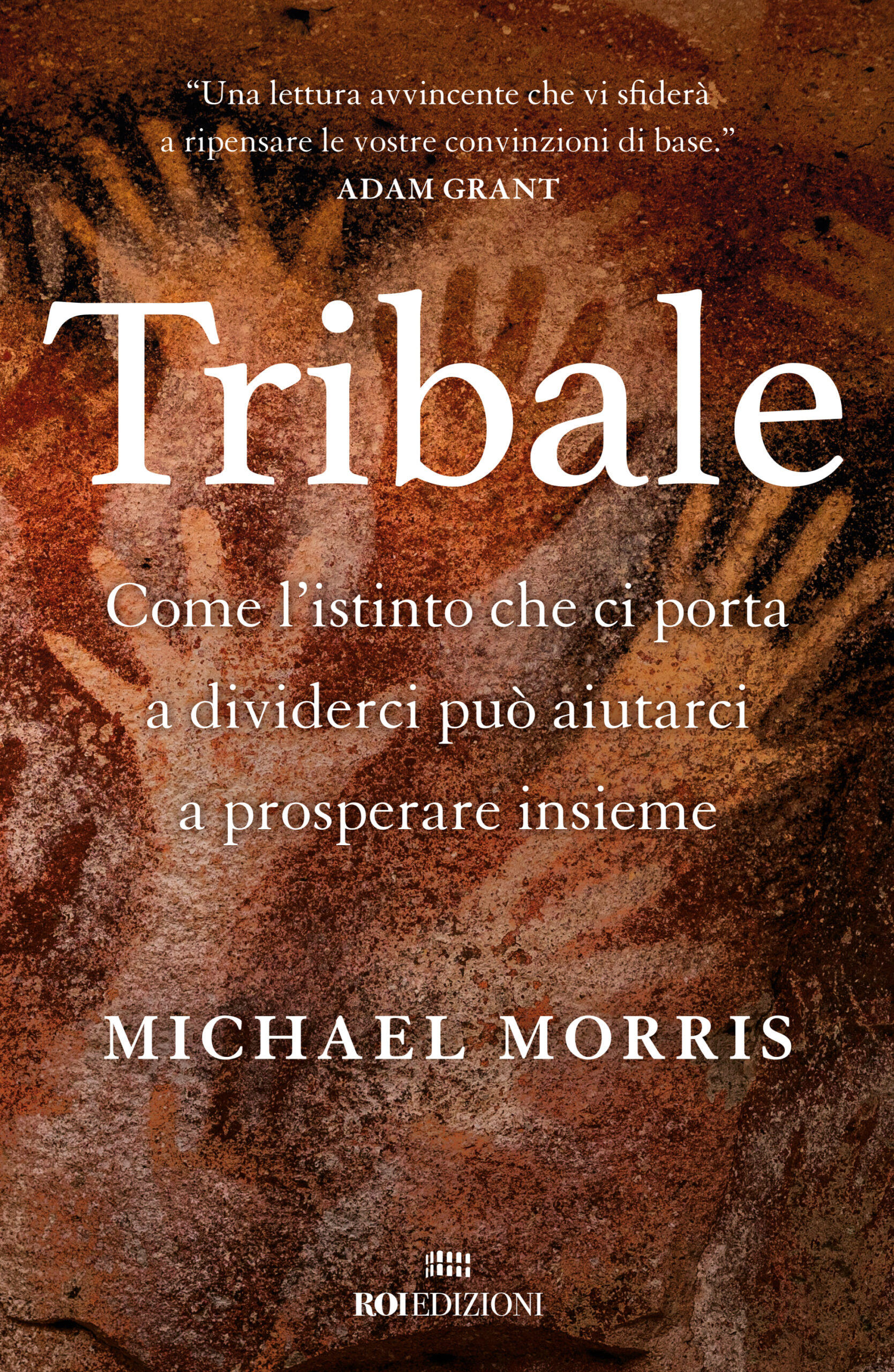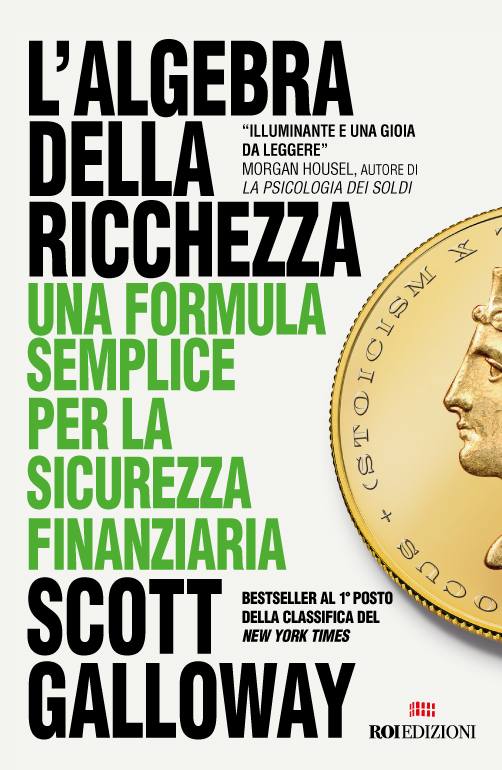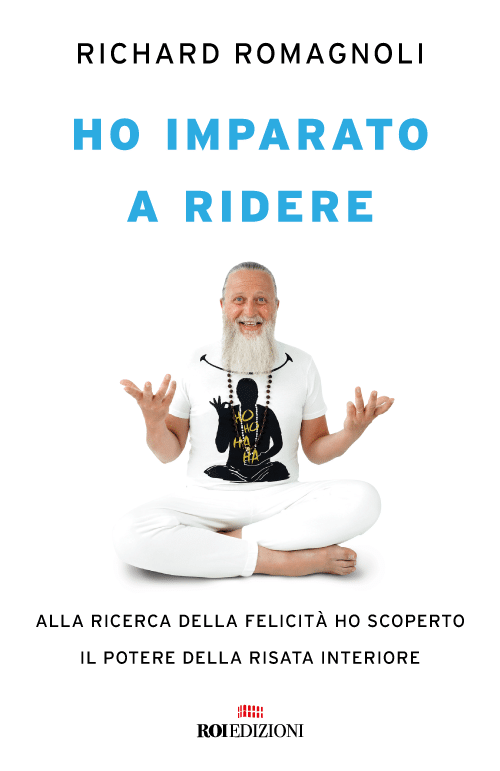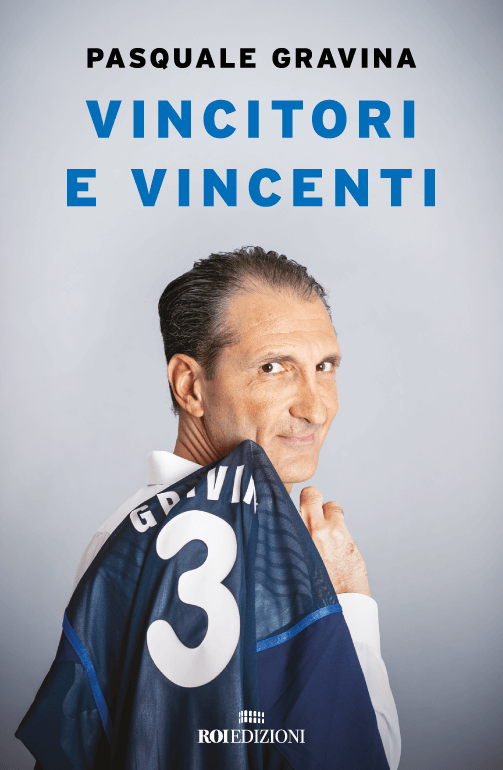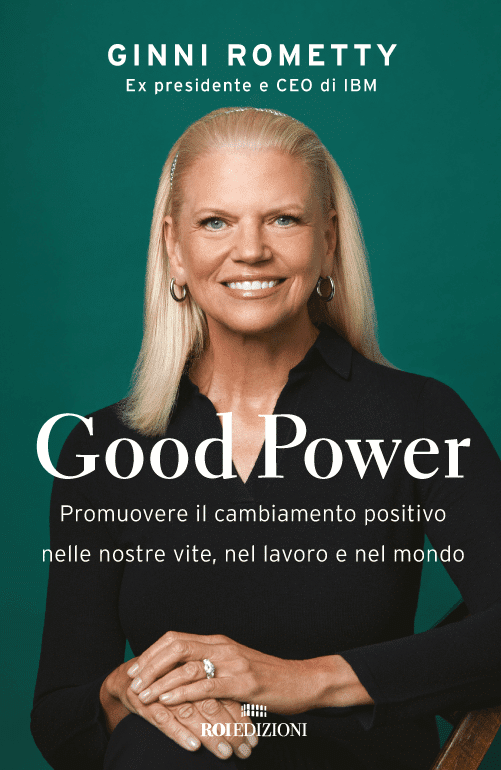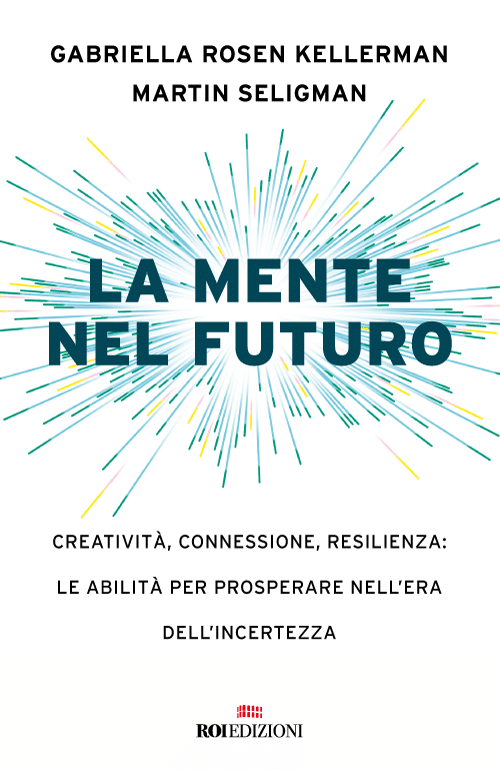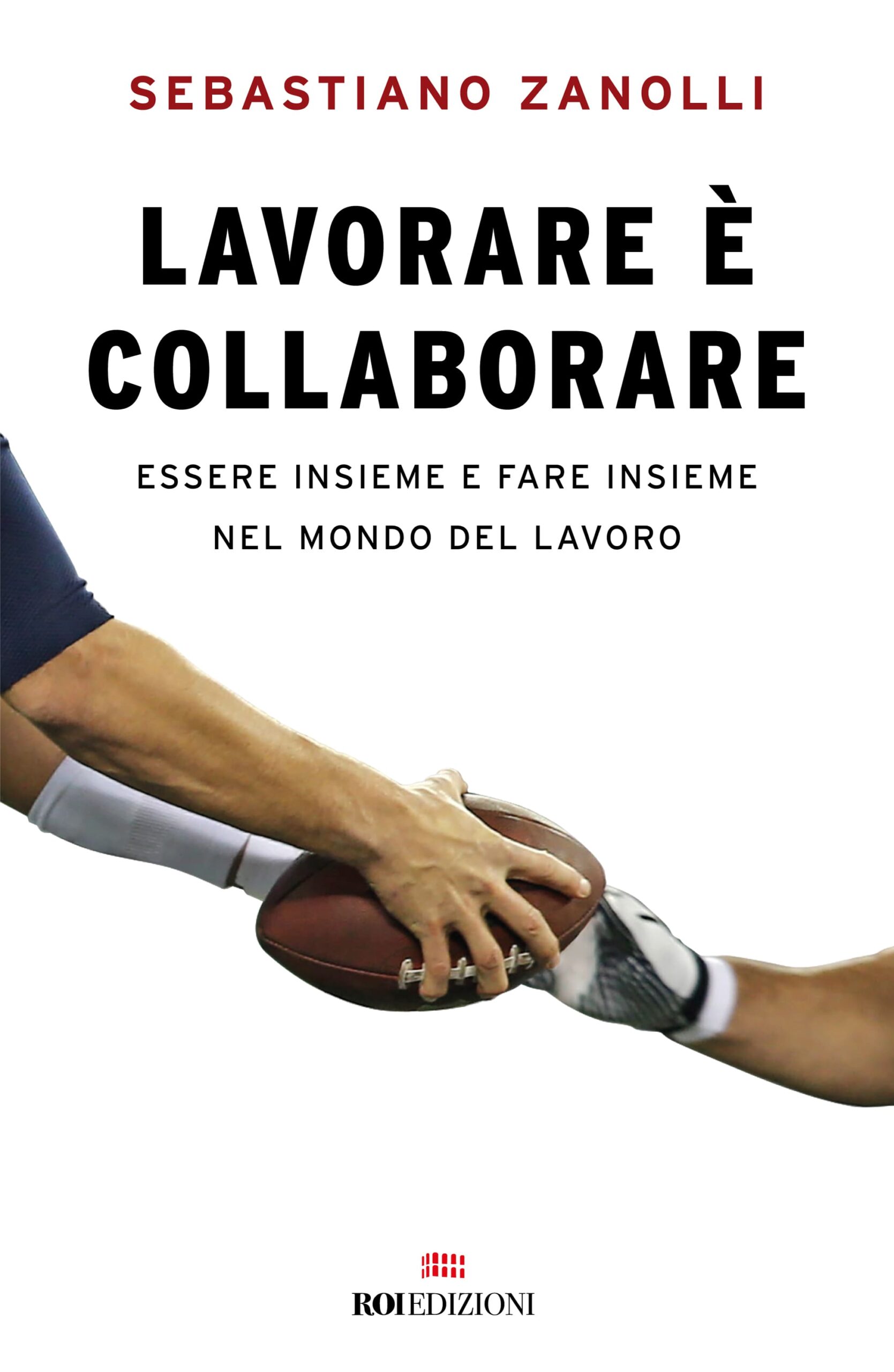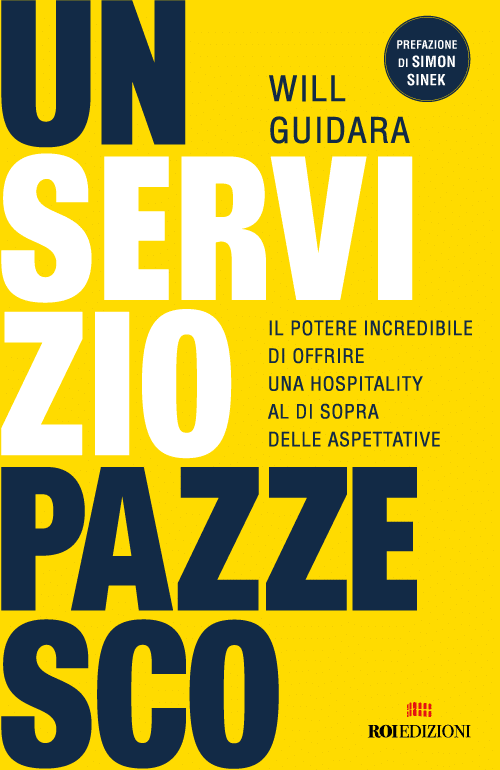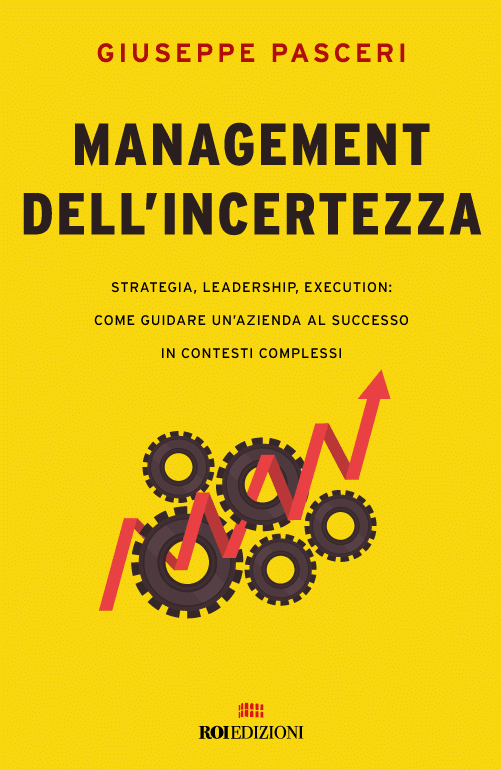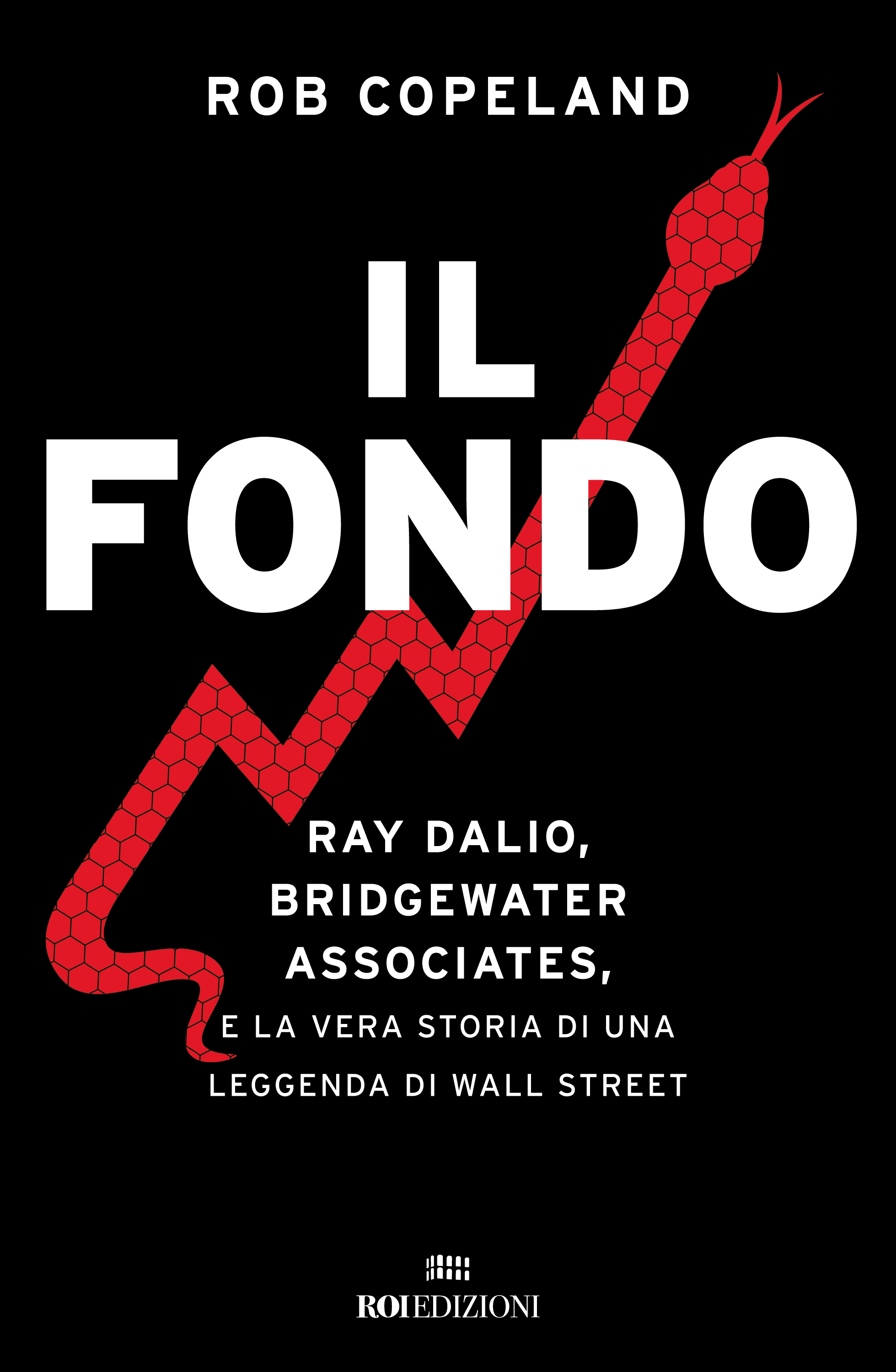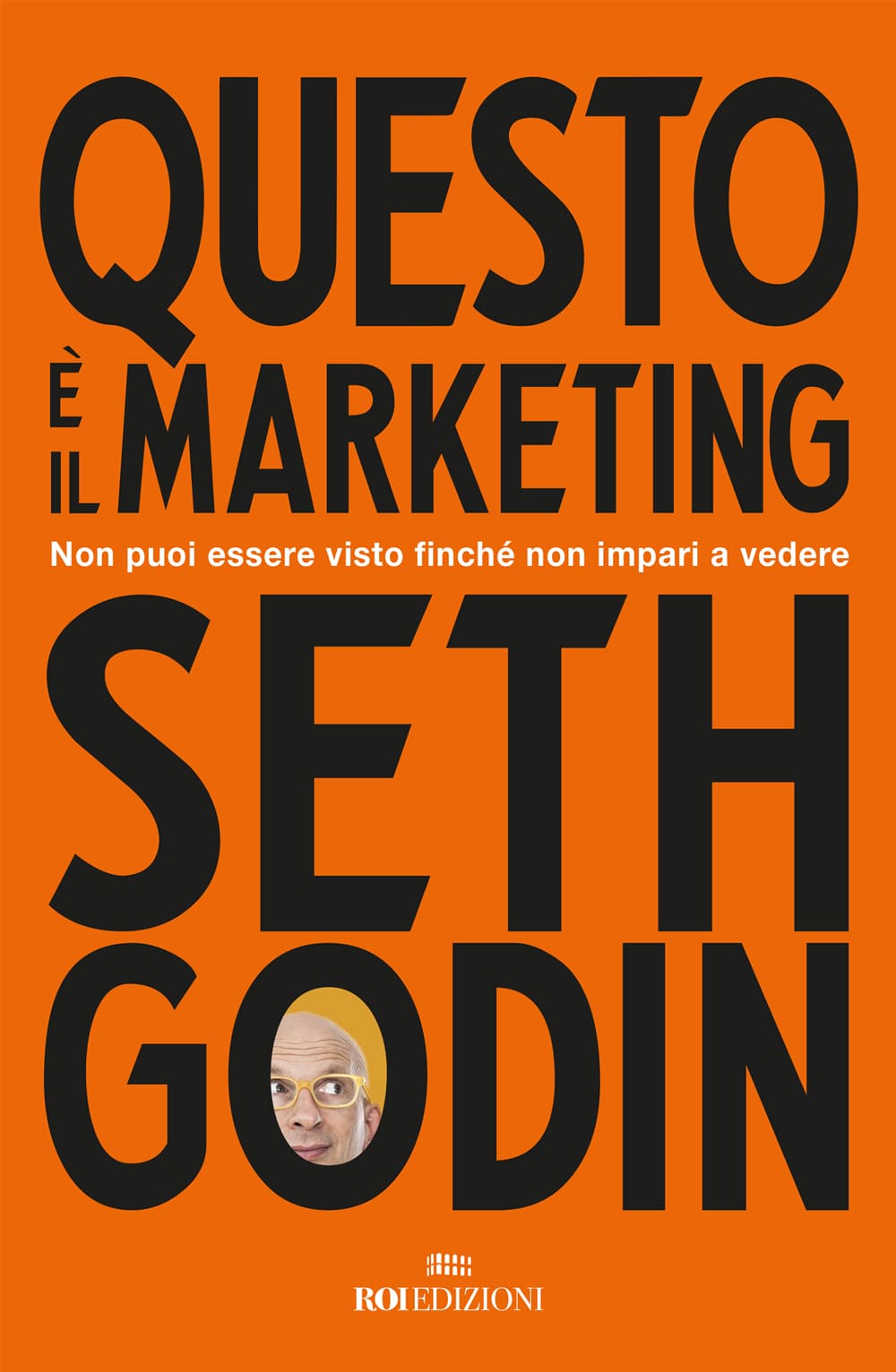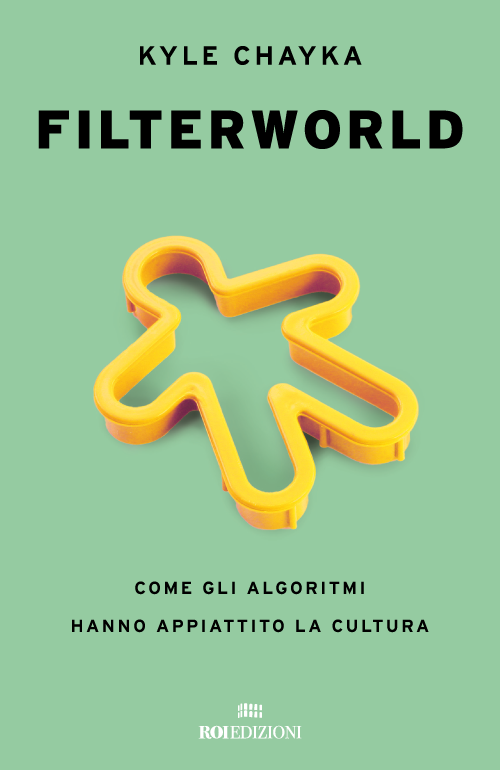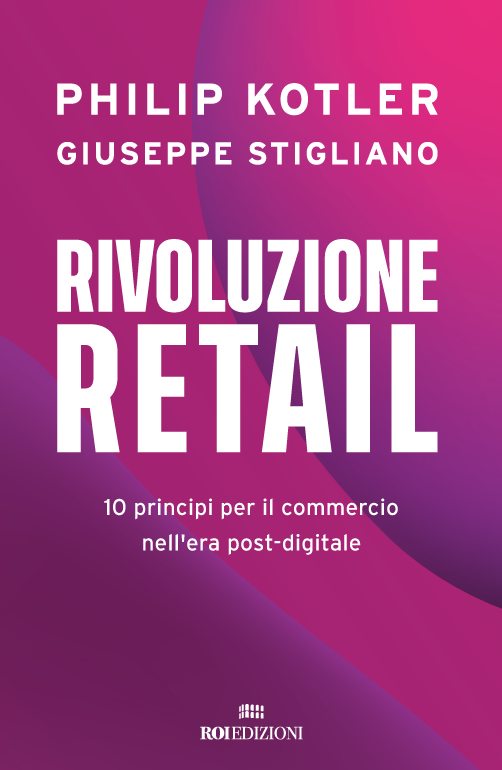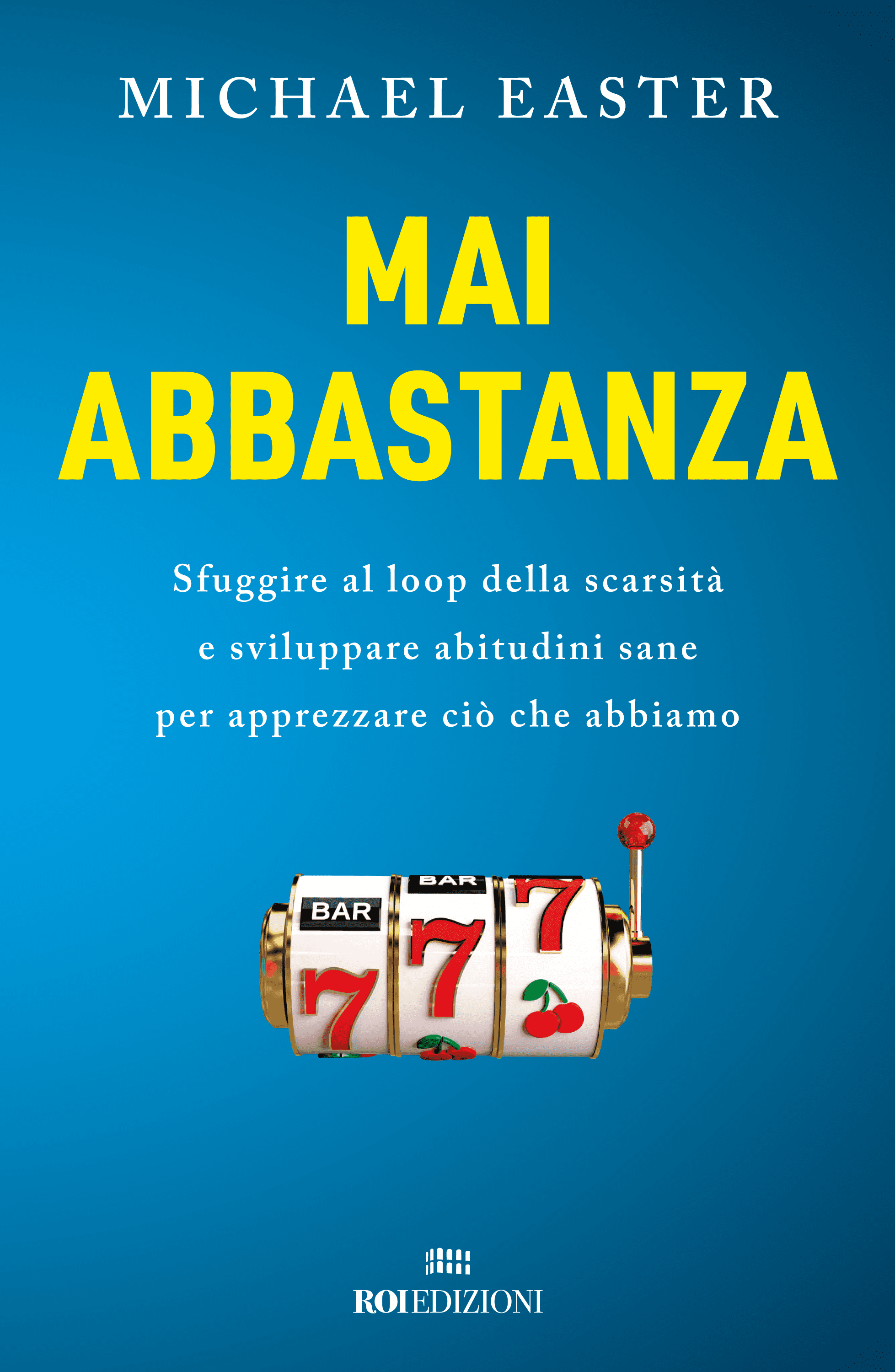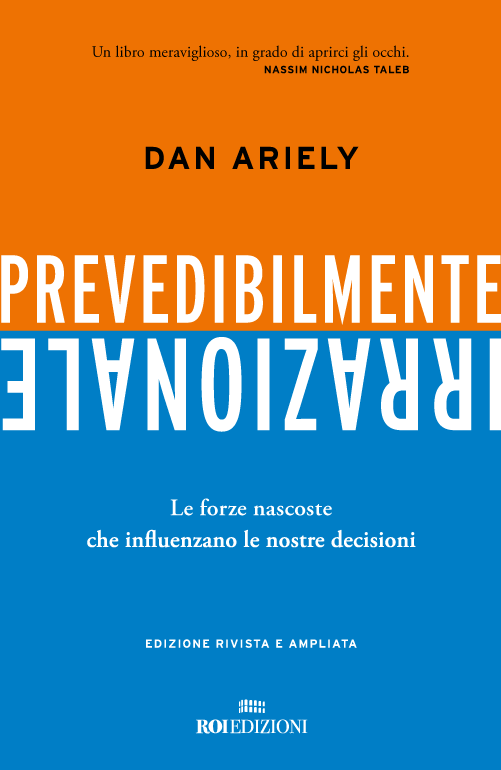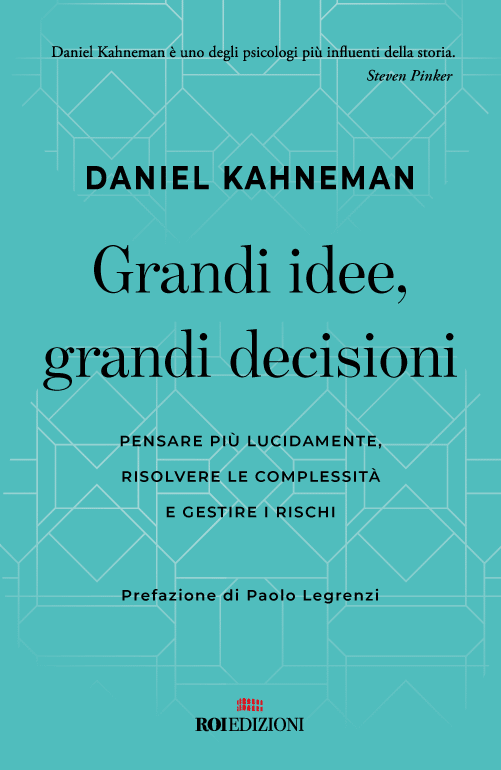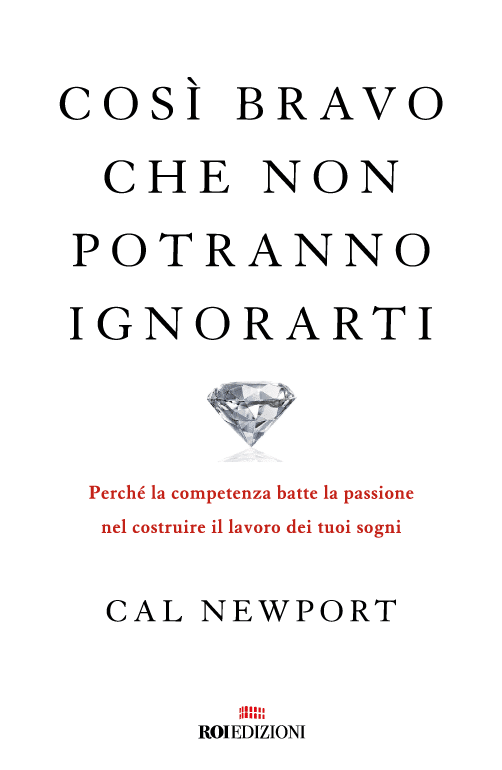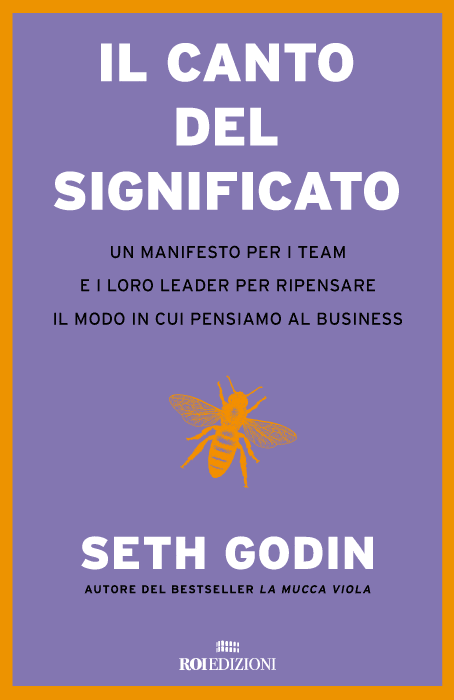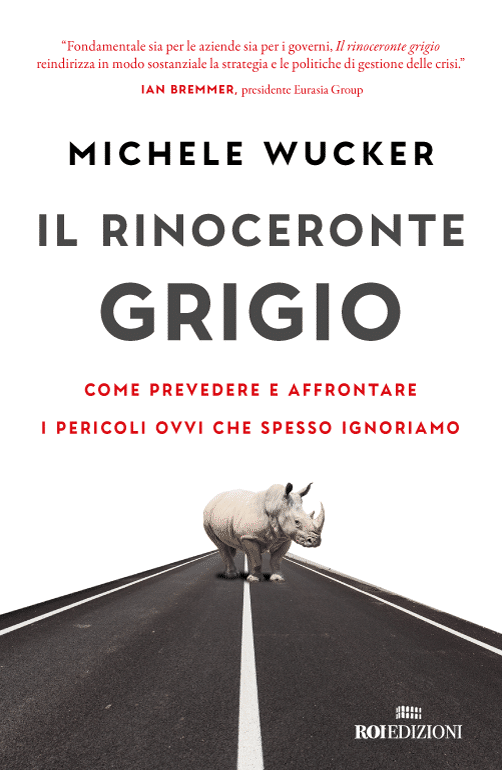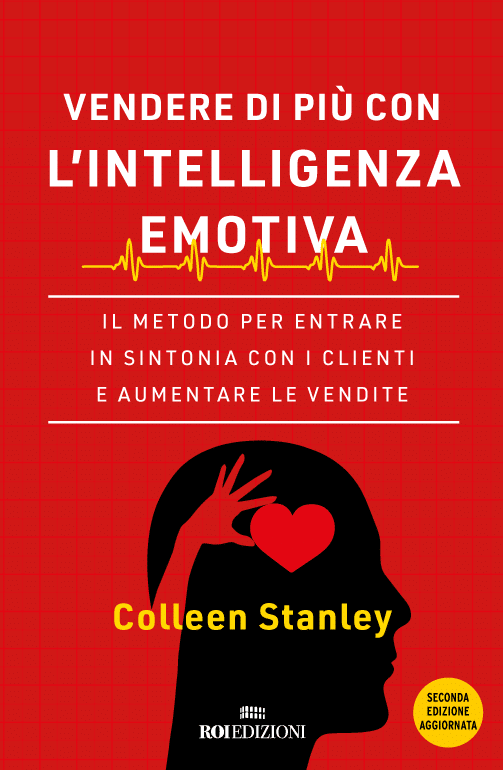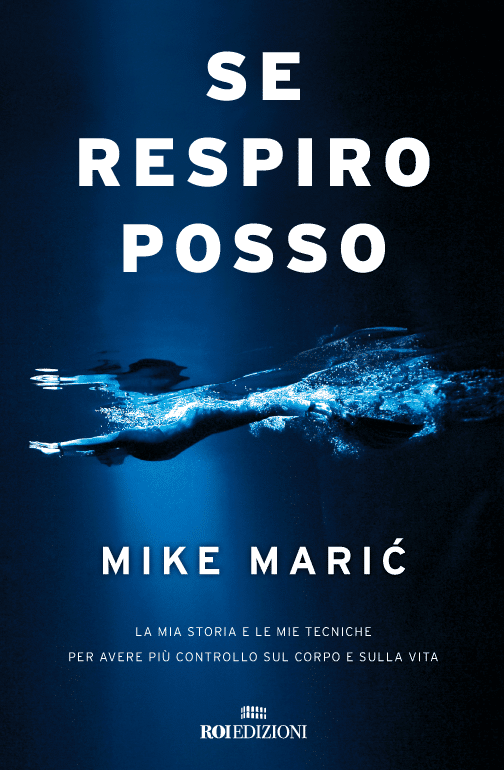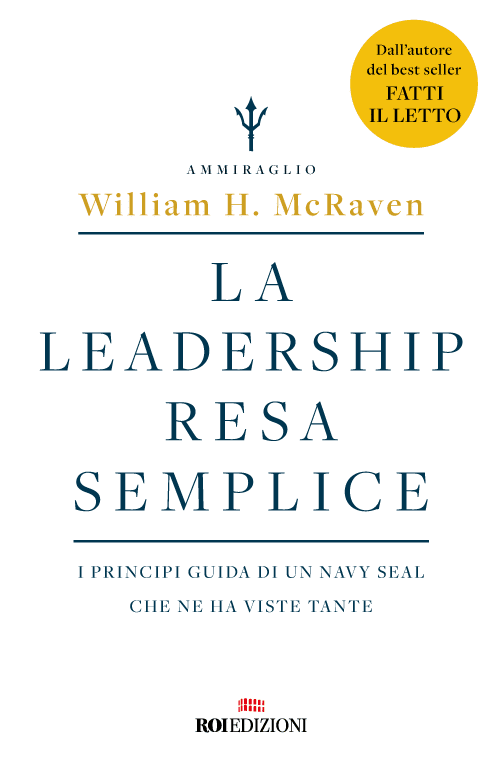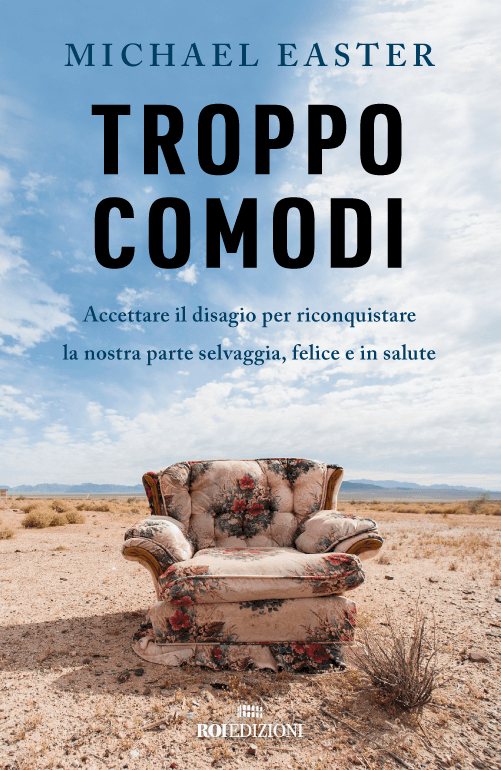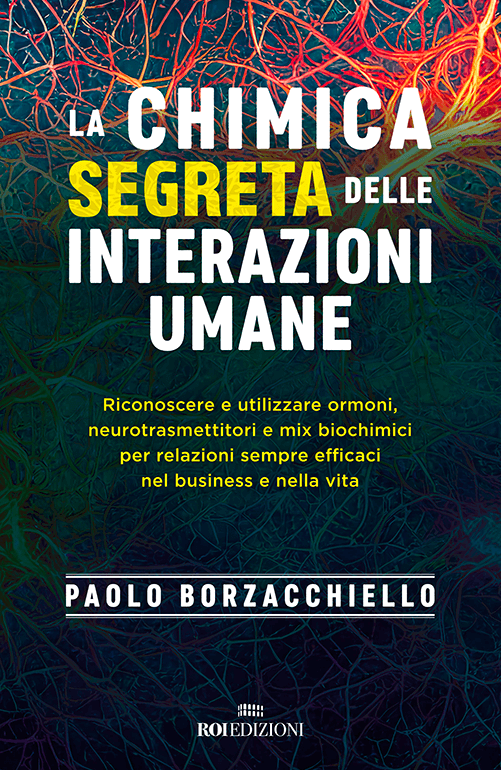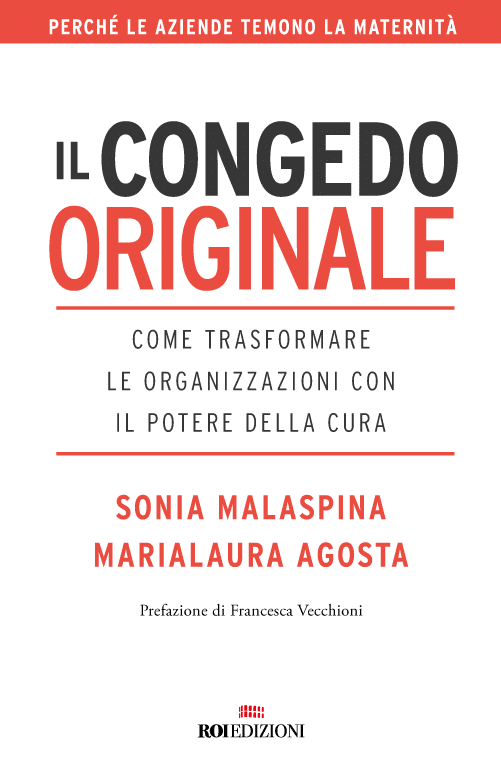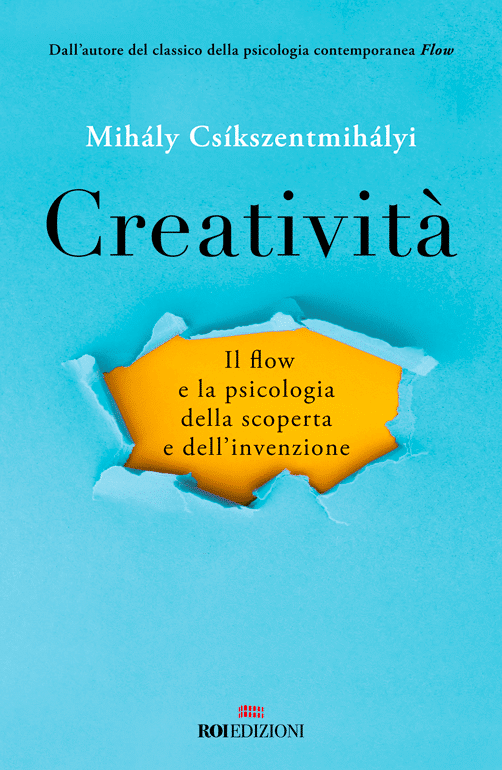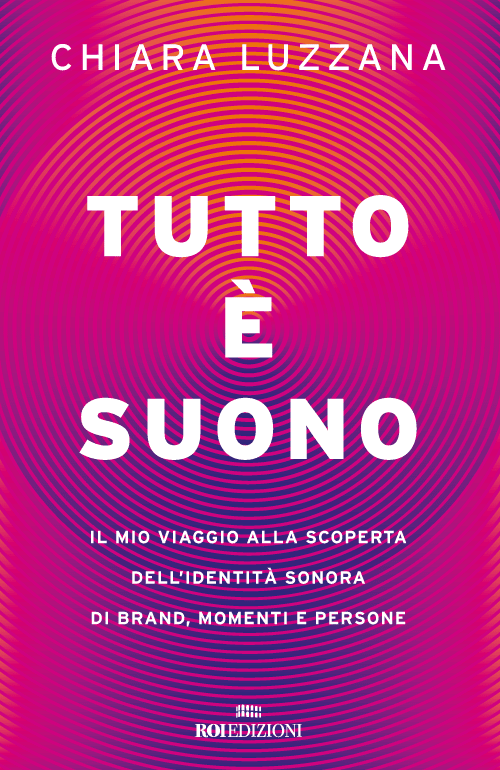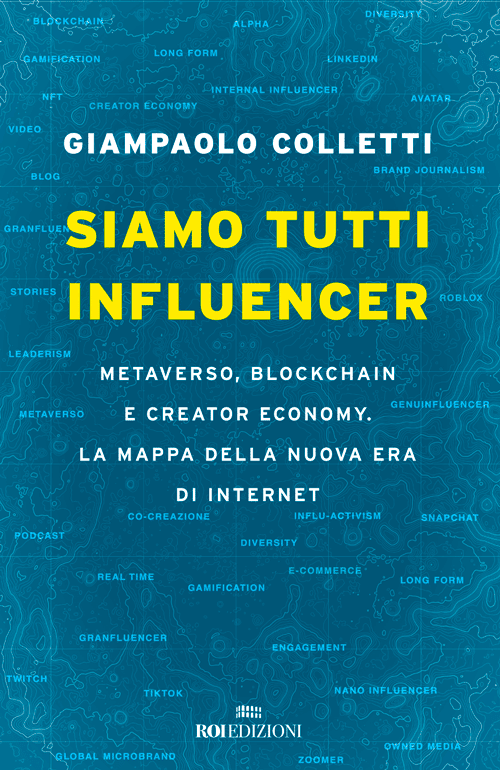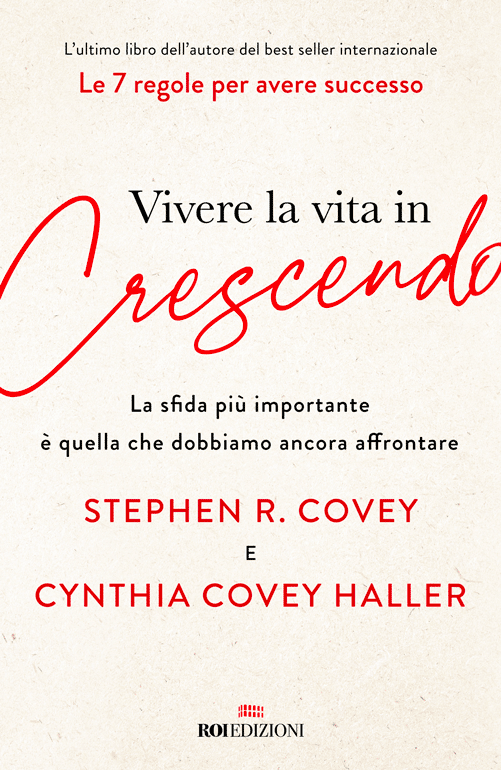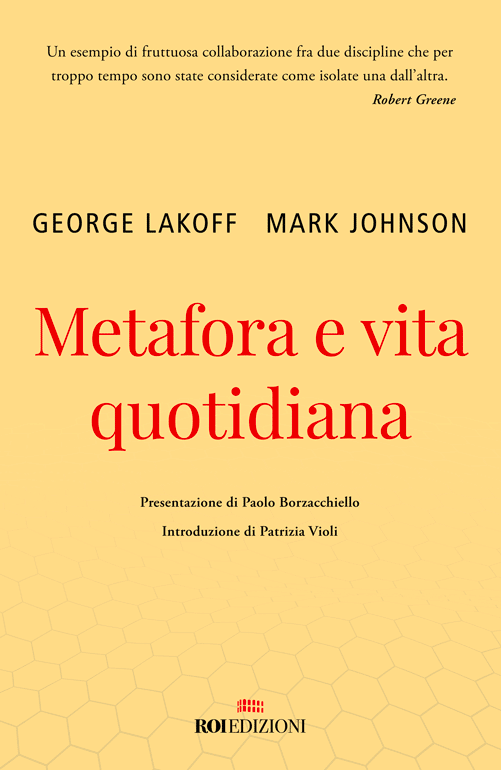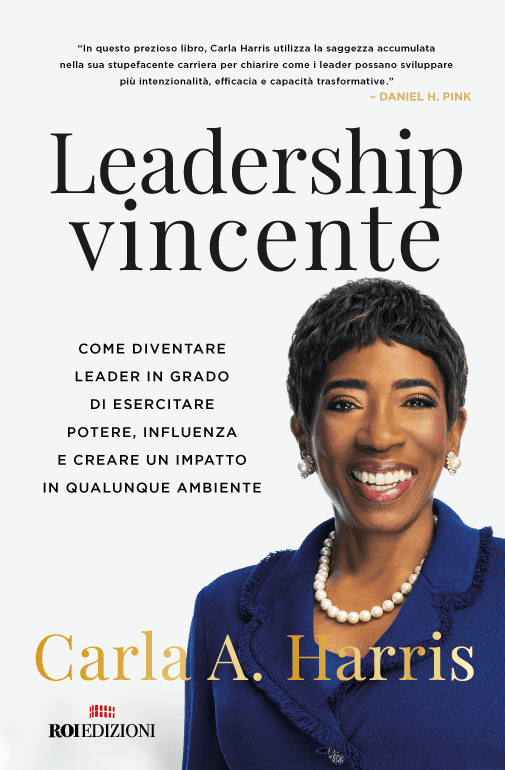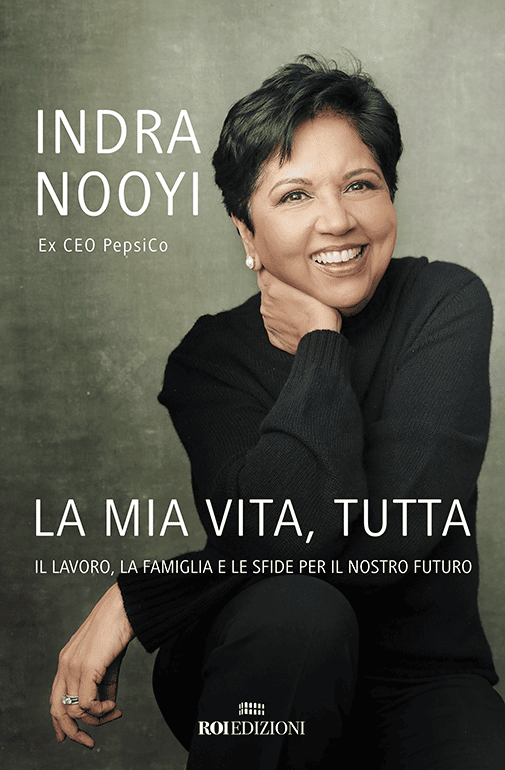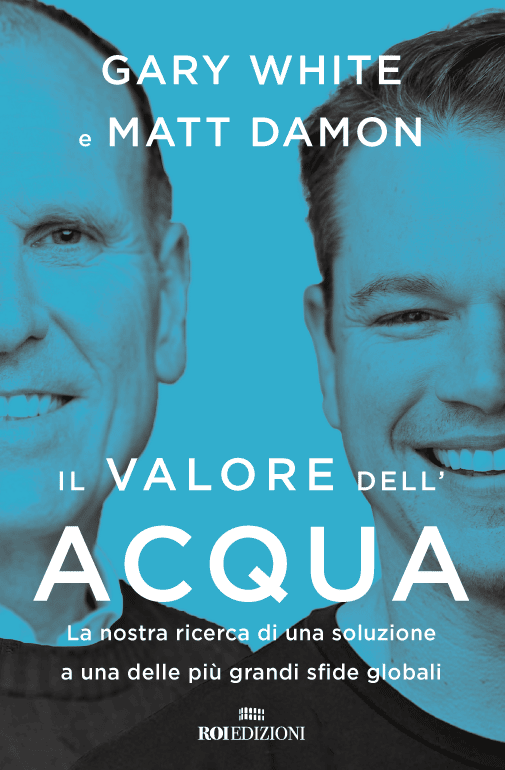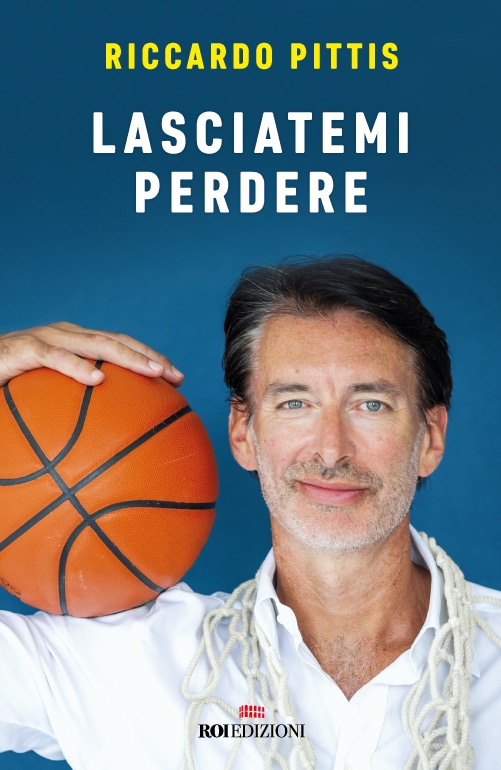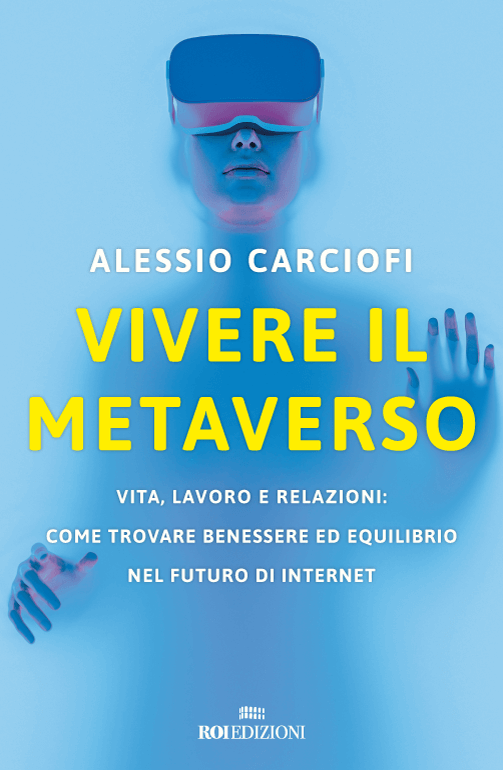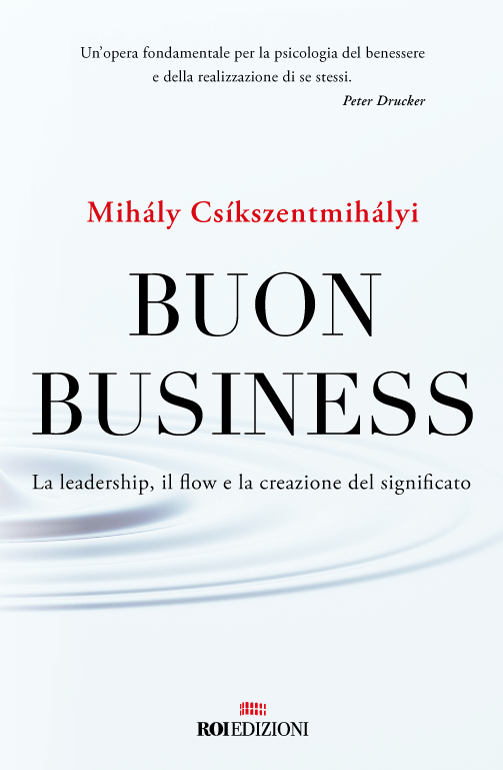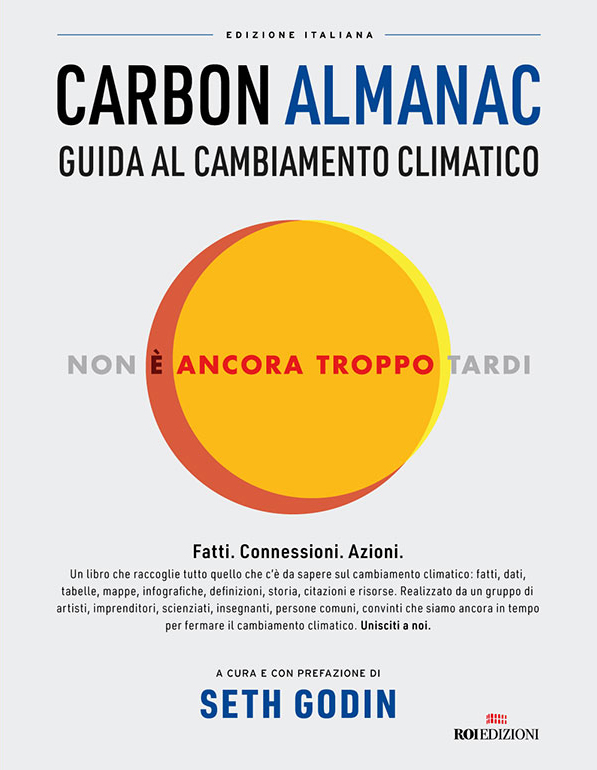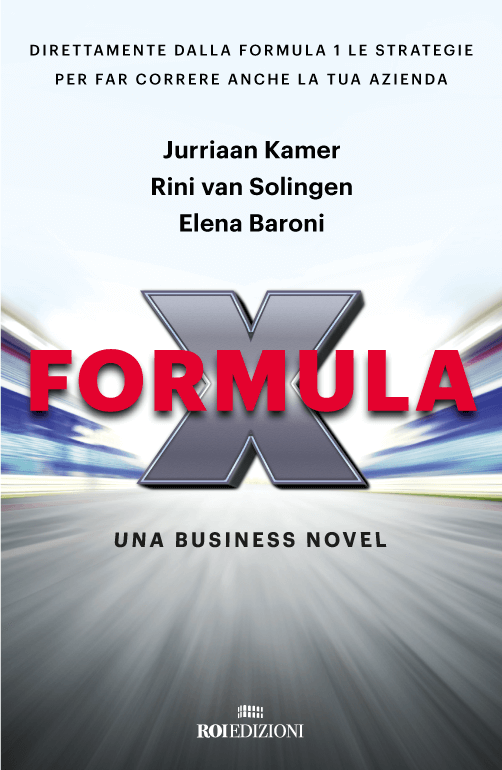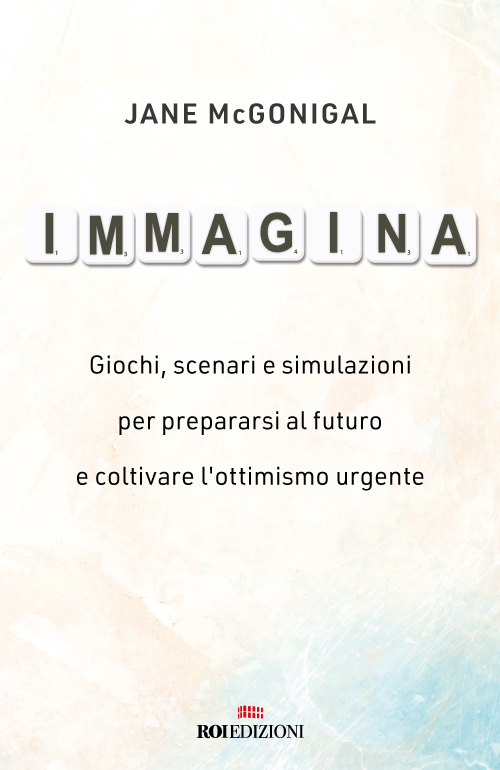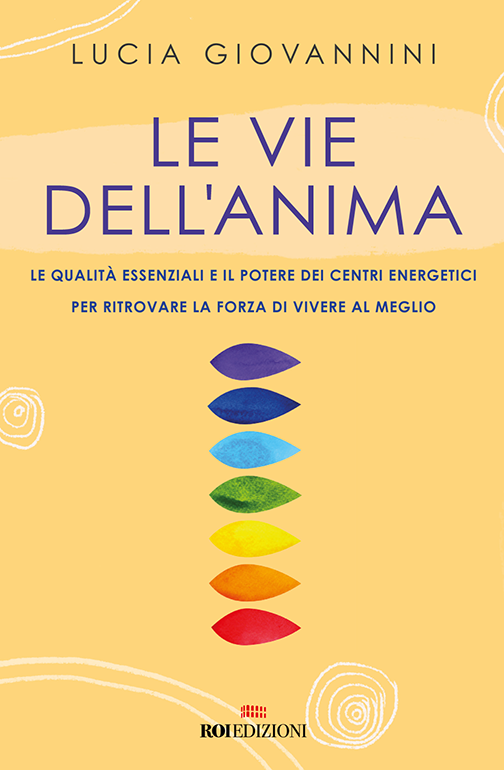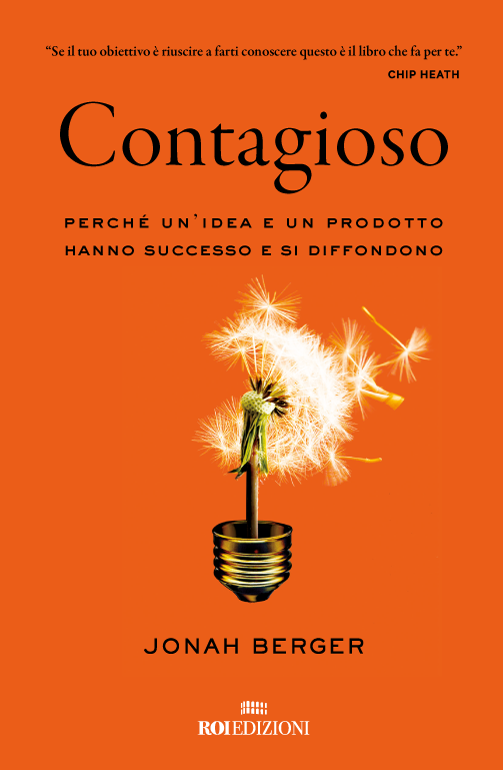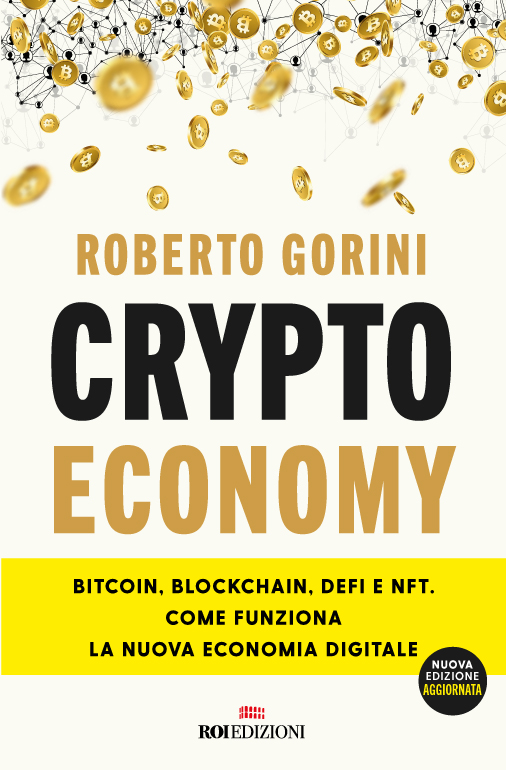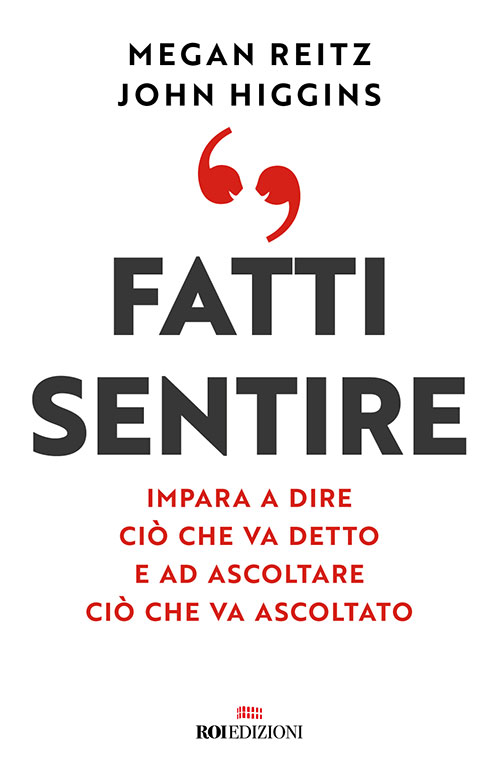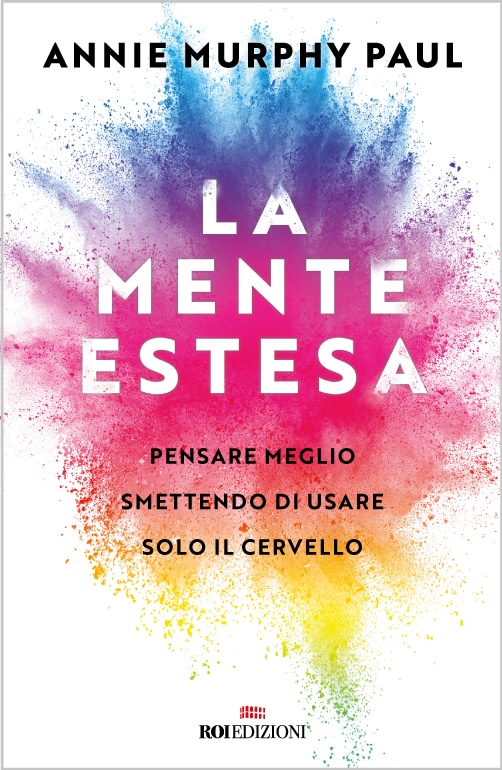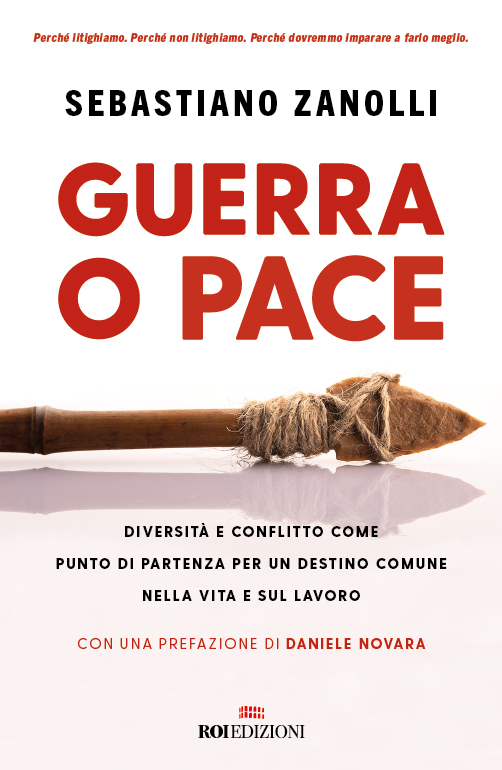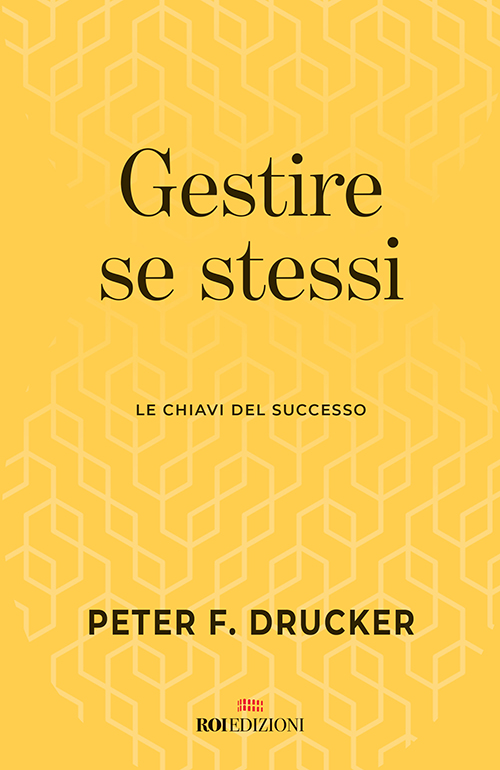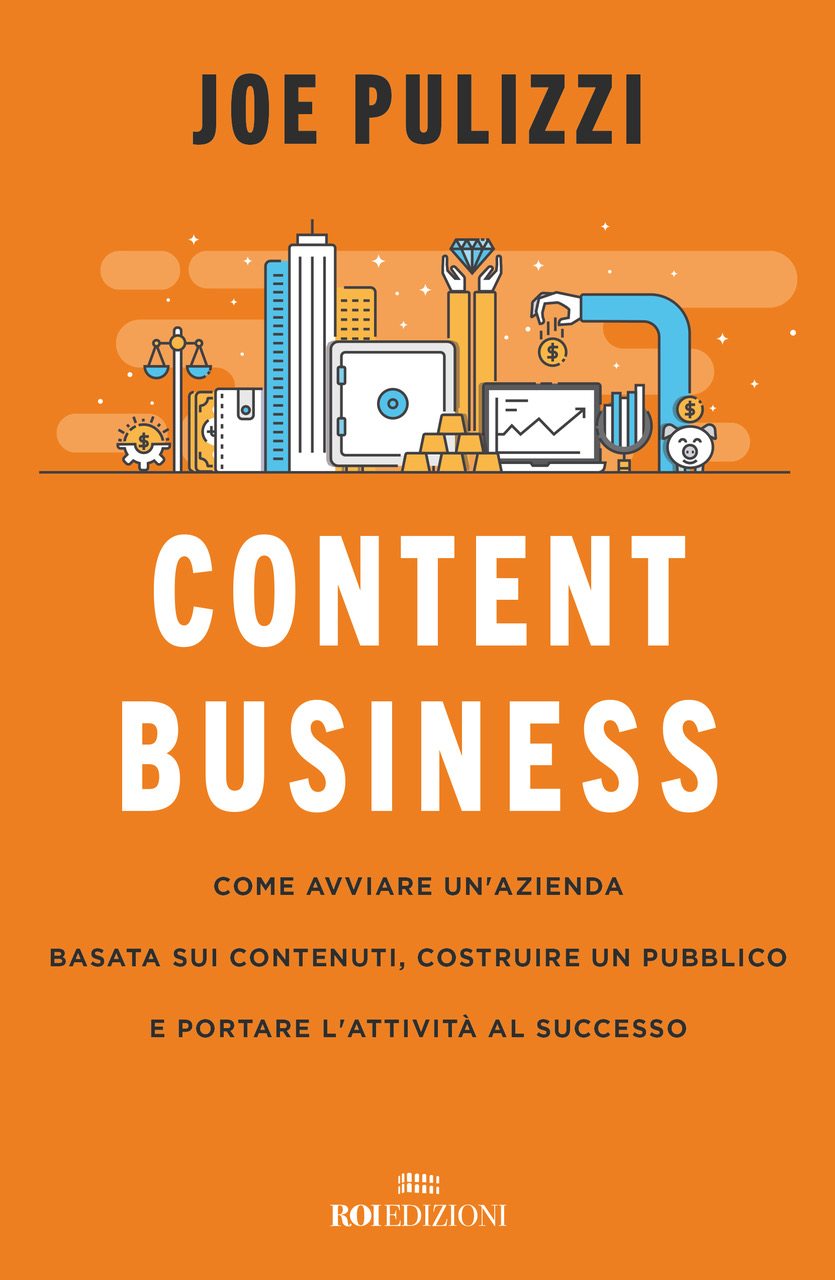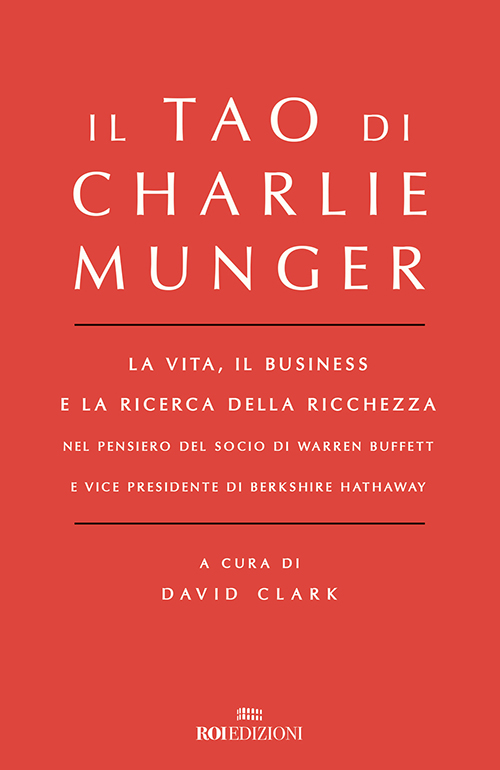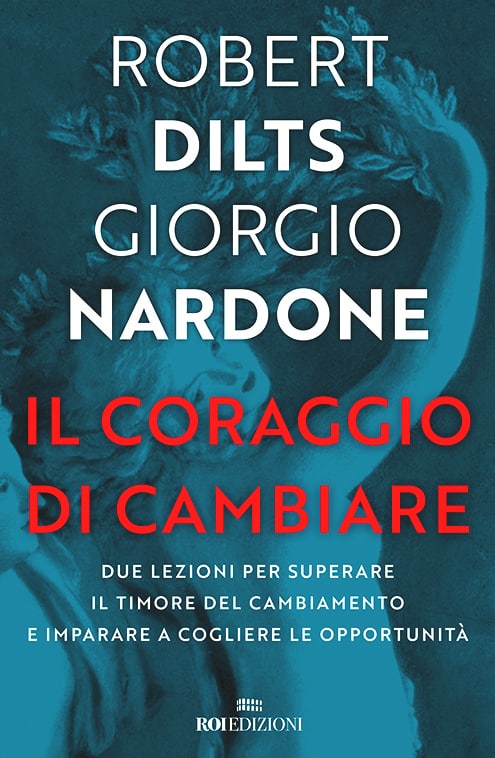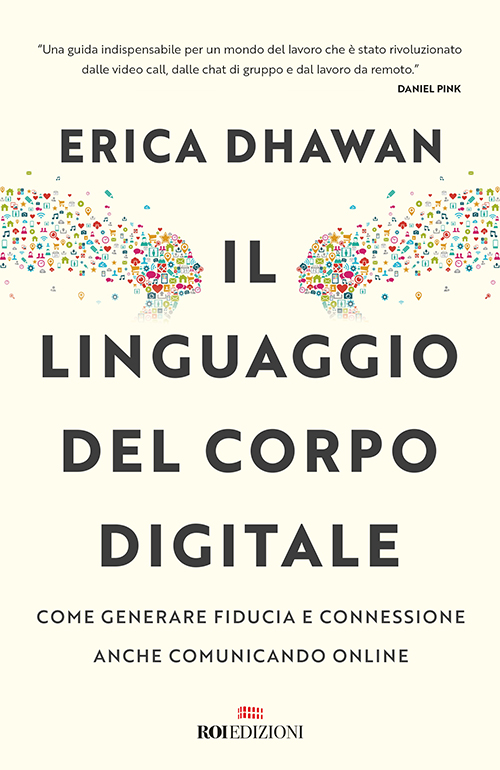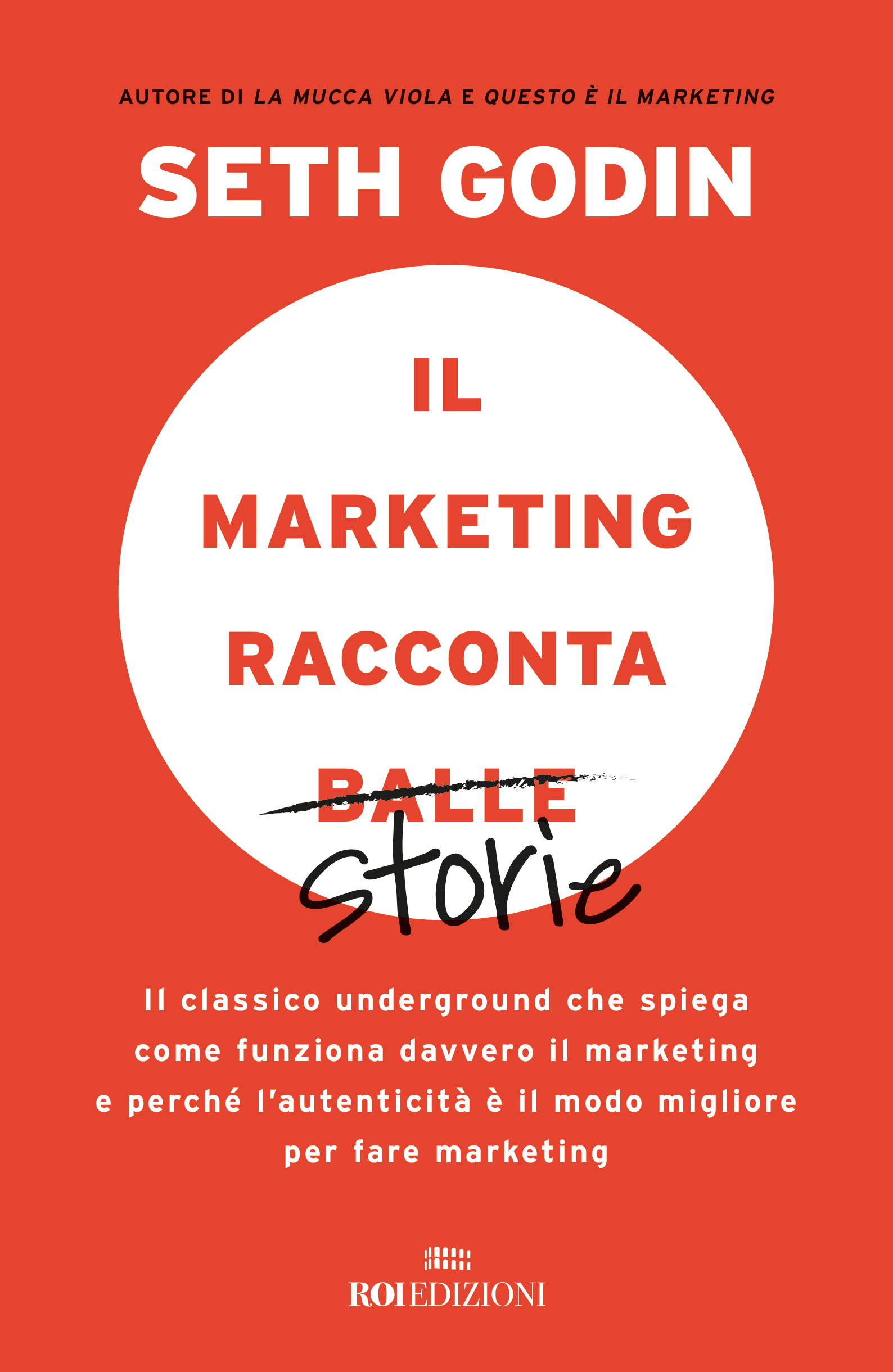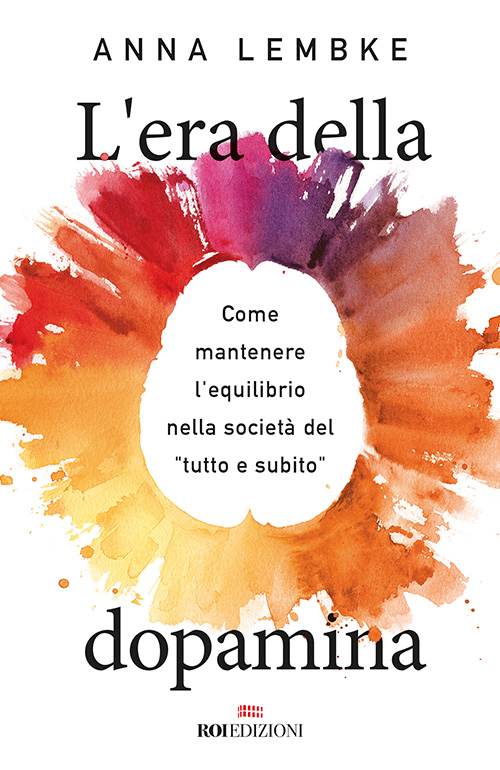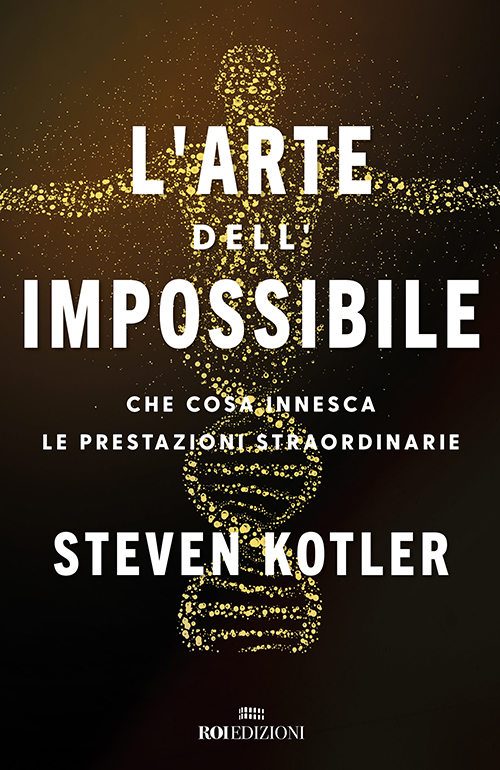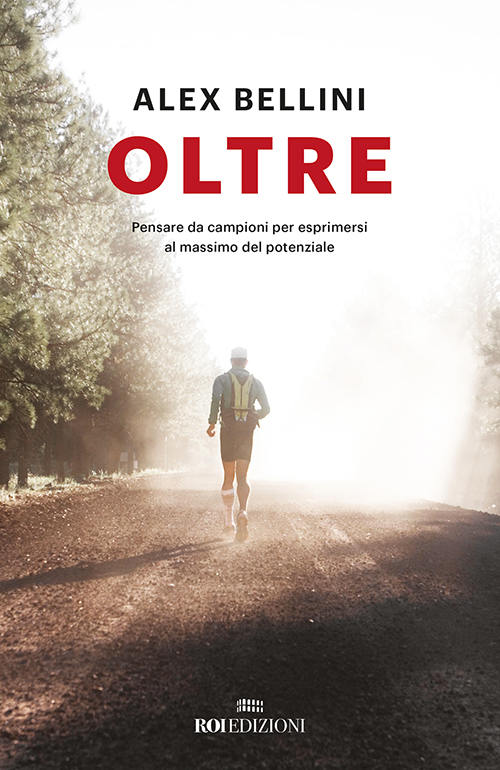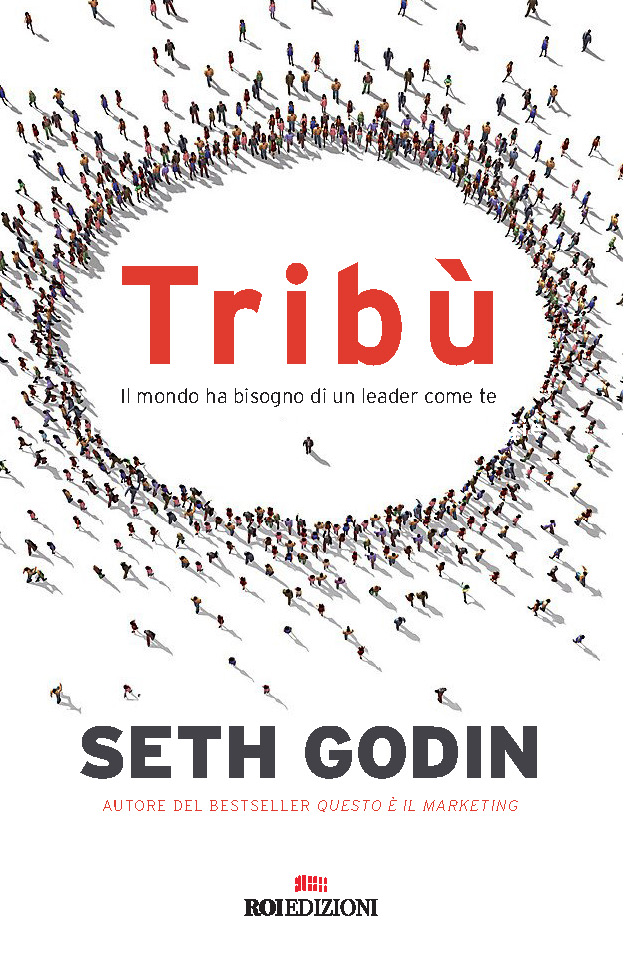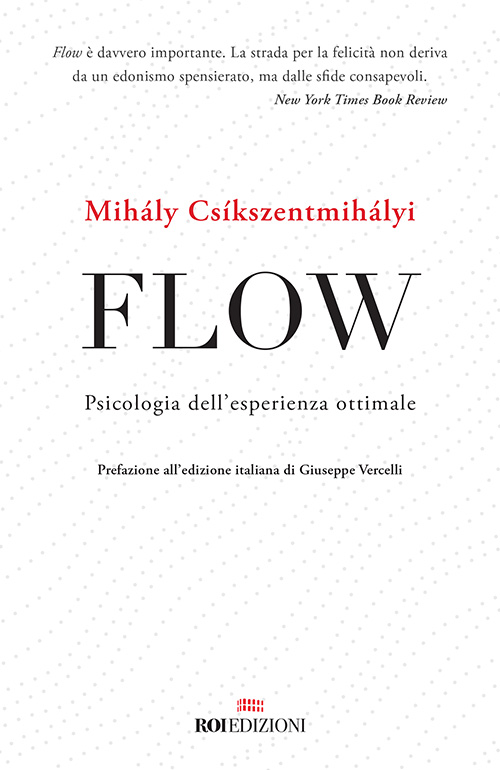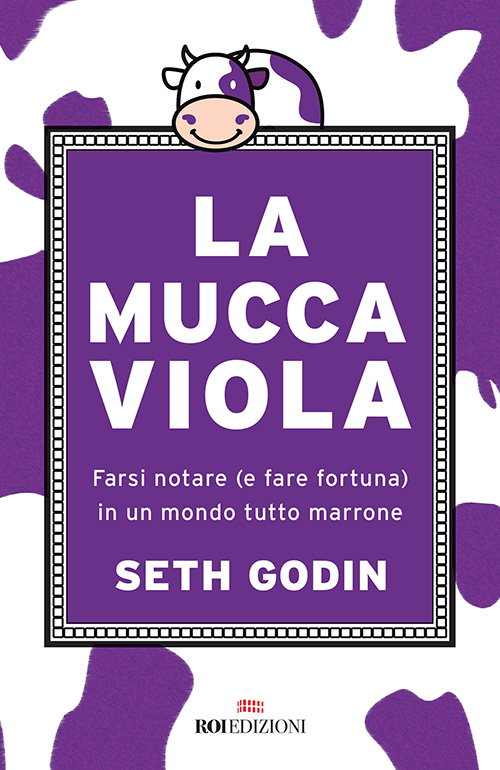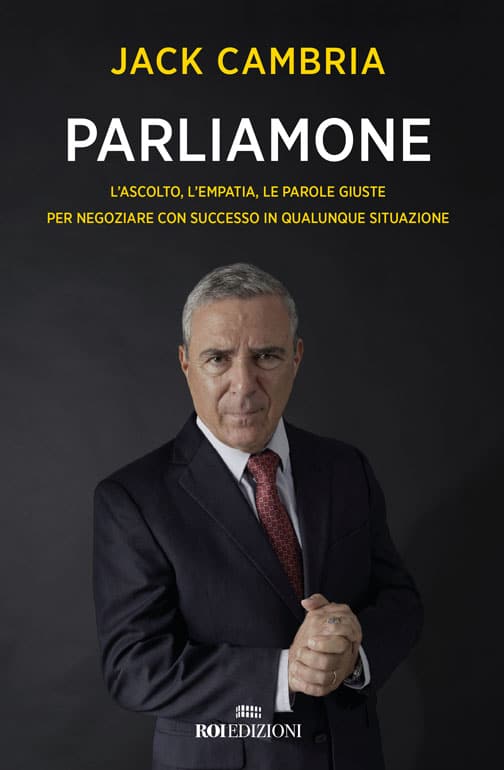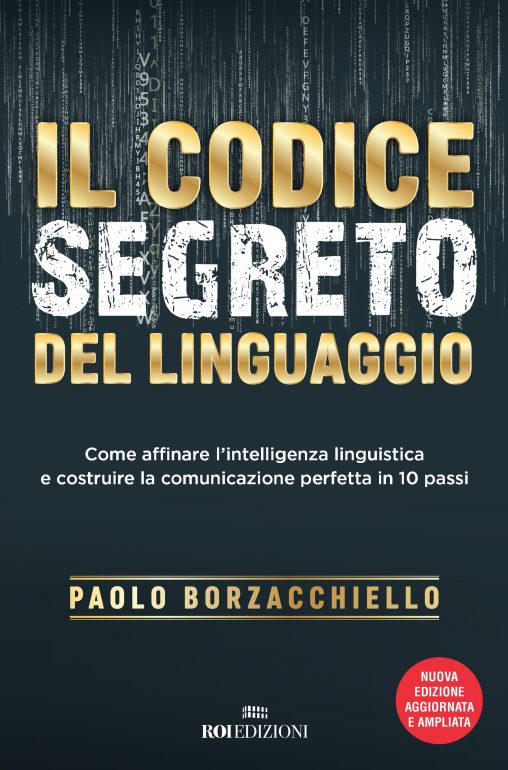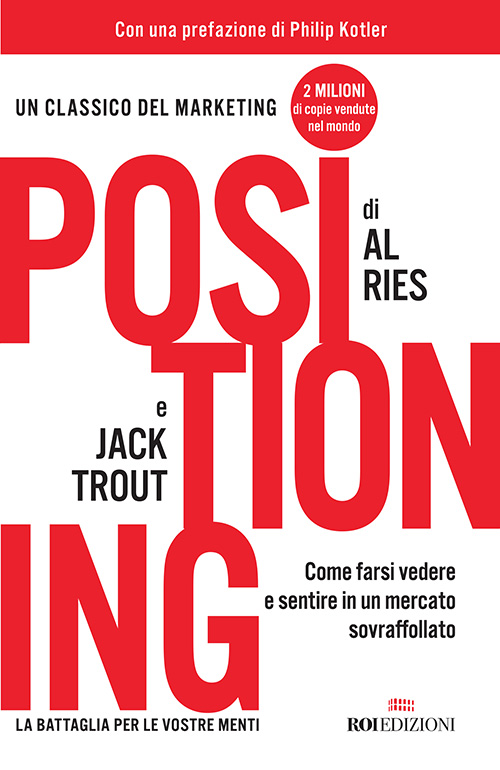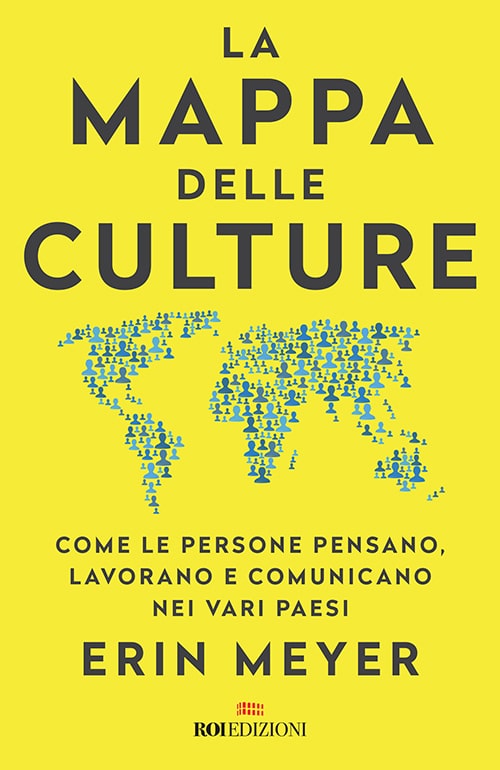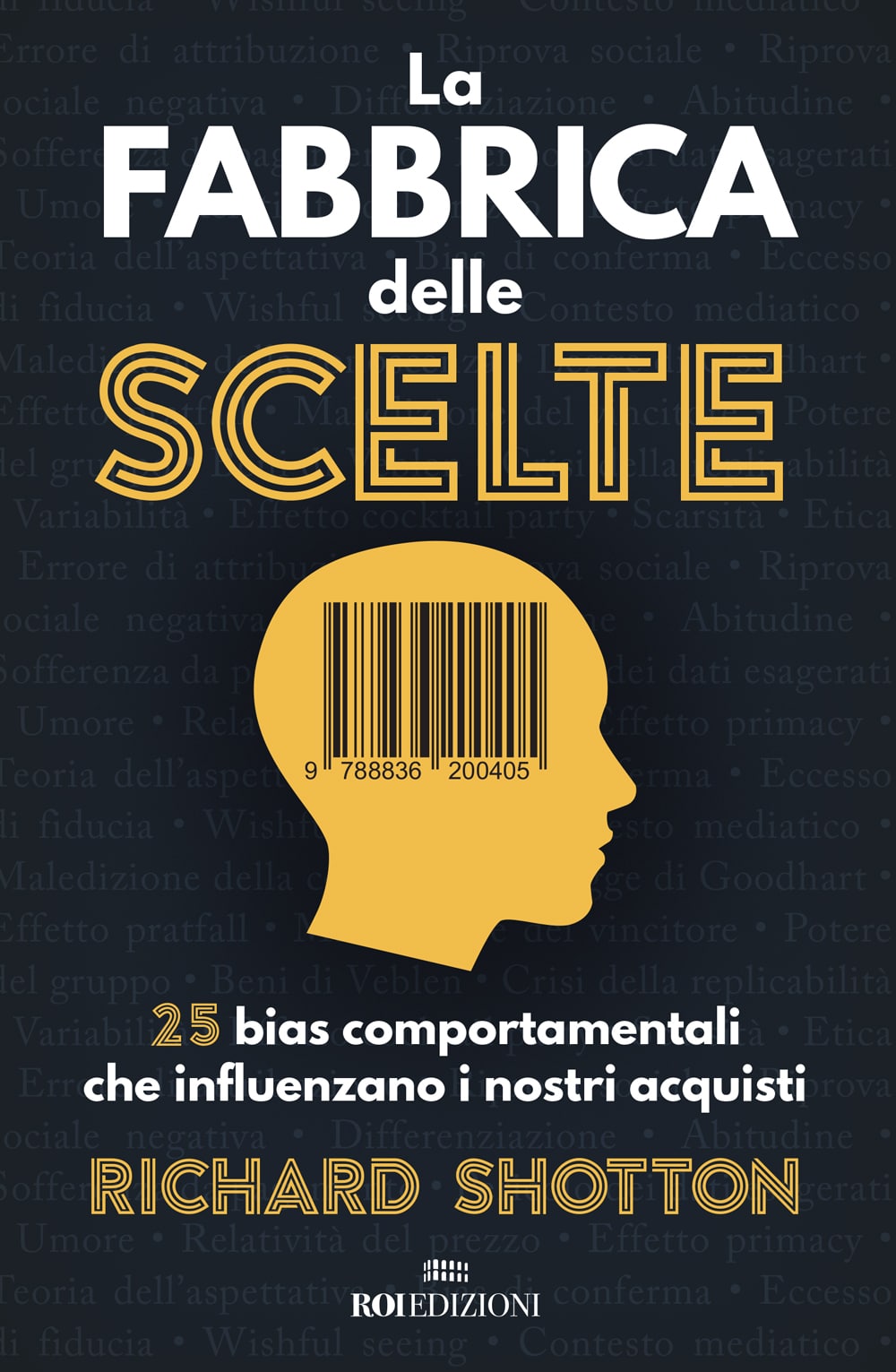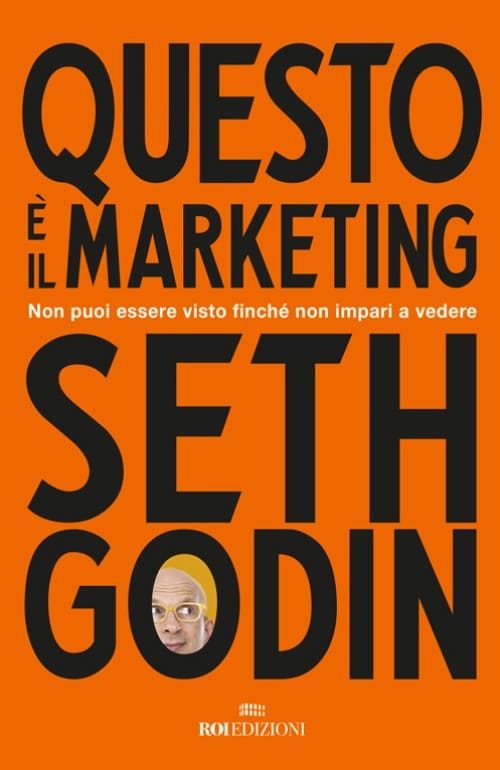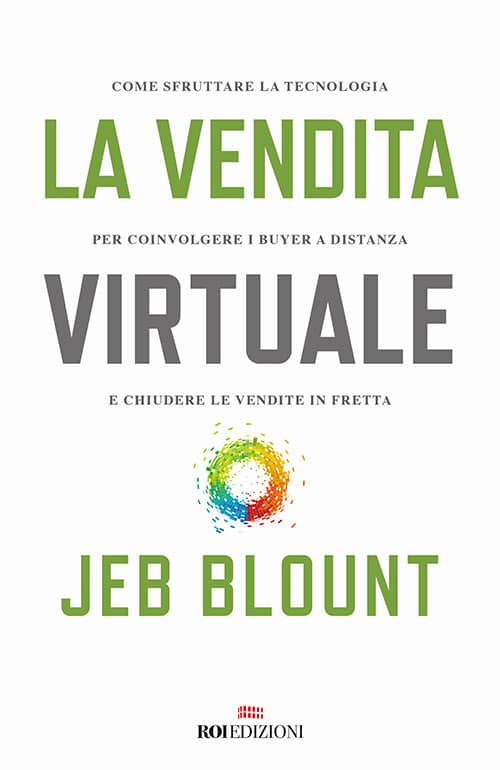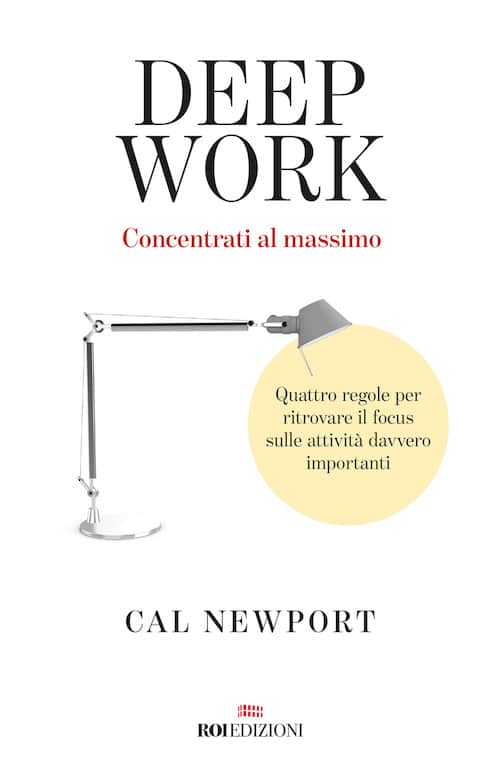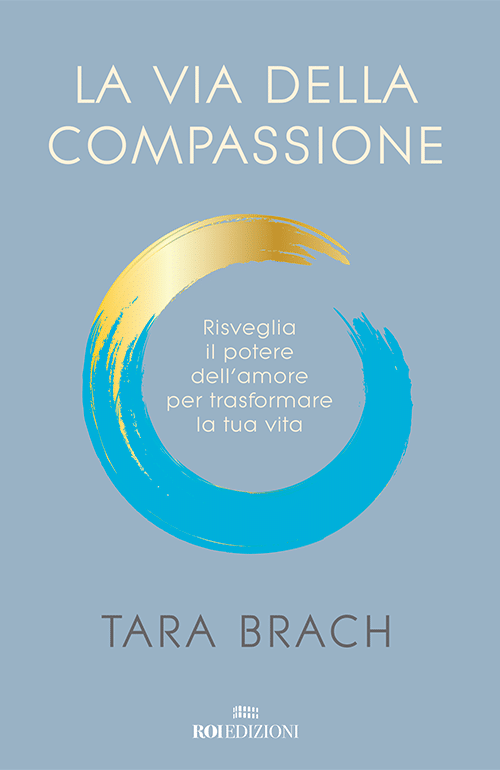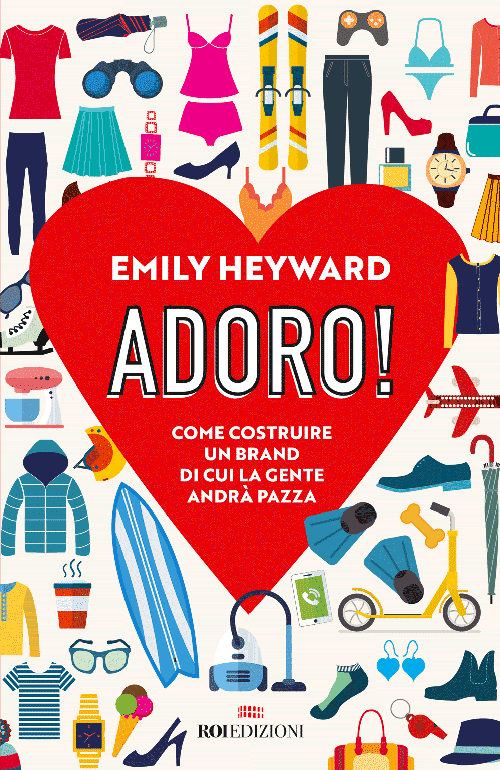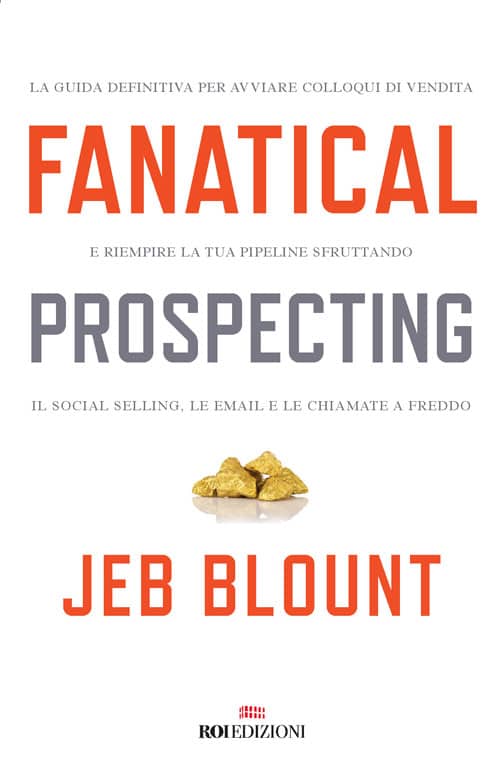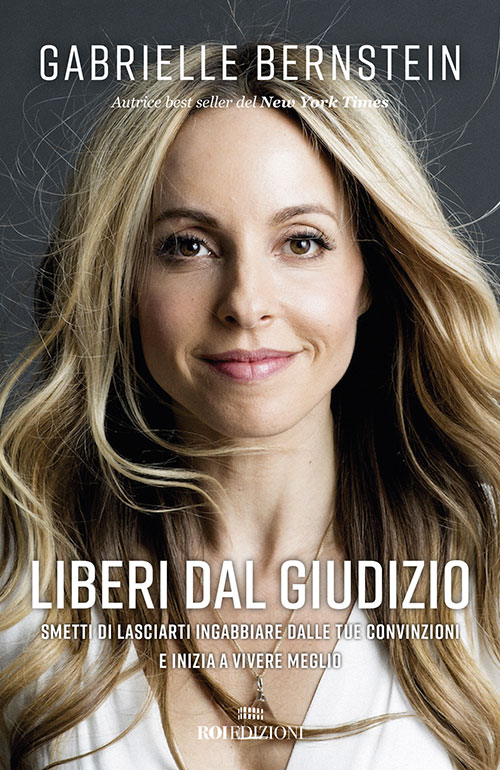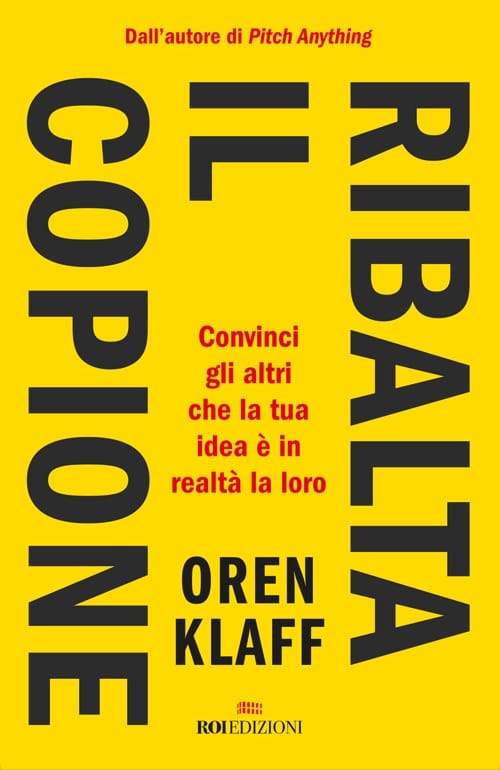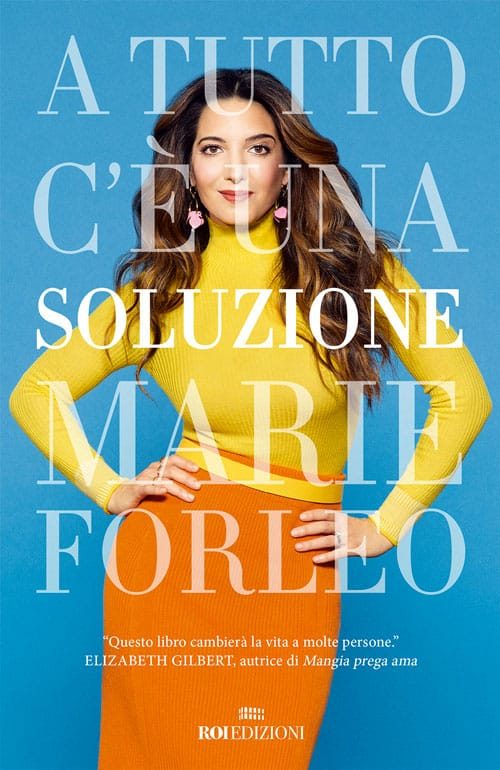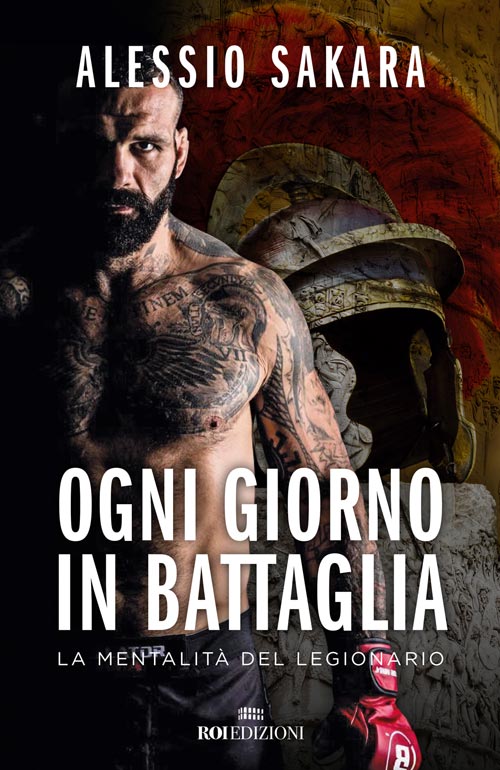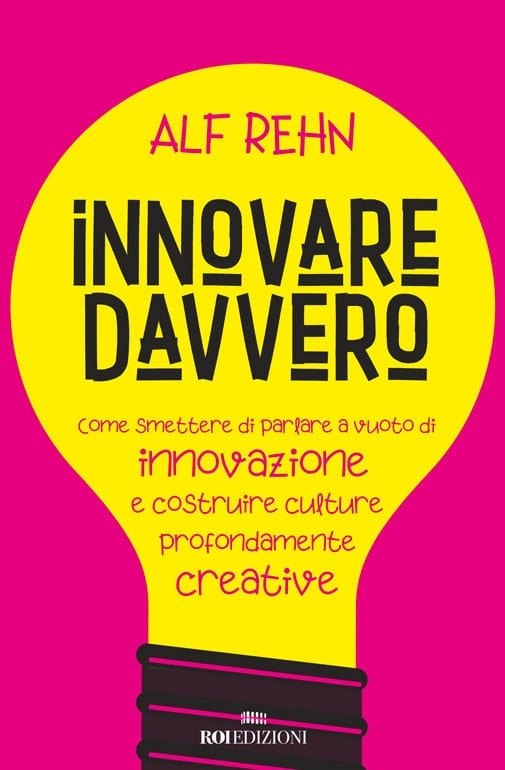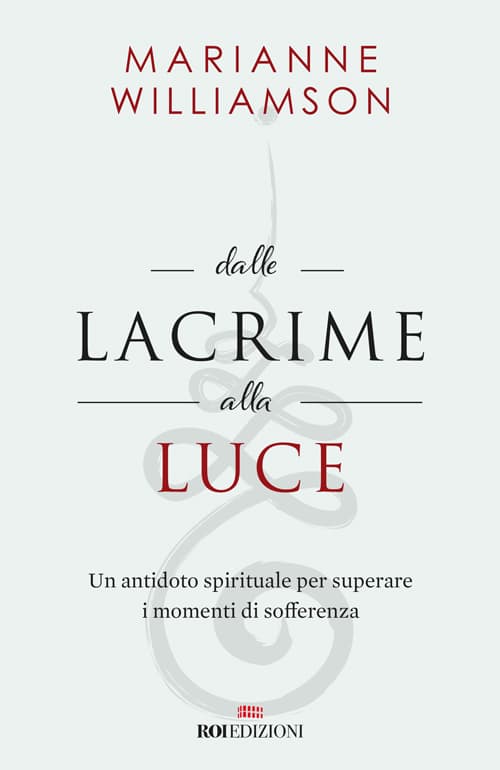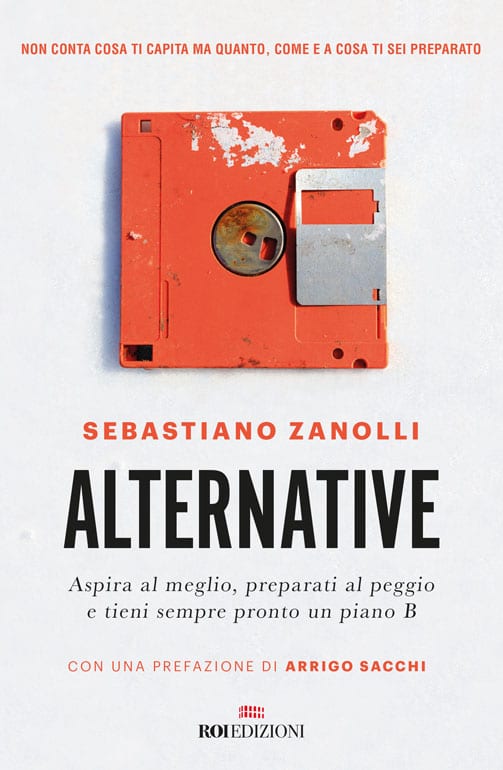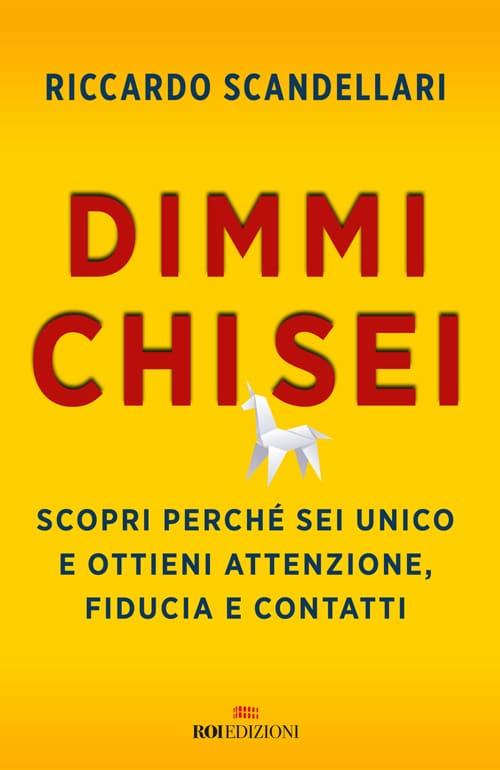Nel 1986, McDonald’s annunciò il progetto di aprire un nuovo enorme ristorante, con oltre 450 posti a sedere, in Piazza di Spagna a Roma, vicino alla scalinata di Trinità dei Monti. Molti italiani non erano contenti. I consiglieri comunali cercarono di bloccare l’apertura, mentre lo stilista Valentino, che aveva un atelier in zona, sosteneva che l’odore degli hamburger avrebbe rovinato i suoi abiti di alta moda. “Quello che ci disturba di più è l’americanizzazione della nostra vita”, denunciò il regista Luciano De Crescenzo.
Il sindaco organizzò una squadra speciale di netturbini per dare la caccia agli involucri di hamburger vaganti che, secondo lui, avrebbero presto riempito le strade.
In questo contesto, un attivista e giornalista di lunga esperienza di nome Carlo Petrini lanciò un nuovo movimento che chiamò Slow Food. Un manifesto ne definiva gli obiettivi:
Contro coloro, e sono i più, che confondono l’efficienza con la frenesia, proponiamo il vaccino di una adeguata porzione di piaceri sensuali assicurati, da praticarsi in lento e prolungato godimento. Opportunamente, inizieremo dalla cucina, con lo Slow Food. Per sfuggire alla noia del “fast-food”, riscopriamo le ricche varietà e gli aromi delle cucine locali.
In tutta Italia cominciarono a nascere altre sezioni locali di Slow Food. Il gruppo promuoveva pasti lenti, consumati in compagnia, a base di ingredienti locali e di stagione. Dopo un po’ di tempo, il gruppo si è fatto carico di obiettivi affini, come l’introduzione di programmi alimentari a carattere regionale nelle scuole e l’impegno a preservare i cibi tradizionali, come la deliziosa albicocca vesuviana, originaria della Campania, nell’Italia meridionale. Nel 1996, il movimento ha organizzato il primo Salone del Gusto a Torino per sostenere le tradizioni alimentari e gli artigiani locali. L’evento, che si tiene ogni due anni, attira oggi oltre 200.000 visitatori che possono degustare i prodotti di oltre 1.500 bancarelle. Oggi esistono sezioni di Slow Food in 160 paesi.